Nino Pedretti, Poesie- Con un saggio di Giuseppina Di Leo-Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA

Nino Pedretti, Poesie- Con un saggio di Giuseppina Di Leo
Nino Pedretti, Giovanni Maria, detto Nino. – Nacque a Santarcangelo di Romagna, il 13 agosto 1923, da Luigi Renato, impiegato comunale noto in paese come cultore di archeologia (sue ricerche del 1936 diedero impulso alla scoperta delle grotte di Santarcangelo) e studioso di storia locale, e da Maria Cola, insegnante di scuola elementare. Trascorse l’infanzia nella casa di via del Tavernello.
da Al Vòuṣi (1975)
Al chèṣi ad campagna
Sbriṣédi da la róspa
maṣèdi dri i garagg
al chèṣi ad campagna
agli à finéi.
I li smana pr’e’ mònd:
i ébi ti ẓardéin
al dvanaróli in mòstra
te salòt.
Dalvólti t’a li vèid
maṣèdi sòtta i cópp,
cmè pavaiòti;
ch’u li zirca i marchènt
par fè d’i albérgh.
Le case di campagna. Sbriciolate dalle ruspe │ nascoste dietro i garage│ le case di campagna │ hanno i giorni contati. │ Le smembrano a pezzetti: │ le vasche di sasso │ nei giardini │ e gli arcolai in mostra │ nel salotto. │ A volte le scorgi │ nascoste sotto i tetti │ come farfalle │ che i mercanti le cercano │ per farne degli alberghi.
I ẓugh
Pòsta che tótt
poeti e nò poeti
a sém te bèl d’l’inféran
u s piṣ a fè di ẓugh
ch’I daga aria.
Mè me mi bidèl
a i dégh ch’u m daga i metar:
déu, tréi, quatar e stènta.
E néun al savém
s’èl ch’e’ vu déi
e’ vó dí mèrda.
Acsè a la matéina
a éintar ti mi pan
cmè t’un scafandar
ch’a vagh ad che pòzz nir
ch’l’è la mi bènca.
I giuochi. Poiché tutti │ poeti e non poeti │ stiamo nel mezzo dell’inferno │ ci piace fare i giuochi │ che un po’ muovono l’aria. │ Al mio bidello │ io chiedo di darmi le misure: │ due, tre, quattro e settanta. │ E noi sappiamo │ che significa, │ significa merda. │ Così la mattina │ entro nei miei panni │ come dentro uno scafandro │ e scendo in quel pozzo di sterco │ che è la mia banca.
La pavunzéla
Mè u m piṣ e’ pasaròt
che quand ch’e’ nèiva
e’ ven tònda ma chèṣa
a saltaréll.
U m piṣ la zèlga
e’ tòurd, e’ culumbazz
e e’ meral stéid ad nir
se su bèch zal.
E u m piṣ e’ varẓléin
ch’l’è pu un burdlín
ad préima elementèra
ch’u s’vólta sempra indrí
par ciacarè.
E una massa u m piṣ e’ rusignul
ch’e’ chènta cumè un rè
tla su varẓéura,
e sinènca e’ stouran pastrouciòun
ch’e’ scaramaza,
mò piò ad tótt
u m piṣ la pavunzéla
ch’la caméina a pass lóngh
cumé una sgnòura.
La pavoncella. A me piace il passero │ che quando nevica │ si avvicina alla casa saltellando. │ E mi piacciono la cincia │ il tordo, il colombaccio │ e il merlo tutto in nero │ col suo becco giallo. │ Mi piace il vergellino │ che è un bambino di prima elementare │ sempre voltato indietro │ a chiacchierare. │ E molto mi piace il rosignolo │ che canta come un re │ chiuso tra il verde; │ e amo persino lo storno fracassone │ ma la mia diletta │ è la pavoncella │ che cammina con passo lungo │ come una signora.
L’òm dal putèni
Léu tla su véita
féina i zinquént’an
u n éva pansè mai
ad mètt so chèṣa.
E stéva te caséin
a lè, bón, a fè i sarvéizi.
«Al putèni – e gévva – sal
n’è te su lavòur
agli è invurnéidi,
mòsci ti su létt
se mèl ad pènza.
U t tòca fè pianín
s’t’vó fè l’amòur
quandè c’al dórma.
E pu, la sèira, mè
a i fazz e’ bagn.
Fa e’ còpp, fa e’ còpp
a i dégh dalvólti
in módi che l’acqua
la i córra zò bén
te mèẓ dla schéina».
L’uomo delle puttane. Lui in vita sua │ fino ai cinquanta │ non aveva pensato mai │ di mettere su casa. │ Stava lì, buono, │ nel casino a fare dei servizi. │ «Le puttane – diceva – se │ non sono impegnate sul lavoro │ sono stordite, │ mosce nel letto │ con il mal di pancia. │ Devi far piano│ se vuoi fare all’amore │ intanto che sono addormentate. │ Poi alla sera │ io faccio loro il bagno. │ Fa il coppo, fa il coppo │ dico delle volte │ in modo che l’acqua │ le corra giù per bene │ nel mezzo della schiena».
Al vòuṣi
Dalvólti da par mè
te lètt, t’un curidéur
t’un treno par Milèn
a sént al vòuṣi.
E alòura a m fazz
piò grand
ch’al sòuna dréinta
ad mè
cumè al campèni.
Le voci. A volte, per conto mio, │ nel letto, in un corridoio, │ in un treno per Milano │ ascolto le voci. │ E allora divento │ più grande │ perché risuonano dentro │ di me │ come campane.
E’ lavadéur
Me lavadéur
al dòni
scavcèdi cmè di
diéval
al sbatéva i pan
cumè dal frósti.
Al scuréva ad travérs
al s’aragnèva
e pu al cantéva insén
e l’éra di rógg d’amòur
cumè dal gati.
Il lavatoio. Al lavatoio │ le donne │ coi capelli scarmigliati come │ diavoli │ picchiavano coi panni │ come fruste. │ Parlavano scurrile │ litigavano │ e poi si mettevano a cantare insieme │ ed erano grida d’amore │ come delle gatte.
La ciòza
La cantéva d’amòur
ma la finestra
la cantéva lòngh, a gòula vérta
e l’éra una vòia ad mas-ci
avnéuda chi lo sa,
da sòtta tèra
so par al gambi, t’i ócc
te fiòur dla pènza.
La cantéva d’amòur:
una zurnèda ch’éurta.
Adés l’è cmè una ciòza
la puléss i burdéll
e la sta zétta.
La chioccia. Cantava d’amore │ alla finestra │ cantava a lungo, a squarciagola │ ed era una voglia di maschio │ venuta chi lo sa │ da sotto terra │ su per le gambe, agli occhi │ al fiore della pancia. │ Cantava per amore │ ed era una giornata corta. │ Ora ha l’aria d’una chioccia │ pulisce i bambini │ e sta in silenzio.
Sesso
Sesso par néun e vléva déi
figa te pógn, scòul,
sburédi tla latréina.
Par néun e vléva déi
la paéura d’l’impregn,
al mói ch’al scapéva de lètt
«Gino, sta bón a m’aracmand»,
senza mai gód, cumè una midizéina.
E pu avemaréi, patérr,
e’ savòun, la praticòuna.
E pansè ch’l’éra acsè dòulz
sal tedeschi te fióm:
a m guardéva cmè déi
«Tóla, tóla, puréin»
e pu al ridéva.
Sesso. Sesso per noi significava │ fica nel pugno, male di scolo │ e vizio di latrina. │ Per noi significava │ terrore di metterle incinte │ la moglie che sfuggiva dal letto │ «Gino, sta buono mi raccomando», │ senza godere mai, come una medicina. │ E poi pianti, preghiere │ sapone, la praticona. │ E pensare che era così spensierato │ farlo giù al fiume con le tedesche: │ mi guardavano come per dire │«Prendila, ragazzo, prendila» │ e poi si mettevano a ridere.
E’ lavòur
«E’ treno e’ pórta véa»
e’ gévva la mi mà
e mè a so andè ẓiréun
par la Germania
in zirca d’un lavòur.
A sémi ch’u l sa l’òs-cia
d’incrécch ad chi vaghéun,
avémi un pansir féss
par tótt e’ viaẓ:
turnè ma chèṣa.
Da par néun, dalòngh,
tra ẓénti furistíri
a s’apuzémi a la mèi
sa cal do trè paróli
cumè chi póri strópi
sòura i su bastéun.
«Ferstehen, ferstehen, polizai»
e lòu i s’guardéva cmè déi:
«Mo quést, da dòu ch’i vén».
Il lavoro. «Il treno porta via lontano» │ diceva mia mamma │ e io in Germania sono andato │ in cerca di lavoro. │ Eravamo una folla │ compressi nei vagoni │ e solo un pensiero │ in tutto il viaggio: │ tornare a casa. │ Soli, lontano │ fra genti forestiere │ ci appoggiavamo alla meglio │ sopra quelle due o tre parole │ come poveri zoppi │ sopra il bastone. │ «Ferstehen, ferstehen, polizai» │ e loro ci guardavano come a dire: │ «Ma questi, da dove vengono?».
Se la lèngua la mòr
Se la lèngua la mòr
se la s’invléna,
se la pérd i parént
cum una vèdva,
se la piénz da par sé
spléida te còr di vécc
tal chèṣi zighi,
alòura e’ paèis l’è andè
u n’à piò stòria.
Se la lingua muore. Se la lingua muore │ se si contamina, │se perde i suoi legami │come una vedova, │se piange in disparte │sepolta nel cuore dei vecchi │nelle case buie, │allora il paese è finito, │non ha più storia.
da Te fugh de mi paèiṣ (1977)
Dedica
Dòni ch’avéi tla bòcca un góst
cumé ad faréina gréiṣa
dòni criscéudi te scéur
cumé un pèn ad fadéiga
dòni de vént e de méur
dòni dla biènca róṣa de sònn
dòni dla brèṣa
dòni ch’avéi cuṣei ti dè
sta mi parlèda antéiga
dòni l’è sòtta e’ vòst zil ch’l’è nèd
tòtt sta fiuréida strèna.
Dedica. Donne che avete in bocca un gusto │ di acida farina │ donne cresciute al buio │ come pane di fatica │ donne del vento e del muro │ donne della bianca rosa del sonno │ donne di brace │ donne che avete cucito i giorni │ della mia parlata antica │ donne è sotto il vostro cielo │ che è nata questa mia fiorita.
La nèiva
Stasèira
ò vòia d’arcurdè
l’udòur dla nèiva
e al préim fróffli
inzèrti te zil
cumé di gazótt furistìr
ch’ì vén ènca da néun.
La neve. Stasera │ mi punge un ricordo: │ l’odore della neve. │E i primi fiocchi │incerti nel cielo │come uccelli forestieri │giunti anche da noi.
Ulisse
Ulisse, un chèn
l’avéva caminé par tótt al strédi
e l’éra avnéu a muréi
t’l’invéran dla su véita.
E adès l’éra e’ mònd
ch’u i scapéva véa
ti su pan ad luce.
Ulisse. Ulisse, un cane │ ramingo per il mondo │ era venuto a morire │ nel colmo del suo inverno. │ Ed ora eran le strade │ che gli correvan via │ in abiti di luce.
Al poeṣéi
Ò scrétt zinquènta poeṣéi par un léibar
zinquènta galéini biènchi te curtéil
e a li guèrd cumè una cuntadéina
che sàbat la li pórta me marchè.
Le poesie. Ho scritto cinquanta poesie per un libro │ cinquanta galline bianche nel cortile │ e le guardo come una contadina │ che sabato le porterà al mercato.
La matéina prèst
A m’arcórd la matéina se cafè
l’udòur di tréni, la nèbia
d’in èlt datònda al chèṣi
e’ sònn ch’e’ pastruciéva s’l’aria
e i ruméur dal curiri
sal pènzi pini ad studént
e e’ sòul ch’lavnéva so pianín
alzènd al brazi e la caméisa
rossa de dè
te zil ch’l’aveva frèdd
ancòura par la nòta.
La mattina presto. Ricordo la mattina col caffè │ l’odore dei treni, la nebbia │ in alto attorno alle case │ e il sonno che si impastava con l’aria │ e il rumore delle corriere │ gremite di studenti │ e il sole si alzava piano │ alzando le braccia e la camicia │ rossa del giorno │ nel cielo ancora infreddolito │ per la notte.
Paróli
A vagh scarabuciand
pruvénd sla vòuṣa
paróli vèci d’un témp
ch’al gévva ad dòni te d’agócc
ch’al mè pasi pianín
sòtta la pèla
e al m’à fiuréi
te sangh, sòtta i cavéll.
Paróli ch’agli à durméi
par an sòtta la zèndra
e adès a tir fura
me fugh de mi paèiṣ.
Parole. Vado scarabocchiando │ provando con la voce │ parole vecchie d’un tempo │ che le donne pronunciavano lavorando a maglia │ che mi sono passate piano piano │ sotto la pelle │ e mi sono fiorite │ nel sangue, sotto i capelli. │ Parole che hanno dormito │ per anni sotto la cenere │ e ora tiro fuori │ al fuoco del mio paese.
*****

LE VOCI DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA NELLA POESIA DIALETTALE DI NINO PEDRETTI*
Il 30 maggio 1981, all’età di 58 anni, veniva a mancare il poeta Nino Pedretti[1], «insegnante e glottologo, che nasce poeta in lingua e muore poeta in dialetto»[2], una delle voci più importanti della poesia dialettale romagnola.
Nino (Giovanni Maria) Pedretti (Santarcangelo di Romagna 1923 – Rimini 1981) faceva parte della generazione dei poeti «nati negli anni ‘20» (Asor Rosa), compagno di strada nonché fraterno amico di Tonino Guerra e Raffaello Baldini, «il singolare terzetto dei poeti di Santarcangelo di Romagna» (Isella)[3].
Il silenzio nel quale sembrava esser stata reclusa la memoria del poeta dopo la sua morte è stato rotto negli ultimi anni grazie alla scrupolosa ricerca che la studiosa Manuela Ricci ha condotto sia sulle carte private – conservate a Pesaro dalla famiglia[4] sia su quelle conservate nel fondo “Archivio Nino Pedretti” presso la Biblioteca Comunale di Santarcangelo di Romagna e nel fondo del padre Luigi Renato, conservato presso la Biblioteca Gambalunga, dove sono state rinvenute le poesie giovanili inedite pubblicate poi (non tutte) nel volume Le pepite d’oro, edito da Raffaelli[5]. Nel 2007, col titolo Al vòusi, e altre poesie in dialetto romagnolo, l’Einaudi pubblicava l’intera produzione dialettale edita di Nino Pedretti: l’opera prima Al vòusi, e le successive raccolte, Te fugh de mi paèis e La chesa de témp. L’edizione era arricchita dalla cura di Manuela Ricci, da una nota di Dante Isella e da uno scritto di Raffaello Baldini.
L’approccio di Nino Pedretti al dialetto è avvenuto non da subito: il contesto familiare (la madre insegnante e il padre non santarcangiolese di origine, scrittore e appassionato di storia locale) gli aveva permesso di potersi esprimere solo ed esclusivamente in italiano; il dialetto, documenta Raffaello Baldini, «lo imparò dagli amici giocando prima a palline e poi a pallone. Ma se per i molti altri della sua generazione il dialetto era, come si dice, la lingua materna, per Nino direi che era la lingua fraterna»[6].
Nell’immediato dopoguerra in Santarcangelo si assiste all’avvio di un’«avventura culturale» (Miro Gori) che andrà sotto il nome di E’ Circal de giudéizi («Il Circolo del giudizio»). Si trattò di un tentativo culturale, passato poi alla storia sotto questo nome per via dell’appellativo che bonariamente qualche compaesano rivolgeva a quel gruppo di giovani intellettuali – “Ve là, e’ circal de giudéizi” – che si riuniva sotto i portici del “Caffè Trieste” per discutere i più svariati temi culturali ed artistici (letteratura, cinema, arte, musica), insieme a quelli politici e sociali, e dove Pedretti avrà modo di esprimere il suo talento poetico e musicale[7].
Nel clima culturale di quegli anni, a partire dal 1946, il poeta santarcangiolese ottiene premi e riconoscimenti nazionali per poesie inedite in lingua, confluite in maggior parte nel volume Gli uomini sono strade[8].
Intorno alla metà degli anni Cinquanta Nino Pedretti parte per la Germania dove trova un impiego e perfeziona la lingua tedesca. In un carteggio con Rina Macrelli emerge, insieme al gusto per la novità verso una città da scoprire (Francoforte), anche una “leggera” «nostalgia»[9] per il paese e per gli amici.
In quello stesso torno di tempo, dopo il rientro in Italia, Pedretti unisce alla carriera di insegnante anche l’attività di traduttore. Se, come abbiamo detto, l’approccio al dialetto è subentrato presumibilmente in età adolescenziale, il passaggio successivo nella formazione poetica di Nino Pedretti, quello della scrittura in dialetto, risale al periodo immediatamente dopo il ’68; un passaggio cruciale in cui egli si fa portavoce degli emarginati e dei “diseredati”, di coloro che, non avendo un ruolo “attivo” nelle vicende della storia di quegli anni, rischiavano di restarne fuori: «Per parlare a loro nome bisognava parlare come loro: in dialetto. E così Nino cominciò a scrivere in dialetto» (Baldini)[10].
Ma, prima ancora che poeta dialettale, Nino Pedretti è valente studioso di questioni linguistiche: «già nel 1967 aveva frequentato un corso di fonologia a Edimburgo; nel 1972 ebbe l’incarico del coordinamento della Commissione docente nei corsi abilitanti per l’area linguistica; nel 1975 l’Università di Urbino gli affidò l’insegnamento di Glottodidattica nella Scuola di perfezionamento»[11].
A seguito dell’indagine linguistica e fonologica, durata diversi mesi, condotta col romanista Friedrich Schürr, Pedretti nota ancor più chiaramente, insieme alle molteplici potenzialità poetiche offerte dal dialetto, anche i limiti in cui esso era costretto. Si trattava cioè di far uscire il santarcangiolese dalle secche dell’«oralità», «per portare, trascinandolo alla legittimità della scrittura, il dialetto nel futuro»: una «scommessa» sulla quale punta anche l’amico Raffaello Baldini.
L’occasione per parlare delle «voci della poesia del dopoguerra» è fornita dal Seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale romagnola[12], tenutosi a Santarcangelo nel giugno del 1973 (l’anno prima era stato pubblicato I bu, di Guerra), in cui il nostro, sotto l’impulso di Tonino Guerra, accetta l’incarico di organizzare l’evento in collaborazione con Rina Macrelli.
Il tema sul dialetto resterà per Pedretti un discorso aperto che egli riprenderà a più riprese, fino al suo ultimo libro.
Il passaggio dalla fase di studio del dialetto alla produzione poetica vernacolare è breve.
Poeta «per necessità» (Bo), Nino si propone al pubblico nel 1975 con Al vòusi, perspicuo già nel titolo (‘le voci’), con il quale sembra dare volto alle voci registrate su nastro magnetico nel corso dell’indagine fono-linguistica. I temi trattati per parlare dei purétt sono espressi utilizzando la «lingua brutale» del sotto-proletariato e del proletariato, in una sorta di esperimento linguistico come testimonianza della loro condizione di sofferenza, fisica e morale. Tra rabbia, dolore, disperazione ma, anche, ironia, nella «nota allegra» del gusto di vivere, nella trivialità del sesso a buon mercato, un popolo di sconosciuti – giocatori, prostitute, infermieri, vecchi, matti, barbieri e lavandaie, per non citarne che alcuni – emerge come dal nulla reclamando diritto di identità. L’attenzione al dialetto copre, scopre e scorre dovunque creando qua e là specchi di vera poesia, come in Se la lèngua la mòr (Se la lingua muore).
In quei primi anni Settanta nasce «quella cosa» (Baldini) che andrà sotto il nome di «poesia neodialettale». La poesia in dialetto, ritenuta fino ad allora «ancillare o eccentrica», comunque minoritaria rispetto alla poesia in lingua, acquista dunque dignità di «lingua-poesia» (Pasolini), avviandosi dai piani «bassi ai piani alti» (Sereni). Se in Al vòusi, la poesia in dialetto di Pedretti «ha trovato da sé l’allineamento alle forme elette e alle esperienze della poesia in lingua […] è da notare come in tutta la poesia di Pedretti lo scarto tra originale e versione non è poi così forte, non tale almeno da ottundere l’incisività dell’impianto e la sicurezza di fondo»[13].
Per certi aspetti, Te fugh de mi paèis svolge un ruolo paritetico ad Al vòusi, cambiandone però la prospettiva, nel senso, come in altro modo precisa Pedretti, che le immagini non sono rivolte ‘verso’ il mondo ma esse provengono ‘dal’ mondo, nate da un’aria perduta e germogliate «nell’io profondo dove risuonava una meraviglia nutrita di dialetto». Così, mentre i versi di Al vòusi ricordavano la miseria del pane e recavano un’ansia di riscatto, in Te fugh de mi paèis lo sguardo si fa interiore, come ricerca della bellezza scomparsa, soffermandosi su tutto ciò che è in pericolo di scomparire, piante e animali inclusi:
Ecco, gli animali, mi sembra siano i più esposti, così come i deboli e gli emarginati, alla violenza e al male di vivere. Ogni giorno scompare una specie di volatile, di mammifero, di pesce. Pensare agli animali s’accomuna al sentimento di precarietà in cui da sempre, ma soprattutto oggi, viviamo.
La chèsa de temp (La casa del tempo), rappresenta l’ultima fatica di Pedretti, uscito alle stampe qualche mese dopo la sua morte «grazie alla fraterna cura di Raffaello Baldini» (Ricci). E, come il protagonista del monologo, Il racconto perduto, anche Nino sembra voler dire: «Così come Ulisse posso lanciare le mie pietre contro l’immenso gigante del tempo senza che nessuno se ne avveda». [14]
L’universo letterario di Nino, lo abbiamo visto, si compone di voci, di storie reali e fantastiche al tempo stesso, di paesaggi, oggetti quotidiani, di luce e di silenzi. Anzi, la luce predomina fino a farsi ossimoricamente «luce nira» (Linfoma).
La sua attenzione verso il mondo rimane costante (E’ mònd l’è una palìna ch’la s’incrépa) ed egli si fa partecipe della natura come in questi ultimi versi di Al nóvvli (Le nuvole): «nóvvli a n’e’ savéi che dréinta / a purté quèll di mi nónn / che adès l’è dvént / un udòur d’un pórt, / chissà, d’una furèsta». («nuvole non lo sapete che dentro / portate il mio fiato / e forse quello dei miei nonni / che adesso è diventato / un odore di porto, / chissà, d’una foresta»); la realtà si confonde con l’immaginazione e la fantasia torna a farsi sogno come in questi versi de La pasegièda (La passeggiata), che riporto in lingua: «e lì dove un tempo / chissà mai quali signori / portavano dentro le carrozze / tra siepi di rose, lì / vado guardando perché un cortile / mi faccia vedere attorno ad una statua / una fontana che sogna / d’avere dei capelli: o dei cavalli / davanti un portone verde / fuori dal tempo, come in una pittura»; gli oggetti raccontano storie di vita in un gioco di luci (come in I vasétt) e di ombre (come in E’ pióv, Piove: «Piove, di fuori il mondo / è pieno di bianco / di un’aria di cenere dolce / come di gigli. / La mia vecchia casa / si è fasciata di ombre: / i miei morti sono lì / che stanno seduti»).
Verrebbe da chiedersi, cos’è che fa soffermare l’attenzione del poeta su ciò che sta al limite tra interno ed esterno, al margine della realtà, ai bordi di un mondo? Una risposta potrebbe essere trovata nella ricerca che Pedretti ha condotto da sempre contro il gioco delle apparenze laddove, ad esempio, se un tetto di canne può significare l’inizio e consentire alla fantasia di andare oltre, al tempo stesso quella linea rappresenta punto ad limina di uno spazio privato dove allo sguardo soltanto è consentito addentrarsi per coglierne, per un attimo, il nucleo “intimo” attraverso la mediazione della parola (La pórta). Allo stesso modo, se da una parte troviamo le varietà legate a uno o più elementi eterei o solari del giorno e del sogno, dall’altra, un microcosmo di oggetti ci porta più vicino la gente e il vasto popolo di compaesani, di parenti e amici che hanno fatta propria la memoria di quegli oggetti, di un intero universo ineluttabilmente destinato a perdersi: «Dietro questa poesia c’è un tempo immemorabile che non ha mai avuto voce e qui sta la prima ragione del poeta Pedretti, immettere nel coro della poesia illustre un materiale di vita che stava per venire cancellato per sempre» (Bo).
In Dmanda (Domanda) leggiamo: «Duv’è ch’a s masarà / al poeséi ch’a n so bón ‘d scréiv / ch’a gli zarchédi tént / ch’l’è quèlli ch’a m pis ad piò / ch’a n li pòs lèz / gnénca se desideri?», («Dove si nasconderanno / le poesie che non sono capace di scrivere, / che ho cercato tanto, / che sono quelle che amo di più, / che non posso leggere / neanche col desiderio?».
Alla Dmanda si potrebbe rispondere che forse si sono nascoste in tutte le poesie da lui effettivamente scritte, visibili solo a chi sa guardare oltre le parole; che sono racchiuse nella conchiglia (La cunchéa), nelle piante strane di una stazione (La staziòun), nella bottiglina piena di aria verde (La bucìna), tra le ruotine dei bottoni nella scatola dei ditali (Tla scatla di didèl).
In La chèsa de temp il tempo è l’artefice, l’arciere pronto a scoccare l’ultimo dardo-attimo di silenzio, subissando ogni voce, totalizzante e privativo, uguale a sé soltanto quando entra dappertutto, come nella splendida E’ silénzi (Il silenzio).
Mi scriveva Nino nell’agosto del 1980: «La poesia si fa con tutto il corpo e non solo coi sentimenti. Voglio dire che il corpo e tutto quello che lo muove diventa poroso, filtra, lascia passare odori di cose. Gli occhi, le mani, il ventre, l’arcata del petto sono investiti da questo vento che ci scuote, che ci fa partorire i sogni».
Giuseppina Di Leo
[1] Il presente studio sull’opera del poeta dialettale Nino Pedretti riprende in parte un mio precedente lavoro già pubblicato su: «Incroci. Semestrale di Letteratura e altre scritture, diretta da Raffaele Nigro e Lino Angiuli, n. 20, Mario Adda Editore, luglio-dicembre 2009», 149-153; “Voci dal Novecento”, a cura di Ivan Pozzoni, vol. III, Limina Mentis Editore 2012.
[2] G. MIRO GORI, E’ circal de giudéizi; Santarcangelo di Romagna nell’esperienza culturale del secondo dopoguerra. Catalogo della mostra: cinema e televisione, Santarcangelo di Romagna, 16 dic. 2000 – 7 genn. 2001, Clueb, Bologna 2000, 13.
[3] R. BALDINI, La nàiva. Versi in dialetto romagnolo. Introduzione di Dante Isella, Einaudi, Torino, 1982, V.
[4] Tra gli inediti conservati nell’Archivio Lina Pedretti Conti, Oggi ho alzato le mie bandiere, autografo, una poesia di cui, tra le carte del poeta, si conserva anche una successiva redazione, «una poesia in seguito ripresa col titolo In risposta all’accusa circa una mia pretesa povertà. Chi sono, non pubblicata. Sorta di autoritratto poetico di Pedretti: «Io sono ricco / perché porto con me / le acque verdi dell’Isar / e gli archi dei suoi grandi ponti. / Nessuno può dire che sono povero / perché ho visto splendere / gli alberi di melo vicino alla tua casa / che tu non conosci. / Io sono forte / perché ho alzato le mie bandiere / e fatto festa, oggi, un giovedì, / un giorno qualunque della settimana. / Io sono ricco / perché ho fiducia nella vita / e posseggo tante case d’amici veri. /Io sono ricco / perché sono me stesso / sono Nino Pedretti», in M. RICCI, E’ circal de giudéizi; Santarcangelo di Romagna nell’esperienza culturale del secondo dopoguerra. Catalogo della mostra: letteratura, Introduzione di Renzo Cremante, Santarcangelo di Romagna, 16 dic. 2000 – 7 genn. 2001, Clueb, Bologna 2000, 61-62.
[5] N. PEDRETTI, Le pepite d’oro. Poesie 1946-1947, a cura di M. Ricci, Raffaelli Editore, Rimini 2003.
[6] R. BALDINI, Due tre cose su Nino e il dialetto, in N. Pedretti, Al vòusi e altre poesie in dialetto romagnolo, a cura di ; Nota di Dante Isella; Con uno scritto di Raffaello Baldini, Einaudi, Torino 2007.
[7] Fin da giovane, Pedretti aveva coltivato l’interesse per la musica e la danza. La tesi di laurea conseguita nel 1953 a Urbino, relatore Piero Rebora, verteva intorno alla poesia e musica nera d’America.
[8] N. PEDRETTI, Gli uomini sono strade, introduzione di G. Bàrberi Squarotti, Forum/Quinta Generazione, Forlì 1977.
[9] L’esperienza lavorativa in Germania durerà alcuni anni a partire dal 1954, «tornerà nel ’57, e comincerà a lavorare in Italia insegnando inglese in vari istituti medi e dell’avviamento», in M. RICCI, E’ circal de giudéizi; Santarcangelo di Romagna nell’esperienza culturale del secondo dopoguerra. Catalogo della mostra: letteratura, cit., 30-31-32.
[10] Ivi, 223-227.
[11] Ivi, XV.
[12] Cfr. Lingua Dialetto Poesia. Atti del Seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale romagnola, Santarcangelo di Romagna, 16-17 giugno 1973, prefazione di T. De Mauro, Edizioni del Girasole, Ravenna, 1976.
[13] V. SERENI, Come canta quel Nino, in «L’Europeo», 7 dicembre 1981, p. 123)
[14] Postume le pubblicazioni degli scritti in prosa: Teatro minimo. Scritto da Nino Pedretti per bambini dai quattro ai dodici-tredici anni, Centro Stampa del Comune, Pesaro [1982]; Nella favola siamo tutti. Fantastorie, a cura di R. Roversi, disegni di R. Vespignani, Maggioli, Rimini 1989; L’astronomo, introduzione di Franco Brevini, nota biografica di G. Fucci, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1992; Monologhi e racconti, con una nota di Manuela Ricci ed Ennio Grassi, Raffaelli Editore, Rimini 2011; Grammatiche. Monologhi e racconti inediti, , a cura di Tiziana Mattioli, trascrizioni di Elena Nicolini, Raffaelli Editore, Rimini 2012.
Nota.
Una versione più ampia di questo saggio è stata pubblicata sul sito di POLISCRITTURE.
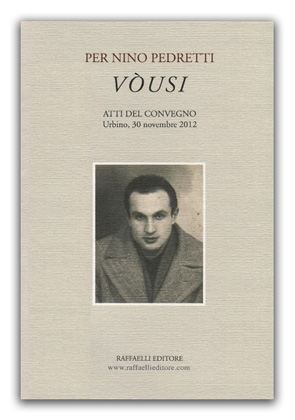

Fonte Enciclopedia TRECCANI- PEDRETTI, Giovanni Maria, detto Nino. – Nacque a Santarcangelo di Romagna, il 13 agosto 1923, da Luigi Renato, impiegato comunale noto in paese come cultore di archeologia (sue ricerche del 1936 diedero impulso alla scoperta delle grotte di Santarcangelo) e studioso di storia locale, e da Maria Cola, insegnante di scuola elementare. Trascorse l’infanzia nella casa di via del Tavernello. Nel 1928 nacque sua sorella Giaele.
Dopo essersi diplomato presso l’Istituto per geometri di Rimini, nel 1942 fu chiamato alle armi a Trieste, da dove fuggì a seguito degli avvenimenti dell’8 settembre 1943 per far rientro a Santarcangelo e trasferirsi poi a San Marino. Ripresi gli studi, conseguì il diploma di maestro all’Istituto magistrale di Forlimpopoli.
È di quegli anni la frequentazione del gruppo di intellettuali santarcangiolesi denominato, con ironia bonaria da parte dei compaesani, E’ circal de giudéizi (Il circolo del senno), che si riunì dapprima in casa di Pedretti e poi al Caffè Trieste e di cui fu inizialmente animatore Tonino Guerra. Questi, fra il 1944 e il 1945, scrisse i testi poi inclusi in I scarabócc (1946), offrendo dignità poetica a un dialetto, quello santarcangiolese, fino a quel momento inedito dal punto di vista della scrittura letteraria.
Del gruppo fecero parte i poeti – a loro volta nel dialetto di Santarcangelo – Raffaello Baldini e Gianni Fucci, lo sceneggiatore e scrittore Flavio Nicolini, i pittori Federico Moroni, Giulio Turci e Lucio Bernardi. Nelle riunioni si discorreva di arti figurative e politica, musica e letteratura; si leggevano Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Éluard, García Lorca, Campana, Ungaretti, Montale, Quasimodo, Kafka, i narratori americani, Moravia. Intorno al 1949 il gruppo conobbe Elio Petri, con il quale collaborarono Fucci e Guerra per la realizzazione del cortometraggio Nasce un campione (1954). Iscrittosi alla facoltà di economia e commercio dell’Università di Ancona, Pedretti la abbandonò quasi subito per passare a quella di lingue straniere dell’Università di Urbino, dove si laureò, nel 1953, discutendo con Piero Rebora una tesi (Poesia e musica negra d’America) sul jazz come punto di arrivo di una tradizione poetico-musicale che ha inizio con i Negro spirituals e le ballades degli schiavi d’America. Agli anni universitari, fra il 1946 e il 1947, risalgono i primi testi poetici che, privilegiando il sermo brevis, risentivano certo delle letture compiute all’epoca, così come di una temperie già postermetica; letti alla cerchia di amici, furono pubblicati postumi con il titolo Le pepite d’oro (a cura di M. Ricci, Rimini 2003).
Dopo aver svolto il ruolo di supplente presso la scuola elementare di Santarcangelo, divenne insegnante alle elementari di Magenta. Abbandonato l’incarico, nel 1954 Pedretti si trasferì in Germania, dove trovò impiego in una banca a Francoforte e poté perfezionare la conoscenza della lingua tedesca.
Rientrato in Italia nel 1957, si recò a Milano, dove collaborò con alcune testate giornalistiche minori. Fece quasi subito rientro a Santarcangelo, ricominciando a fare supplenze nelle scuole. Dopo un breve periodo come addetto alle pubbliche relazioni presso l’Azienda nazionale idrogenazione combustibili (ANIC) di Ravenna, ricoprì provvisoriamente il ruolo di insegnante di inglese a Forlì. Ebbe inizio un periodo di relativa stabilità, cui contribuì anche il matrimonio nel 1959 con Lina Conti, con la quale si trasferì a Rimini. Nel 1960 nacque la figlia Daniela e nel 1961 ottenne la nomina di insegnante di ruolo a Cesena, dove andò a vivere: qui vide la luce la seconda figlia Anna Maria, mentre un terzo figlio, Paolo, nacque nel 1963.
Fra gli anni Cinquanta e Sessanta, insieme con l’approfondimento della lingua inglese, si era dedicato all’attività di curatore e traduttore di testi stranieri. Nel 1963 scrisse la prefazione a un’edizione scolastica del romanzo di J.K. Jerome, Tre uomini in barca (tradotto da Anna Maria Mezzolani Casadei). Assieme a Eloisa Paganelli curò poi l’antologia British children teach Italian children (Bologna 1966): pensato per le scuole medie, il volume raccoglieva testi scritti da bambini britannici, nella convinzione che le esigenze espressive e i contenuti psicologici che danno forma a un linguaggio siano i medesimi durante l’età puberale, in Italia come nel Regno Unito.
Nel 1967 frequentò un corso di fonologia a Edimburgo. L’anno successivo ricoprì l’incarico di insegnante di inglese al liceo di Pesaro, dove nuovamente si trasferì con tutta la famiglia. Nel 1972 ebbe l’incarico per il coordinamento della Commissione docente nei corsi abilitanti per l’area linguistica. A prosecuzione di questo iter didattico, nel 1975 l’Università di Urbino gli affidò l’insegnamento di «glottodidattica nella Scuola di perfezionamento» (Ricci, 2003, p. 12 n.).
Ma gli anni Sessanta e Settanta furono anche quelli della scelta del dialetto come lingua della poesia. Pedretti, che amava definirsi linguista, si impegnò in una ricerca sulla fonologia delle parlate locali, commissionatagli dal Comune di Santarcangelo e registrata su una serie di nastri. In tale percorso è da segnalare l’amicizia con il glottologo Friedrich Schürr, studioso di dialetti romagnoli, che veniva raccogliendo i risultati dei suoi spogli nel volume La voce della Romagna (1974).
Stimolato dalla frequentazione di Guerra e di altri poeti del circal (fra cui Baldini, che esordì nel 1976 con E’ solitèri), anche Pedretti scrisse quindi i suoi primi versi in dialetto, che apparvero nel bimestrale TuttoSantarcangelo fra il 1970 e il 1973: le poesie Trent’an (n. 33), La lèngua dla mi mà, Se la lèngua la mor (n. 60) e I nòm dal strèdi (n. 66). Sempre nel 1973 fu tra i partecipanti al Seminario popolare su Tonino Guerra e la poesia dialettale romagnola, ideato da Nicolini e organizzato da Rina Macrelli (anche lei parte del circal), che si tenne il 16 e 17 giugno a Santarcangelo, dove lesse la relazione Poesia romagnola del dopoguerra (poi inclusa negli atti Lingua Dialetto Poesia, usciti nel 1976, con prefazione di Tullio De Mauro, per le Edizioni del Girasole di Ravenna). In un commento a margine della relazione di Augusto Campana toccò il problema della trascrizione del santarcangiolese, oggetto di discussione con Schürr (dalle posizioni del quale si era allontanato, prediligendo piuttosto una riduzione dei segni diacritici, e ricorrendo ai soli accenti acuto e grave).
Ma l’evento più importante fu la pubblicazione della prima raccolta in santarcangiolese, Al vòuṣi (Ravenna 1975), con prefazione di Alfredo Stussi. Le voci del titolo sono quelle della comunità paesana, in un’ottica di poesia civile intesa a dare la parola a chi, per imposizione storica, non l’ha mai avuta; sono voci di personaggi umili e non illustri, veicolo di espressione di una mentalità popolare creativa e fantastica. La scelta del dialetto, idioma letterariamente affrancato dall’oleografia municipalistica pur restando lingua quotidiana e semanticamente concreta, fu tanto più significativa quanto più si consideri che esso era lingua d’elezione a posteriori; in ogni caso non canale di recupero memoriale, né lingua rappresentativa di un’infanzia perduta (nonostante sia definito lèngua dla mi mà). La novità di tale scelta era inoltre in certa autonomia lessicale rispetto a Guerra, e nella semplificazione grafica dei dittonghi (evidenziata dallo stesso Pedretti in una Nota sul dialetto).
Tra febbraio e settembre 1974 Pedretti aveva pubblicato inoltre alcune prose satiriche sul mondo della scuola (La scuola, La carriera, La pensione e Lo stato giuridico finalmente) in TuttoSantarcangelo. Tre anni dopo diede invece alle stampe la raccolta Gli uomini sono strade (Forlì 1977); prefata da Giorgio Bàrberi Squarotti, che rilevava la maggiore ampiezza e distensione di discorso delle liriche in lingua rispetto all’essenzialità di quelle in dialetto, includeva poesie scritte fra il 1946 e il 1977, per alcune delle quali era stato insignito nel 1969 con il Cervo d’argento alla XIII edizione del premio Cervia di poesia.
A pochi mesi di distanza vide la luce la seconda silloge in santarcangiolese, Te fugh de mi paèiṣ (Nel fuoco del mio paese, Forlì 1977), con dedica alle donne ispiratrici della parlata in dialetto, che abbandonava la coralità di Al vòuṣi per farsi ricerca lirica di un senso fuggevole al di là delle cose, intuito in pochi dettagli come una finestra aperta, lo scorrere dell’acqua, un odore, un ricordo improvviso. Proseguendo l’attività di traduttore, pubblicò una versione in italiano del poema di Sylvia Plath, Three women (Tre donne. Un poema per tre voci, Forlì 1978).
Nel 1979 seguì l’organizzazione del Convegno nazionale di studi su Antonio Baldini, che ebbe luogo a Santarcangelo il 16 e 17 giugno. Per l’occasione preparò un’intervista a Marino Moretti, che non fece in tempo a realizzare per la malattia di quest’ultimo, morto poi a luglio. Grazie a una borsa di studio ricevuta dall’Experiment in international living, pochi giorni dopo si recò a Saint Louis per seguire un corso di perfezionamento sulla letteratura americana presso il Webster College. Visitò anche New York, da cui trasse l’immagine della ‘città verticale’. Tuttavia, come emerge da una lettera alla moglie del 25 giugno, gli Stati Uniti gli ispirarono da subito un sentimento di durezza e ostilità.
Al ritorno in patria il suo fisico era già minato dal linfoma che non molto tempo dopo lo avrebbe portato alla morte.
Ebbe comunque la forza di lavorare all’ultima raccolta in santarcangiolese, La chèṣa de témp (La casa del tempo, Milano 1981), in cui si avverte l’imminenza della fine, che uscì postuma, con uno scritto di Carlo Bo, per i tipi di All’insegna del pesce d’oro. Il manoscritto, la cui stesura fu accompagnata da uno scambio epistolare con Baldini sul problema della grafia del dialetto, piacque a Dante Isella (lettera a Pedretti, 3 novembre 1980).
Pedretti morì a Rimini il 30 maggio 1981.
L’anno prima era stato insignito del primo premio al concorso di poesia Romagna. Con una lettera del 12 marzo 1982, Ettore Bonora, ancora ignaro della sua scomparsa, ne elogiava la produzione in santarcangiolese.
Postumi uscirono, oltre a La chèṣa de témp e a Le pepite d’oro, una silloge di pièces per bambini fra i quattro e i tredici anni, Teatro minimo (Pesaro 1982), e una di ‘fantastorie’ risalenti al 1961, Nella favola siamo tutti (Rimini 1989). Videro poi la luce 37 racconti e monologhi con il titolo L’astronomo (a cura di F. Brevini – G. Fucci, Milano 1992), cui seguirono “Al vòuṣi” e altre poesie in dialetto romagnolo, a cura di M. Ricci, nota di D. Isella, postfazione di R. Baldini (Torino 2007); Monologhi e racconti, a cura di M. Ricci – E. Grassi (Rimini 2011) e Grammatiche: monologhi e racconti inediti, a cura di T. Mattioli (Rimini 2012).
Fonti e Bibl.: Archivio Pedretti, donato da Lina Conti alla Biblioteca comunale A. Baldini di Santarcangelo di Romagna.
Pelasgi. I poeti romagnoli in lingua, a cura di D. Argnani – G.R. Manzoni, Rimini 1985, pp. 35-56; G. Fucci, ‘E’ circal de giudéizi’…, in Diverse lingue. Rivista semestrale delle letterature dialettali e delle lingue minori, 1992, n. 11, pp. 37-46; N. Pedretti, L’astronomo, introduzione di F. Brevini, nota biografica di G. Fucci, Milano 1992; E’ circal de giudéizi. Santarcangelo di Romagna nell’esperienza culturale del secondo dopoguerra…, a cura di M. Ricci, Bologna 2000; M. Ricci, Prefazione a N. Pedretti, Le pepite d’oro, Rimini 2003; C. Martignoni, Per non finire. Sulla poesia di Raffaello Baldini, Pasian di Prato 2004, pp. 49-58; Per N. P., Atti del convegno, Urbino… 2012, a cura di G. De Santi et al., Rimini 2013.
Nino Pedretti nasce a Santarcangelo il 13 agosto 1923, figlio di un impiegato comunale e di una maestra elementare.
Dopo essersi diplomato presso l’Istituto per geometri di Rimini, nel 1942 viene chiamato alle armi a Trieste, da dove fugge a seguito degli avvenimenti dell’8 settembre 1943 per far rientro nella città natale e rifugiarsi poi a San Marino.
Ripresi gli studi nel primo dopoguerra, consegue il diploma di maestro presso l’Istituto Magistrale di Forlimpopoli; è in quegli anni che dà vita, assieme ad altri giovani intellettuali santarcangiolesi, al sodalizio che diventerà noto come E’ circal de’ giudéizi.
Decide di continuare gli studi iscrivendosi alla facoltà di lingue straniere dell’Università di Urbino, ove si laurea nel 1953 con una tesi sul jazz.
Successivamente si trasferisce in Germania. Rientra in Italia e insegna lingua inglese nei licei di Cesena e Pesaro. Nel 1975 pubblica Al vòuşi, la sua prima raccolta di poesie in romagnolo. L’opera riscontra un immediato successo.
Muore prematuramente nel 1981, a 57 anni.
Del dialetto romagnolo, Pedretti ha lasciato questa definizione:
| «A differenza dell’italiano, arrotolato nei codici, levigato ed illustre, il fratello umile, il dialetto, è vissuto all’aperto come un’erba selvatica, bagnato dalla pioggia dei secoli e come un’erba pertinace di gramigna, si è arrampicato sui monti, si è addentrato nei minimi villaggi, ha coperto ogni metro di terra dove viveva la gente comune del lavoro e dei sacrifici.» |
Sebbene Pedretti sia principalmente un letterato, l’esigenza di scrivere il dialetto santarcangiolese lo ha indotto ad affrontare l’analisi del proprio dialetto, confrontandosi anche con Friedrich Schürr, che Pedretti incontrò a Costanza. A partire da tale confronto egli definì alcuni criteri grafici che furono poi adottati da altri autori santarcangiolesi, e che trovano un fondamento obbiettivo anche negli studi più recenti[1].



