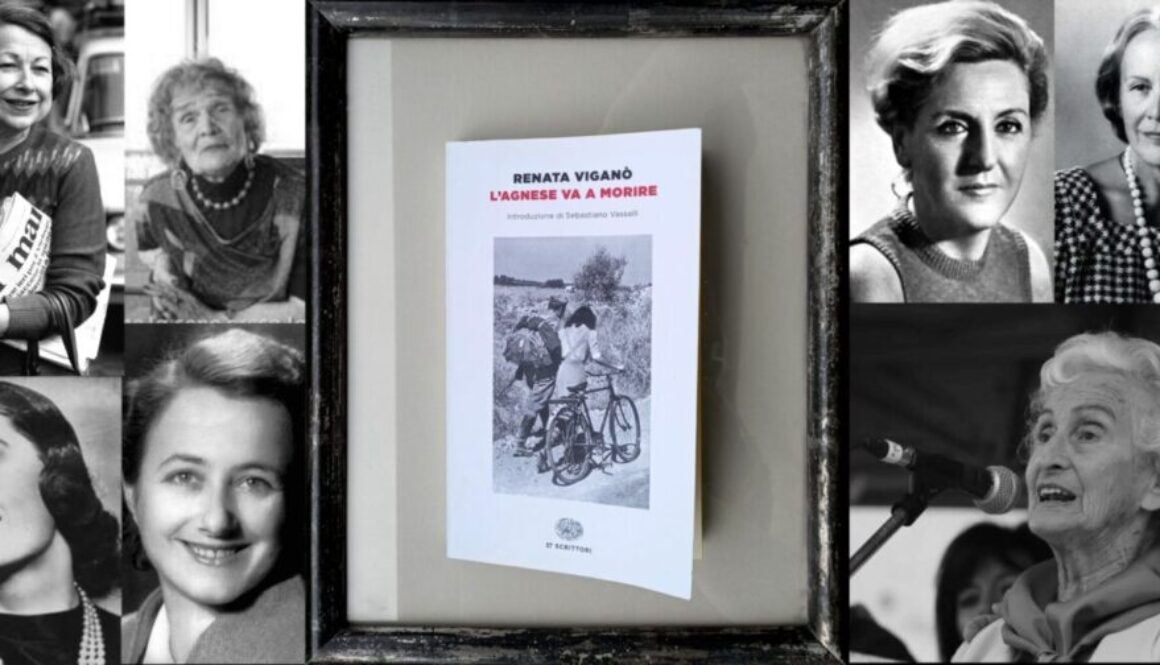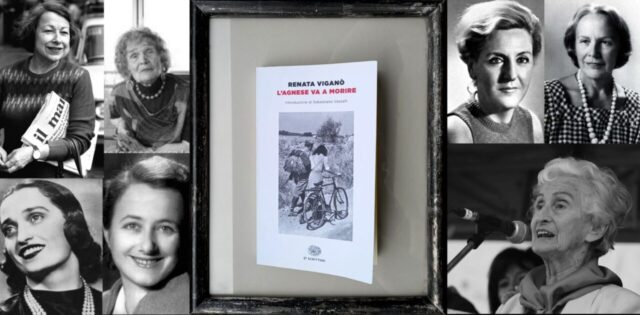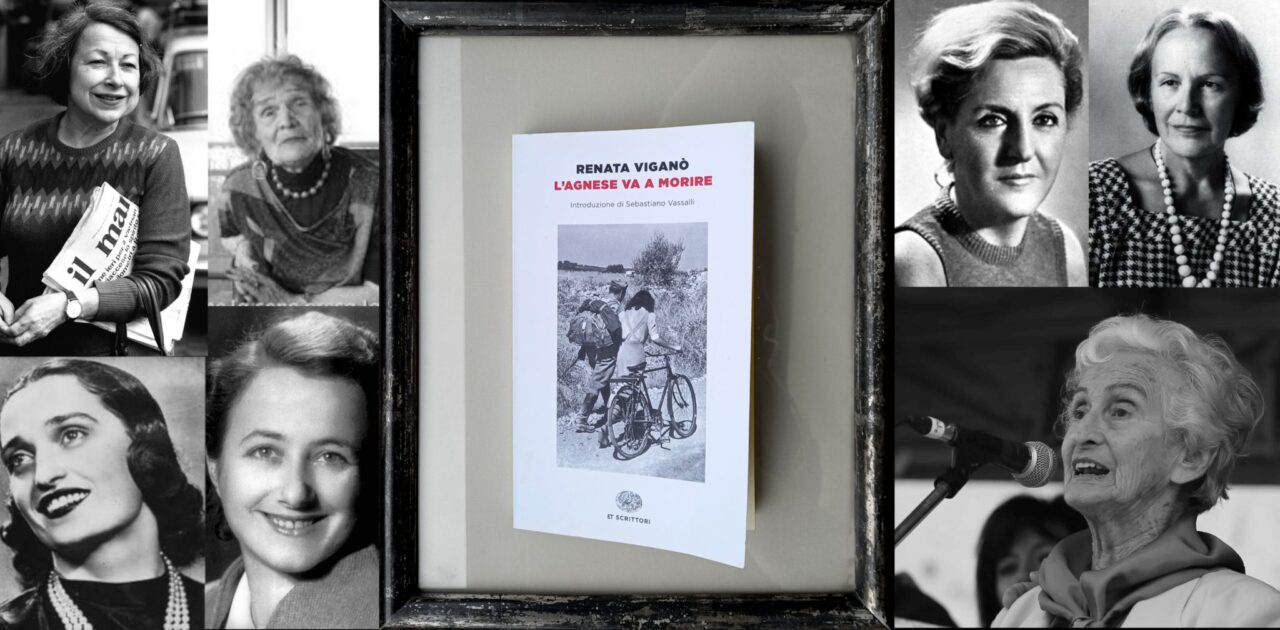Tarquinia (VT): nella necropoli etrusca del sito Unesco scoperta nuova tomba dipinta-Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA
Tarquinia (VT): nella necropoli etrusca del sito Unesco scoperta nuova tomba dipinta
Tarquinia-Straordinaria scoperta nel sito Unesco di Tarquinia nella necropoli etrusca, dove gli archeologi hanno ritrovato una nuova tomba a camera dipinta: le pitture sulle pareti mostrano scene di danza e di officina. La scoperta risale alla fine del 2022, anche se è stata comunicata dalla Soprintendenza di Viterbo soltanto in queste ore. Tutto comincia nel corso di un’ispezione della Soprintendenza a seguito dell’apertura di alcune cavità nel terreno: l’eccezionale scoperta è avvenuta nella necropoli etrusca dei Monterozzi, vicino a Tarquinia, dove gli archeospeleologi, esplorando quelle cavità, hanno confermato che si trattava di sepolcri già visitati da scavatori clandestini in passato. Tuttavia, una delle tombe celava un segreto ancora intatto: il crollo di una parete aveva rivelato una camera funeraria più profonda, decorata con scene dipinte dai colori straordinariamente vividi.

Questa nuova tomba, catalogata con il numero 6438, è stata dedicata alla memoria di Franco Adamo, rinomato restauratore delle tombe dipinte di Tarquinia, scomparso nel maggio 2022. Il ritrovamento rappresenta un evento di grande rilievo per l’archeologia etrusca, riportando alla luce uno spaccato di vita e cultura di oltre duemila anni fa.
La scoperta è frutto del lavoro della Soprintendenza di Viterbo e dell’Etruria Meridionale, e in particolare degli archeologi Daniele F. Maras e Rossella Zaccagnini del Ministero della Cultura, assieme ai collaboratori esterni Gloria Adinolfi e Rodolfo Carmagnola, mentre lo scavo è stato condotto da Archeomatica s.r.l.s., e il restauro delle superfici da Adele Cecchini e Mariangela Santella. A.S.S.O. si è invece occupata delle operazioni di archeospeologia.

Un delicato lavoro di scavo e messa in sicurezza
Per evitare che il sito venisse compromesso da tombaroli o da visitatori imprudenti, la Soprintendenza ha mantenuto il massimo riserbo sulle operazioni di scavo Grazie a un finanziamento straordinario del Ministero della Cultura, gli archeologi hanno potuto condurre un intervento meticoloso per mettere in sicurezza la tomba e preservarne il delicato equilibrio: per queste ragioni, oltre che per studiare quanto riemerso, la notizia è stata comunicata due anni dopo l’effettivo ritrovamento.
“Dopo aver ripristinato l’accesso alla camera funeraria”, spiega Daniele F. Maras, il funzionario archeologo responsabile della scoperta, oggi direttore del Museo Archeologico Nazionale di Firenze, “e una volta installata una porta metallica, lo scavo archeologico ha dimostrato che tutto il materiale raccolto non apparteneva al corredo della tomba dipinta, che risale alla metà del V secolo a.C., ma era franato da quella superiore, più antica di oltre un secolo, della fine dell’epoca Orientalizzante”.

Una stratificazione complessa tra storia e natura
L’indagine archeologica ha rivelato una situazione unica e complessa. La tomba dipinta era stata scavata in profondità sotto una sepoltura preesistente. In epoca antica, ladri di tombe erano riusciti a penetrare nel sepolcro forando il lastrone di chiusura, saccheggiando il corredo originario. Successivamente, il crollo della camera superiore ha portato con sé detriti e oggetti, mescolandoli ai resti della tomba inferiore.
Di ciò che un tempo costituiva il corredo funerario della tomba dipinta restano solo pochi frammenti di ceramica attica a figure rosse, testimonianza del pregio degli oggetti deposti con il defunto. Tuttavia, il vero tesoro del ritrovamento è rappresentato dagli affreschi che decorano le pareti della camera funeraria.

Scene di danza e di officina: un’iconografia senza precedenti
Le pitture parietali, ancora in fase di restauro, offrono uno spaccato unico della cultura etrusca. La parete sinistra è animata da una danza frenetica: uomini e donne si muovono in cerchio attorno a un elegante flautista, in una scena che esprime la vitalità e il gusto per la celebrazione tipici del popolo etrusco.
Sulla parete di fondo, invece, emergono le figure di una donna – forse la defunta – e due giovani, ma parte della decorazione è andata irrimediabilmente perduta a causa di un crollo. Ancora più enigmatica è la parete destra, dove affiora un’officina metallurgica in attività. Gli studiosi ipotizzano che possa rappresentare il mitico laboratorio del dio Sethlans (equivalente etrusco di Efesto), oppure un’officina reale appartenente alla famiglia sepolta.

Restauro e tecnologie avanzate per riportare i colori alla luce
Gli interventi di restauro sono ancora in corso e richiedono estrema precisione. “Il livello straordinario delle pitture”, commenta con soddisfazione la soprintendente Margherita Eichberg, “è evidente già nel primo tassello di restauro, operato da Adele Cecchini e Mariangela Santella, che mette in luce la raffinatezza dei dettagli delle figure del flautista e di uno dei danzatori”. E aggiunge Daniele Maras: “Da decenni, questa è la prima nuova tomba dipinta con fregio figurato che viene scoperta a Tarquinia e si preannuncia molto intrigante per la sua storia, per il livello artistico e per alcune delle scene rappresentate, uniche nel loro genere”.
Il progetto di conservazione prevede la costruzione di una struttura protettiva intorno alla tomba, dotata di una porta a taglio termico per garantire condizioni climatiche ottimali. Inoltre, gli archeologi stanno applicando tecnologie avanzate di imaging multispettrale per recuperare i colori scomparsi dei pigmenti antichi. I primi test hanno già dato risultati sorprendenti, restituendo nuova luce a queste straordinarie testimonianze dell’arte funeraria etrusca.

Verso un futuro di studi e accessibilità pubblica
Mentre il restauro procede, gli archeologi continuano a studiare il materiale raccolto per comprendere meglio il contesto storico e sociale della tomba. L’obiettivo a lungo termine è quello di rendere il sito accessibile al pubblico, permettendo di ammirare da vicino questa straordinaria testimonianza dell’arte e della cultura etrusca.
Il ritrovamento della tomba n. 6438 non è solo una grande scoperta per l’archeologia italiana, ma un tassello fondamentale per riscoprire l’identità di un popolo che, attraverso la bellezza delle sue pitture funerarie, continua a raccontare la propria storia a distanza di millenni.
Fonte-Finestre sull’Arte-Direttore responsabile-Federico Giannini