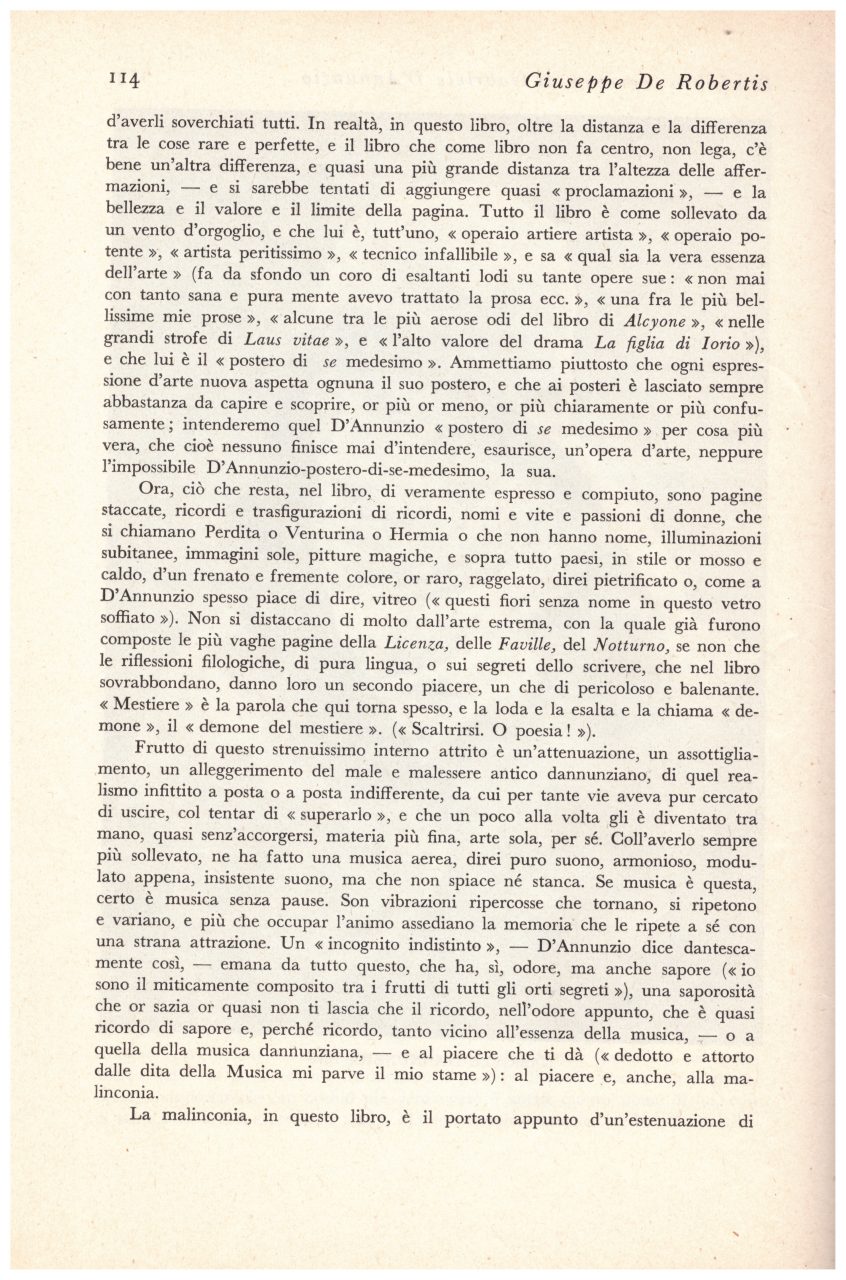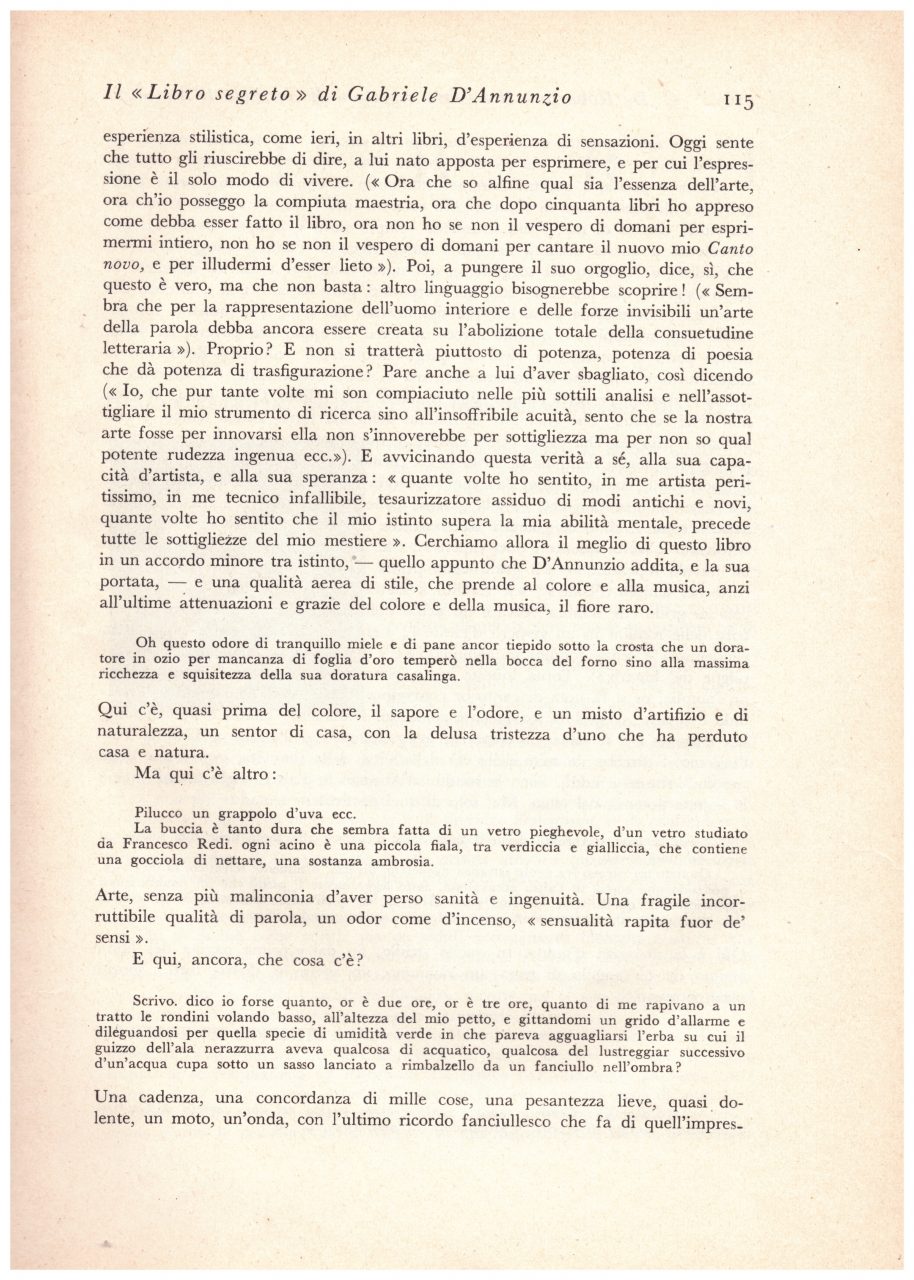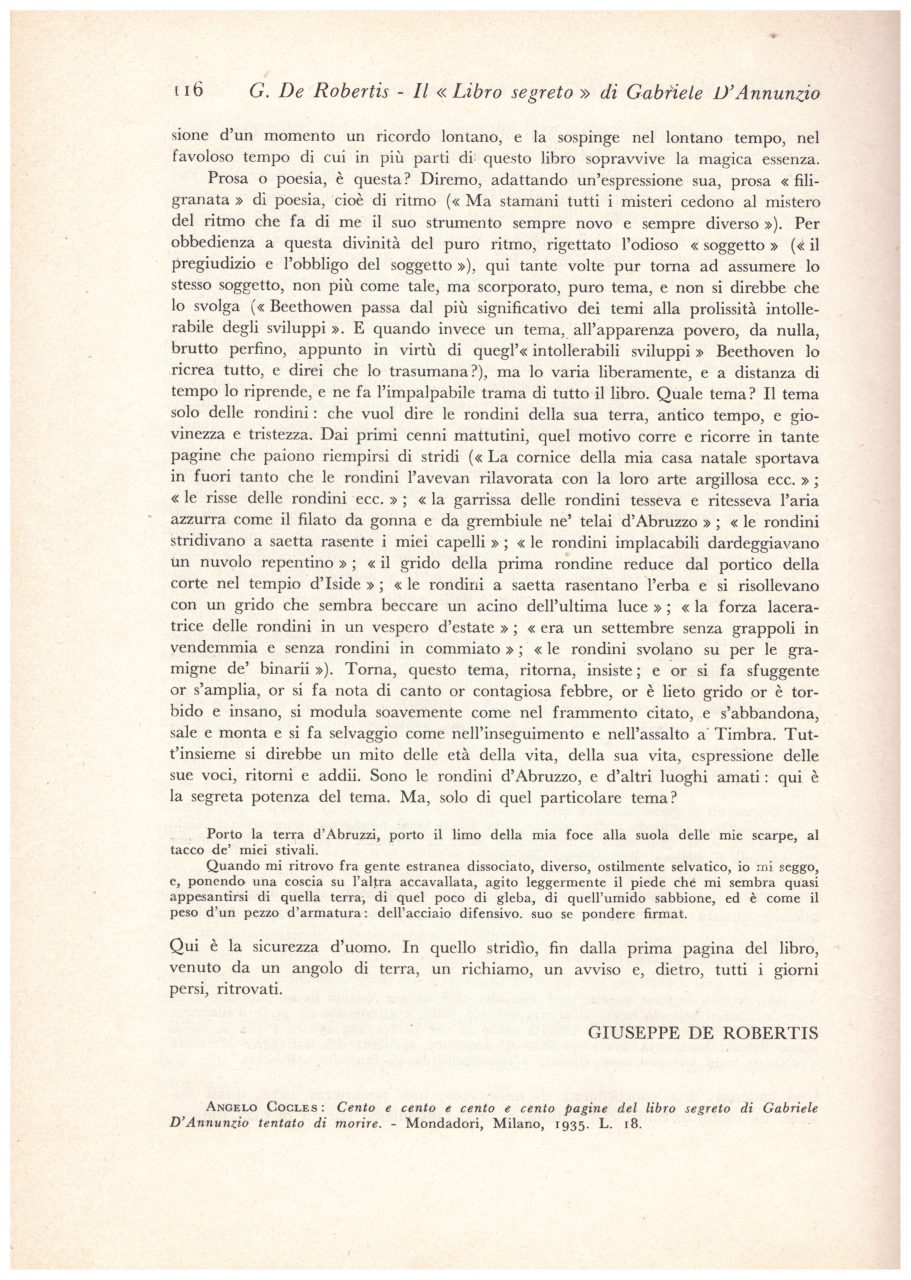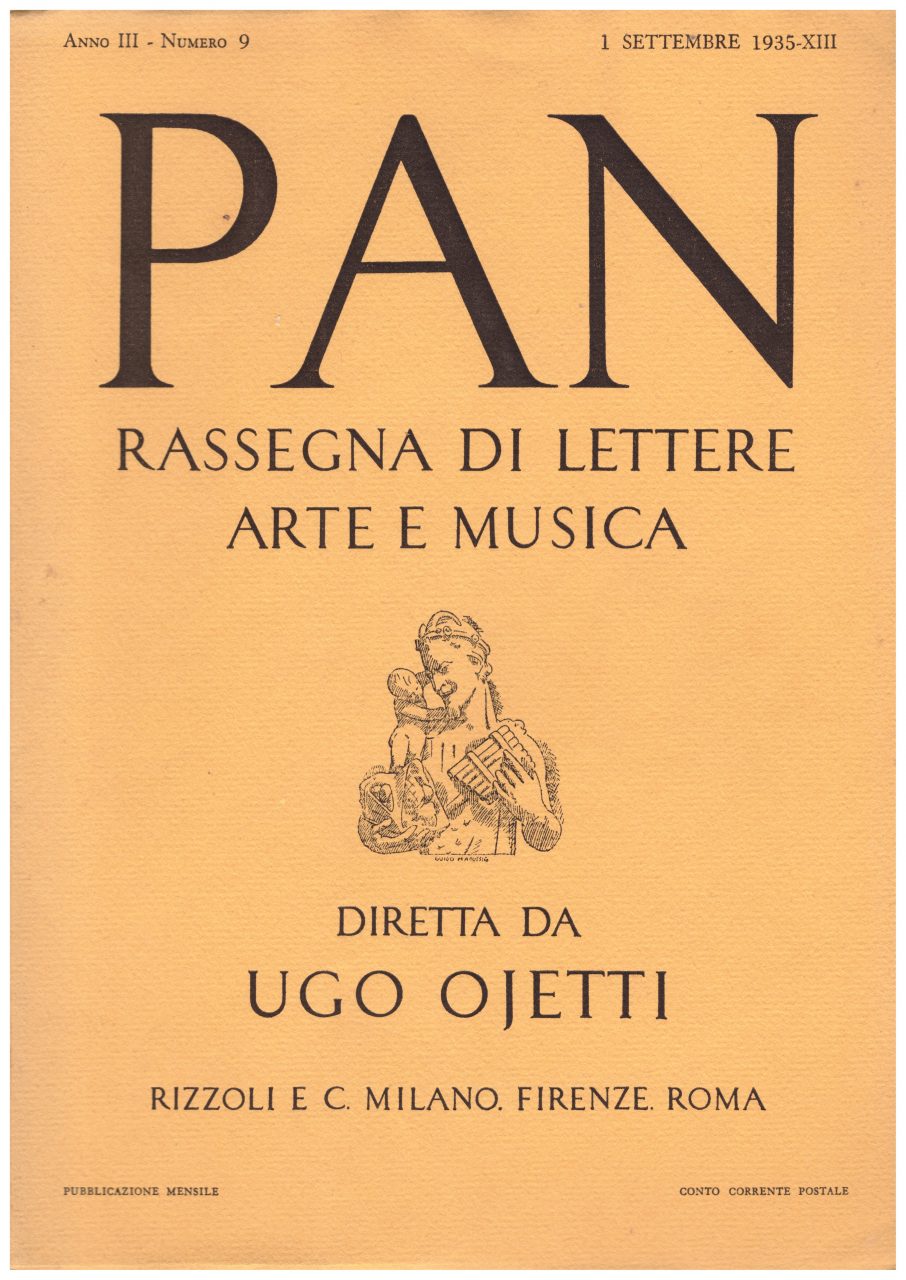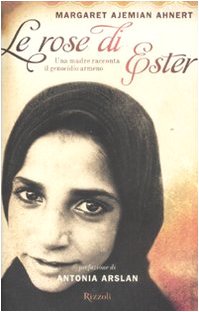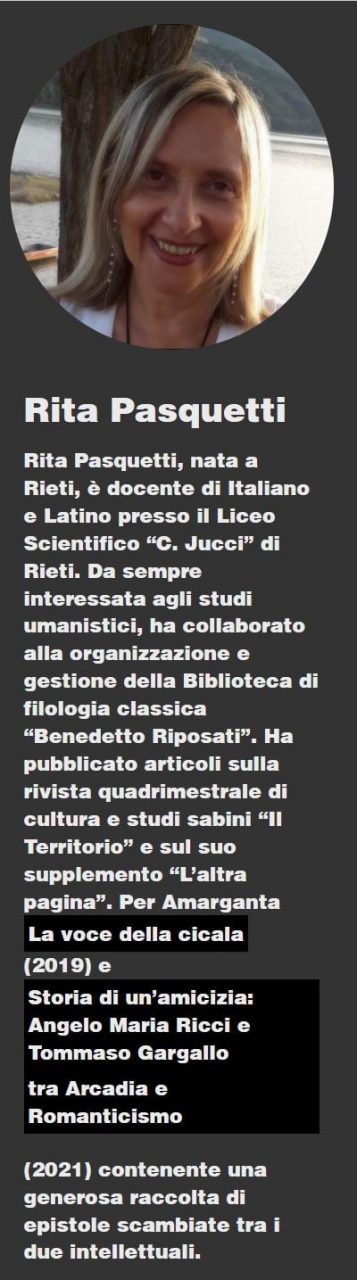Il “LIBRO SEGRETO” di Gabriele D’ANNUNZIO – Rivista PAN n°9 -1935-Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA
–Il “LIBRO SEGRETO” di Gabriele D’ANNUNZIO –
Rivista PAN n°9 -1935
Gabriele D’Annunzio nacque a Pescara nel 1863 ed è stato uno scrittore, un poeta, Gabriele D’Annunzio un drammaturgo ma anche un militare e politico italiano.
Fu l’inventore della frase “vivere inimitabile” ed è proprio questo il modo in cui ha cercato di vivere la propria vita fin dalla più giovane età. Fin da subito mostrò un grande interesse per la letteratura, tanto da pubblicare la sua prima raccolta di poesie negli anni in cui frequentava il collegio. Questa raccolta prende il nome di Primo Vere e ne affronteremo una poesia nei paragrafi successivi.
Quando pubblicò quest’opera aveva soltanto sedici anni e questa potremmo dire che segnò il suo avvenire nel mondo letterario di quegli anni. Si iscrisse poi alla facoltà di Lettere a Roma, anche se non porterà mai a termine i suoi studi.
Quel periodo trascorso nella grande città, però, gli fu comunque utile per approfondire i suoi interessi nel giornalismo e per la frequentazione di vari salotti letterari che lo avviarono alla vita mondana. Cominciarono in quegli anni le sue storie d’amore e le sue storie di vita sregolata, tutte con l’obiettivo di vivere una vita degna di essere vissuta al massimo.
Proprio per questo è considerato il padre dell’Estetismo: la sua dottrina del vivere inimitabile si diffonde non soltanto al suo modo di vivere la sua vita, ma anche nelle opere che scrive in quel periodo. Pubblicò Il Piacere, che divenne il simbolo dell’estetismo stesso che, appunto, si impone non soltanto come un vero e proprio movimento letterario ma anche come un modo di vivere la vita.
La sua vita sregolata e dedita al piacere a Roma comporta lo sviluppo di diversi debiti, per fuggire dai quali si trasferì a Venezia dove conobbe il suo grande amore, Eleonora Duse, che diventerà la sua musa ispiratrice.
In questo periodo entrò in contatto con la dottrina di Nietzsche del superuomo, che appare del tutto in linea con la sua dottrina dell’estetismo: si tratta di un uomo che rifiuta le convenzioni sociali, che è uno spirito libero e che non accetta alcun tipo di costrizione data dalla società.
Fu un aperto sostenitore della Prima Guerra Mondiale e si batté affinché il paese vi prendesse parte. Infatti, lui stesso partecipò alle battaglie, anche se perse la vista da un occhio a causa delle ferite riportate. In questo periodo scrisse un’opera intitolata Il Notturno, che racconta proprio della perdita della vista e del periodo di guarigione successivo.
Dopo la guerra, con l’arrivo in Italia della politica mussoliniana, si ritirò dalla vita politica e passò gli ultimi anni in ritiro, all’interno di quello che successivamente diventerà Il Vittoriale degli Italiani, costruito a partire dal 1921 da lui stesso con l’aiuto dell’architetto Gian Carlo Maroni.
Morì nel 1938.