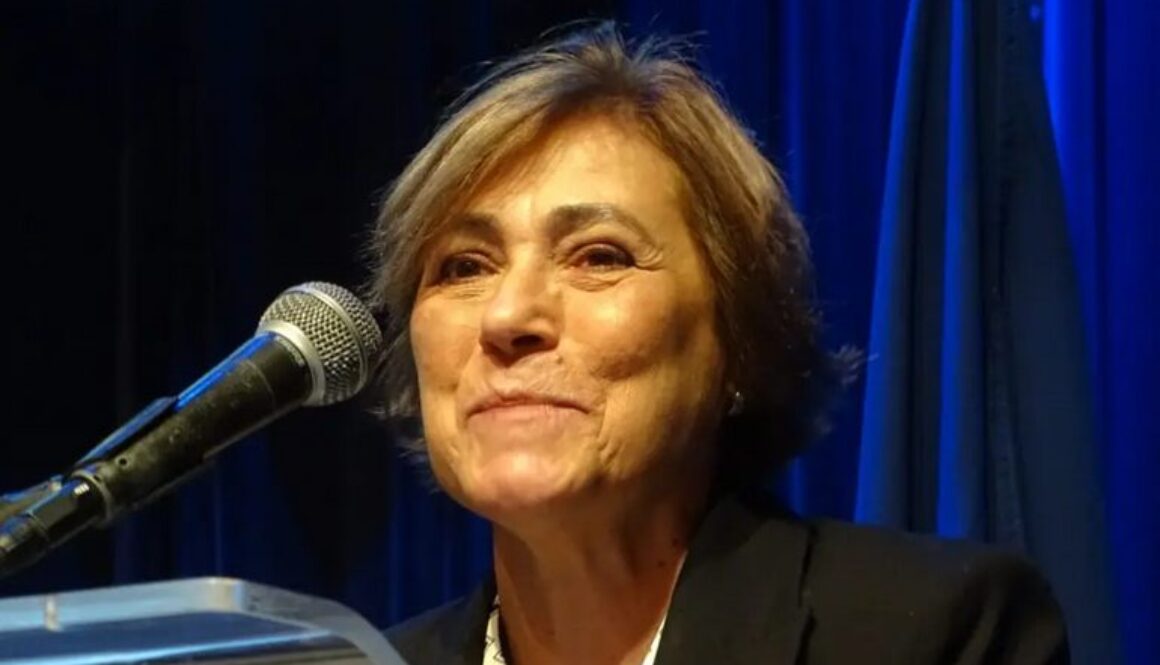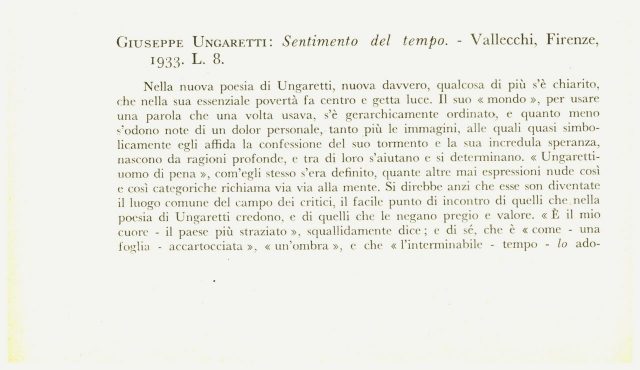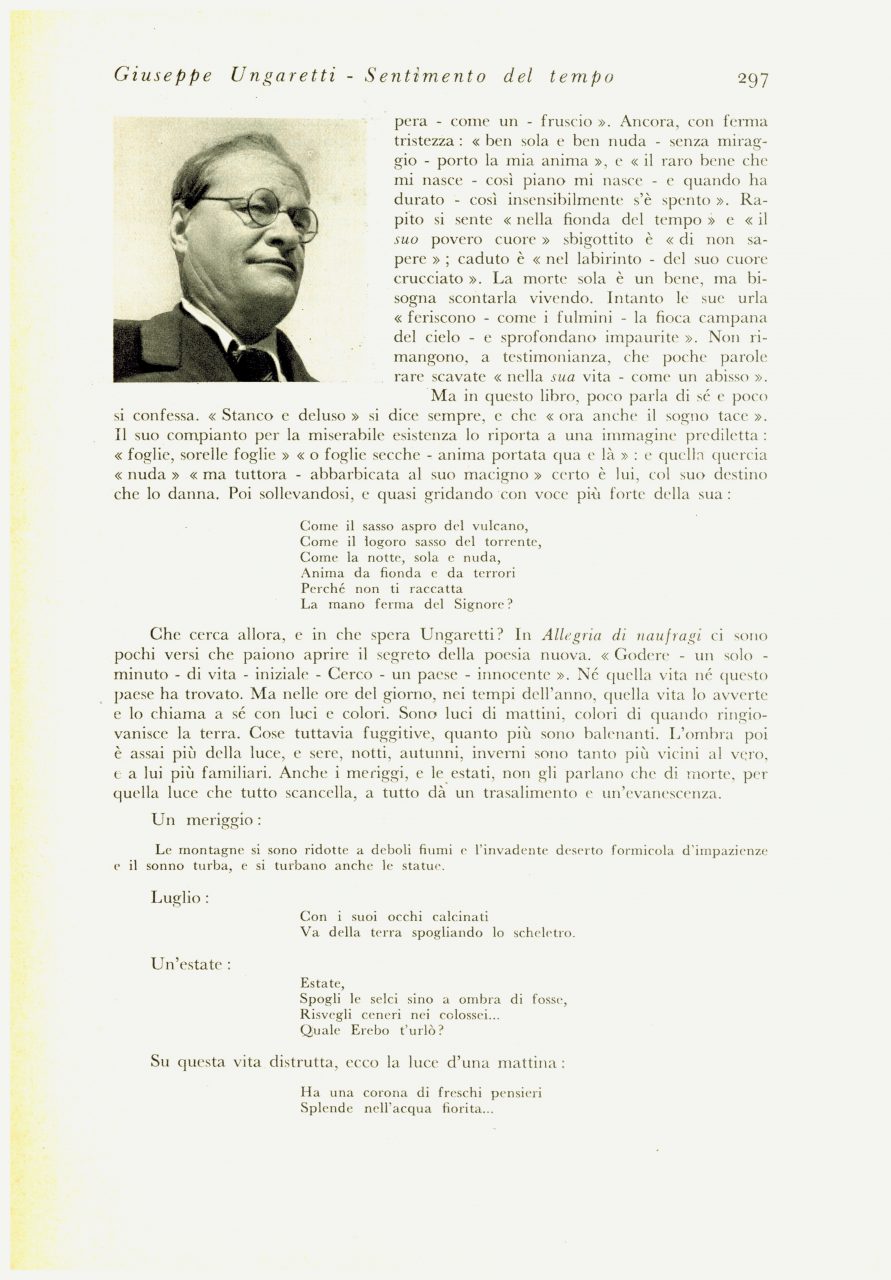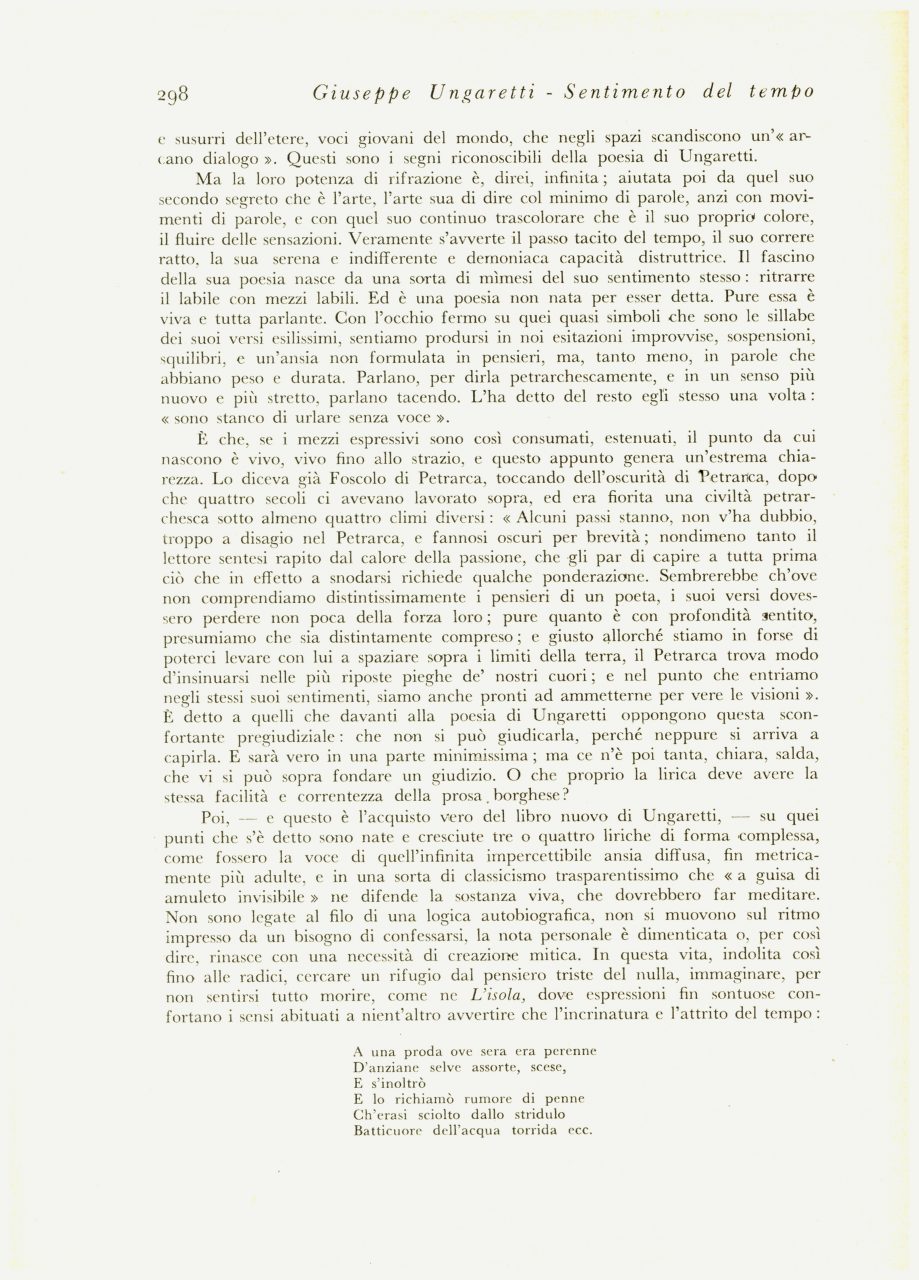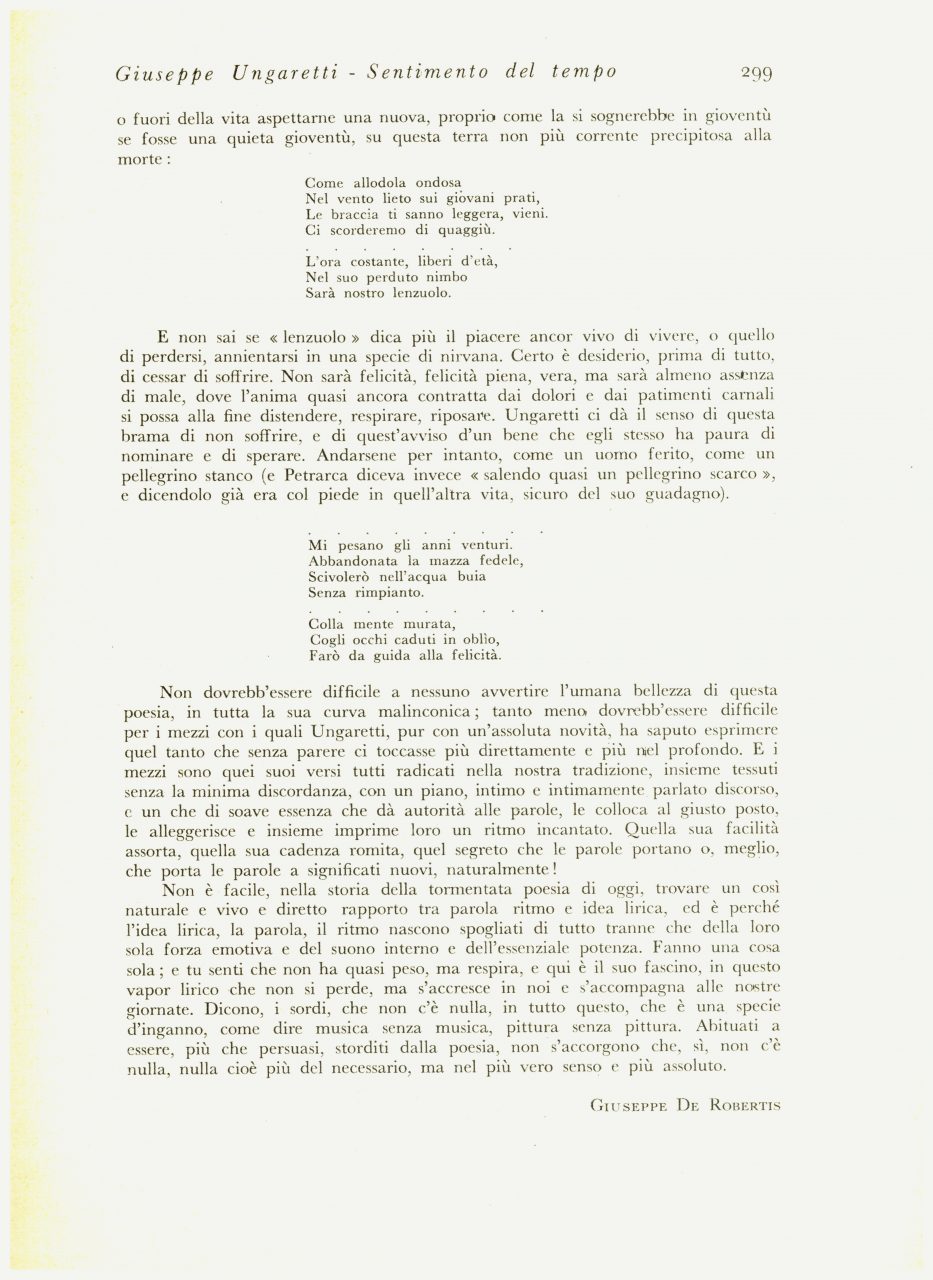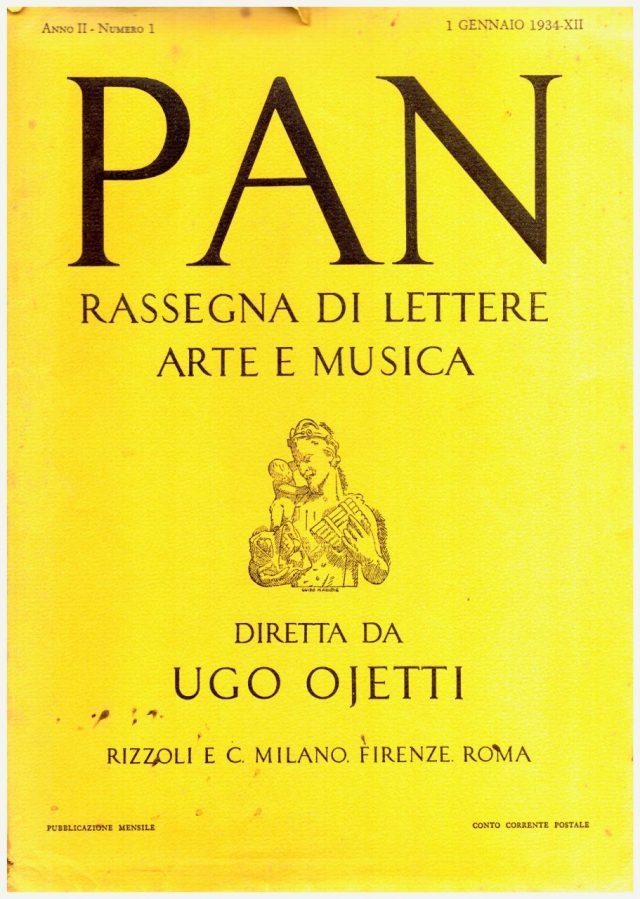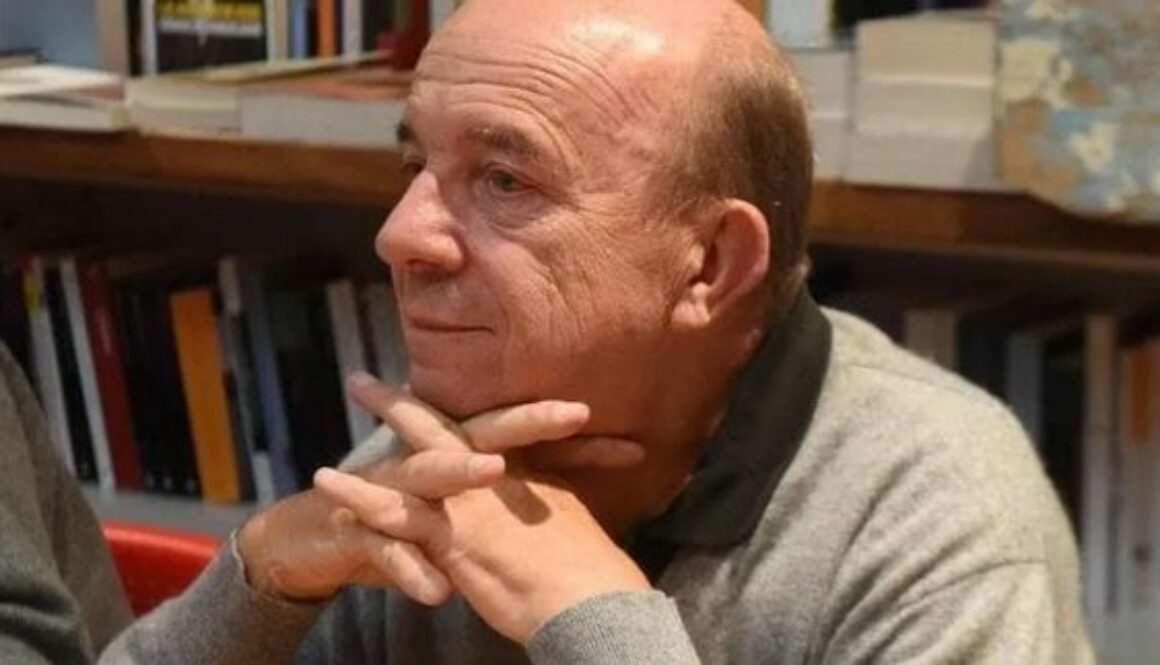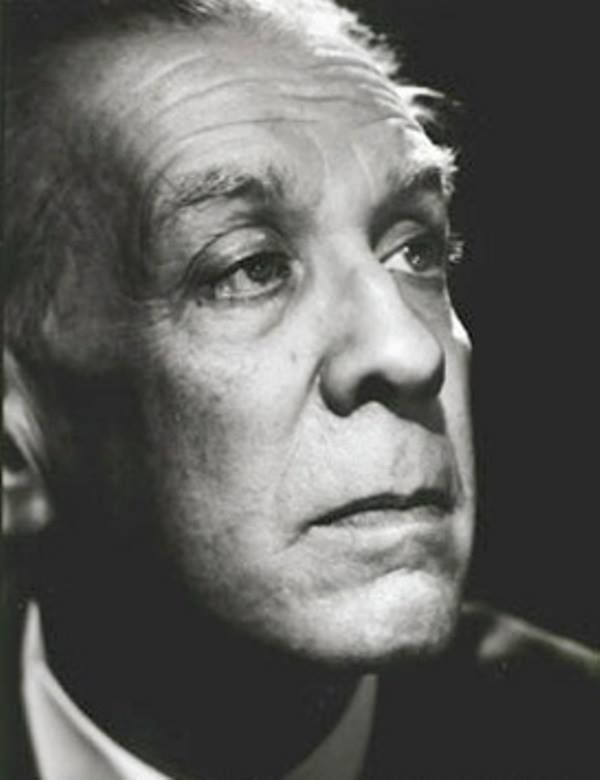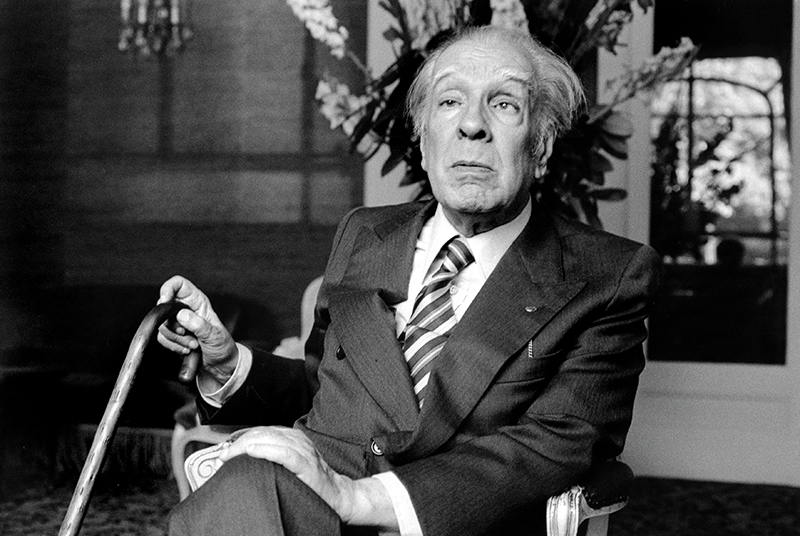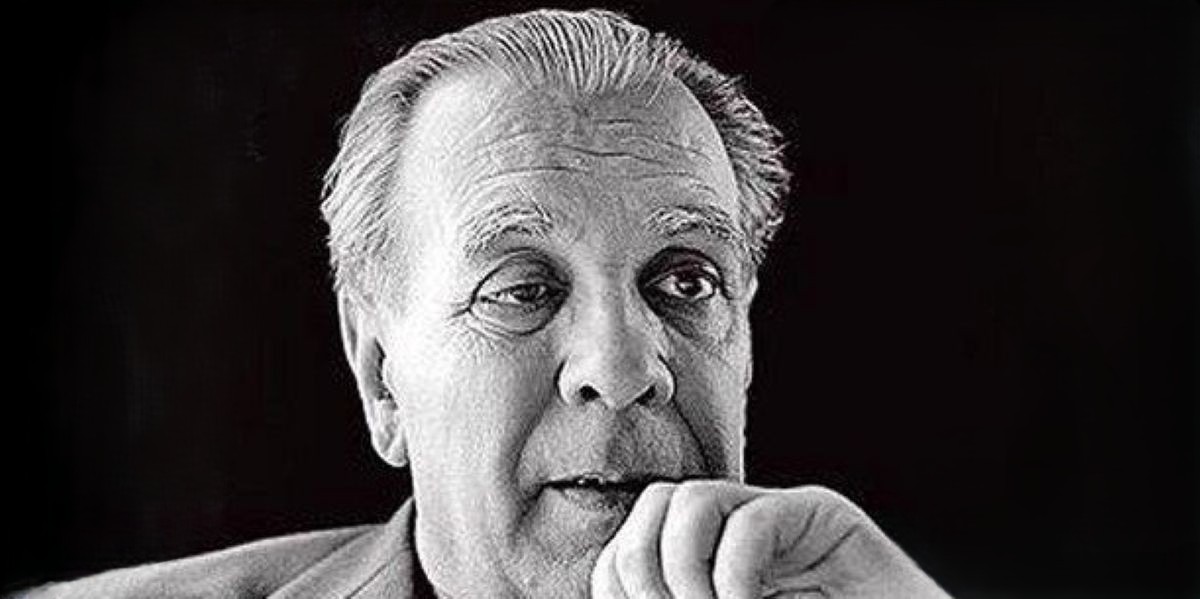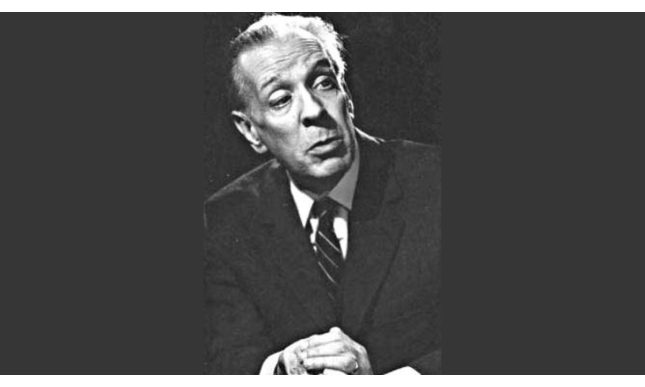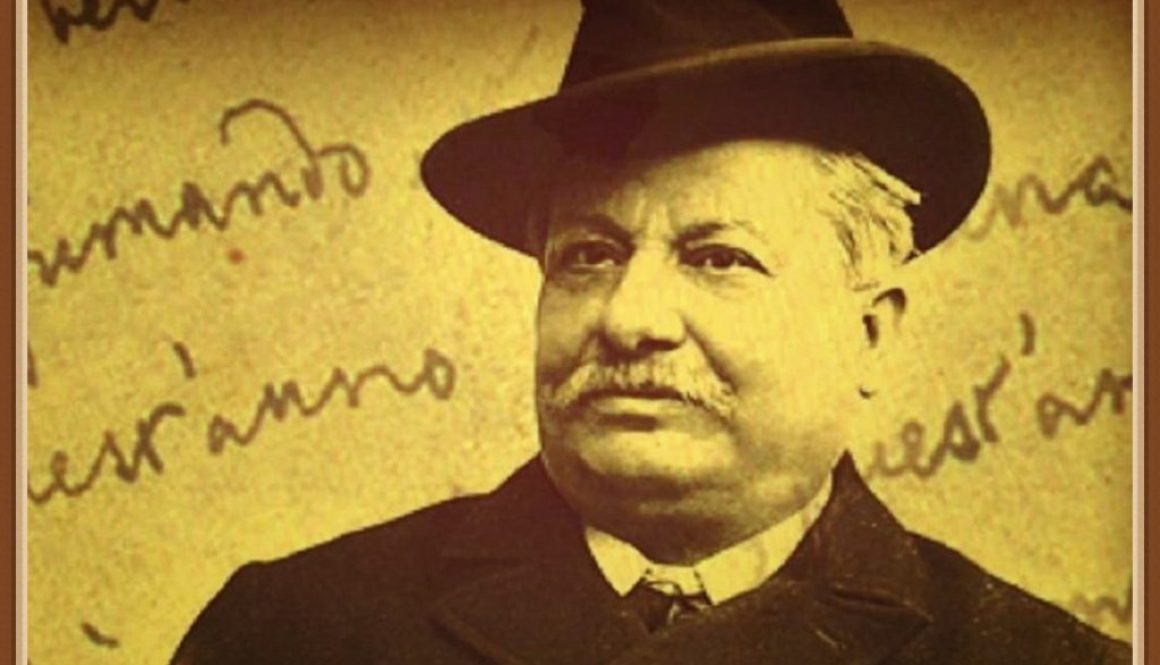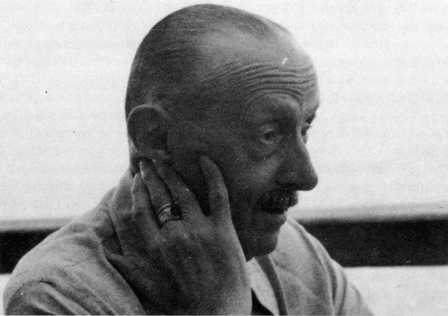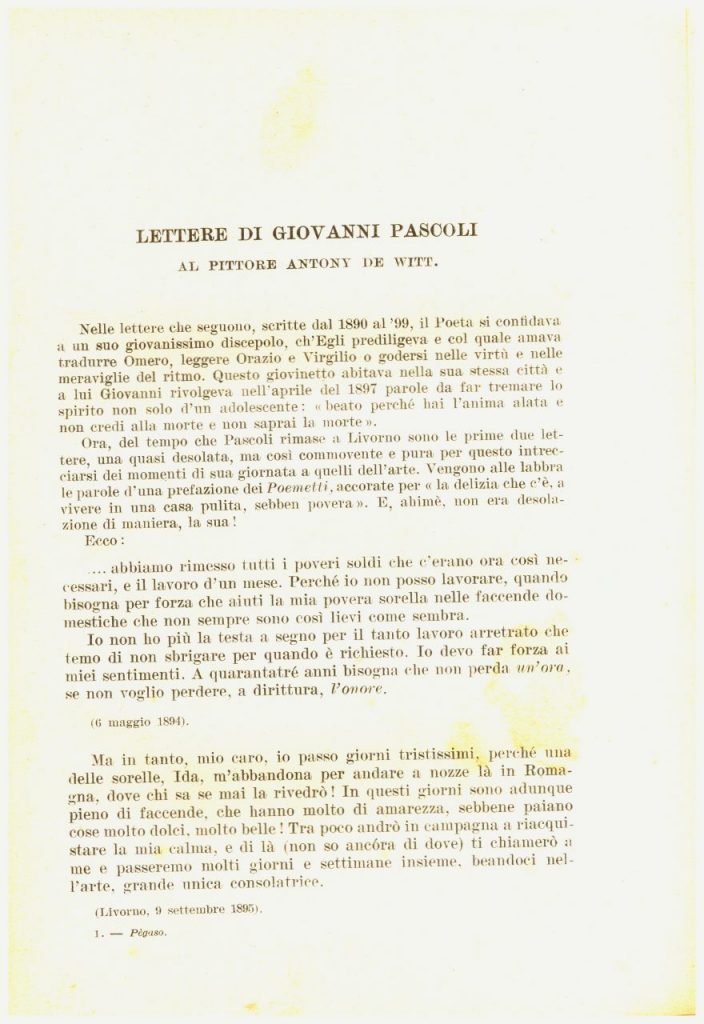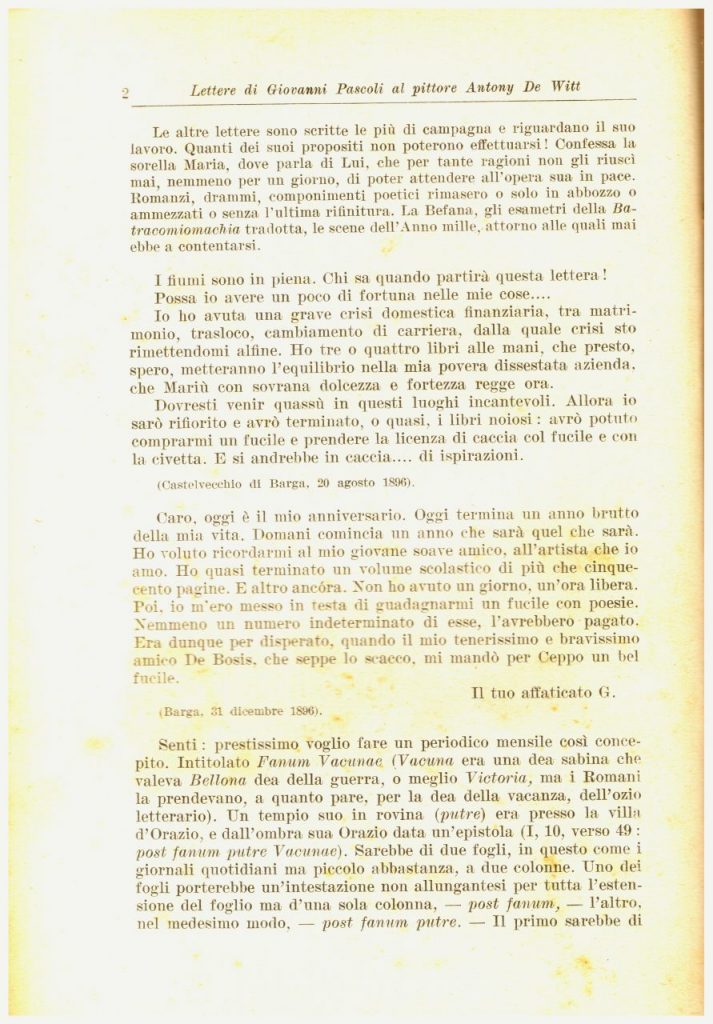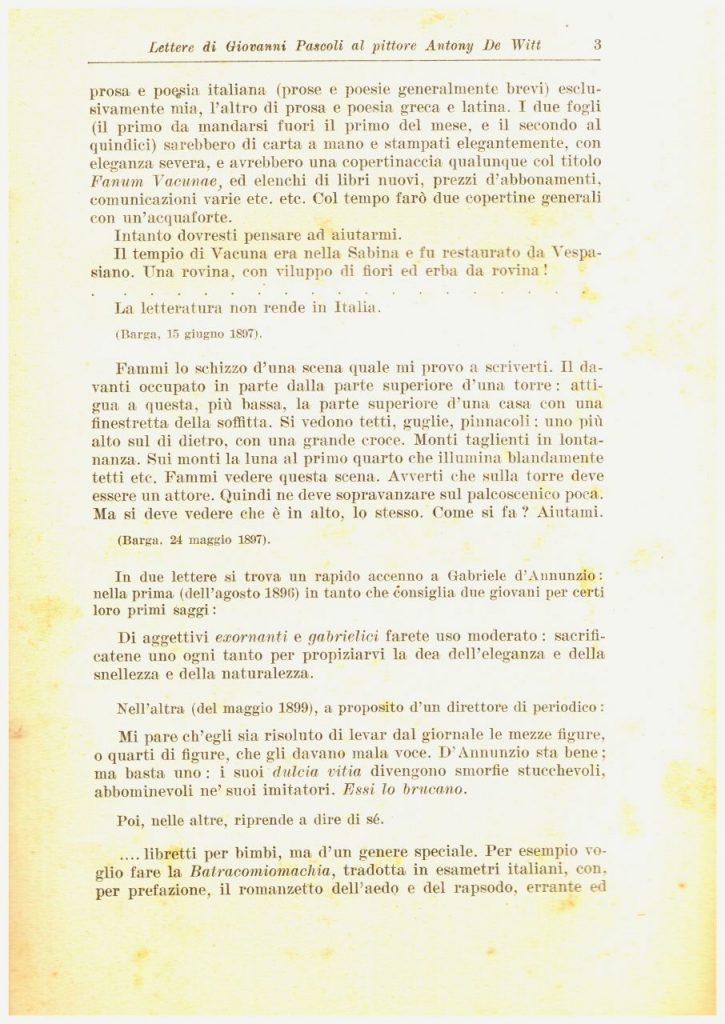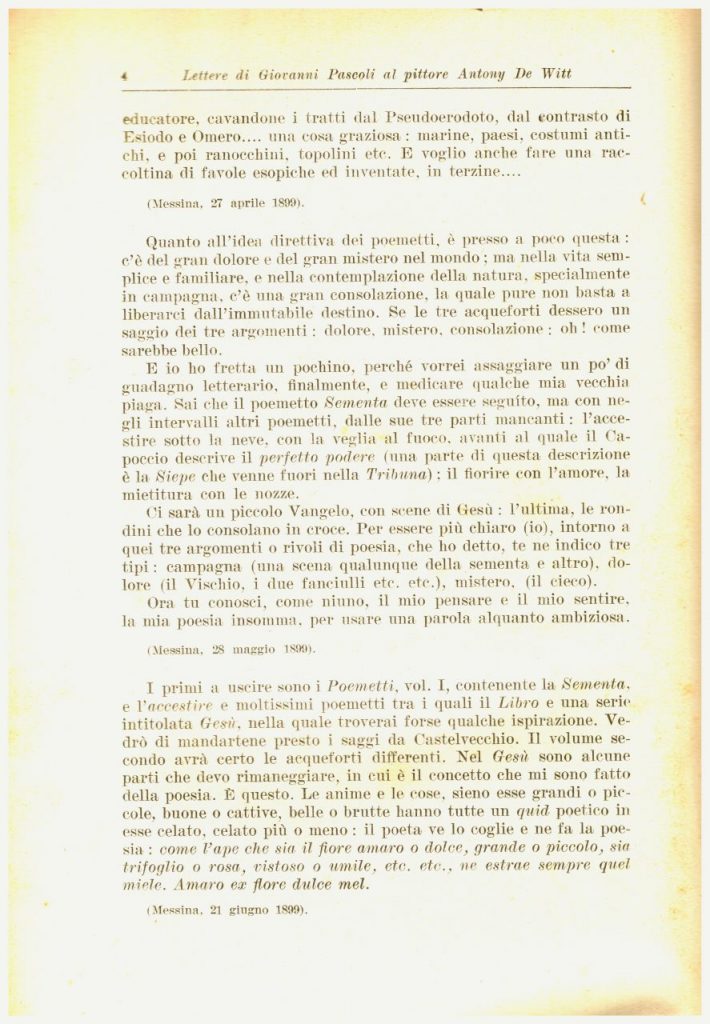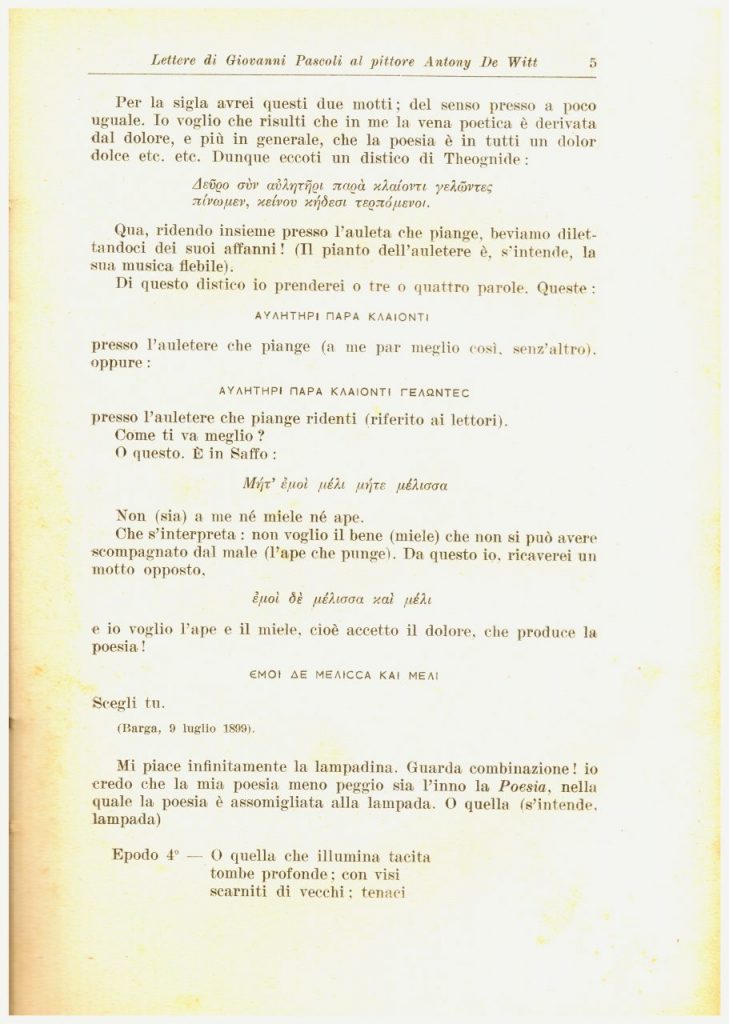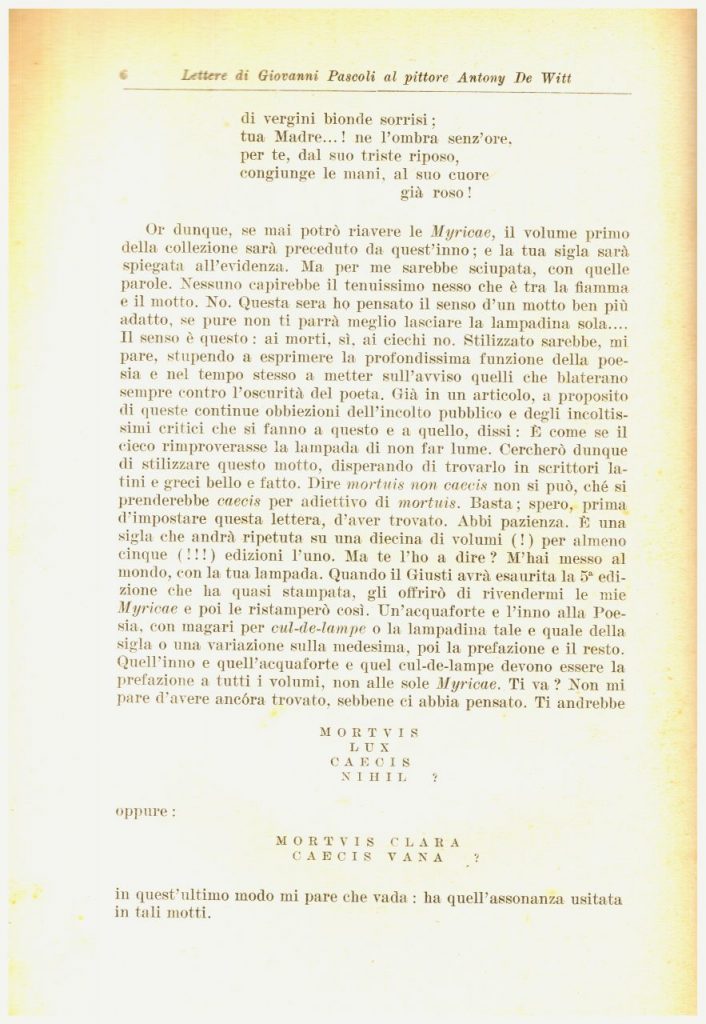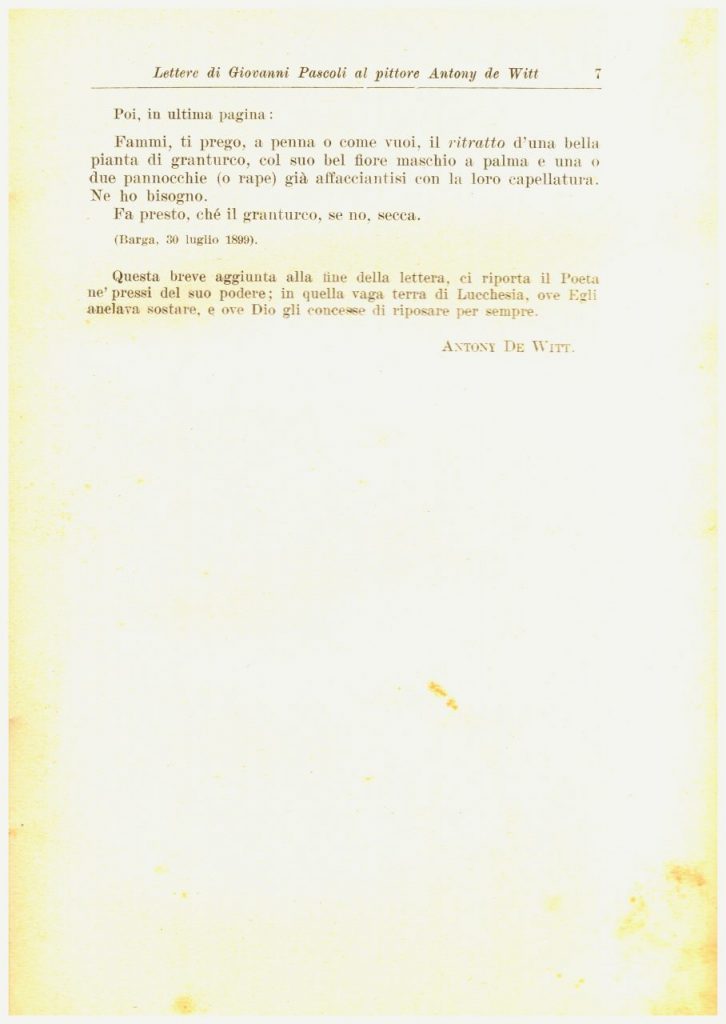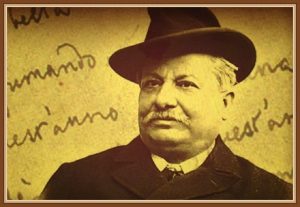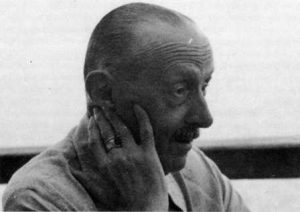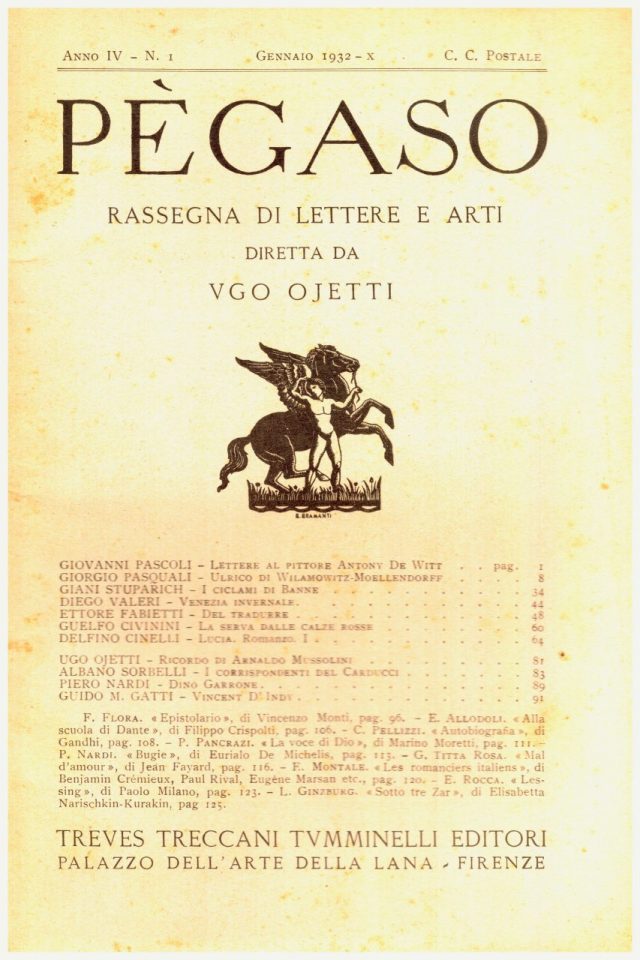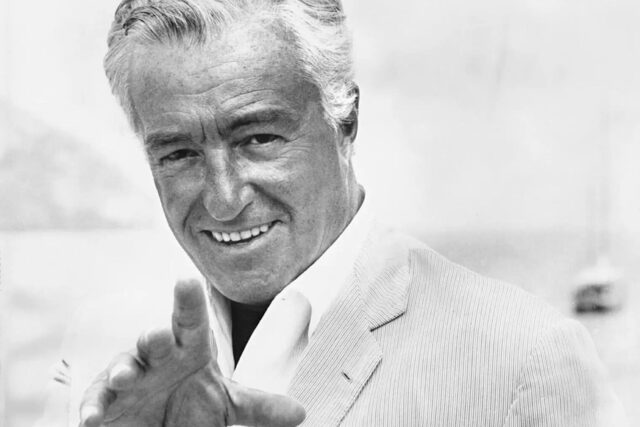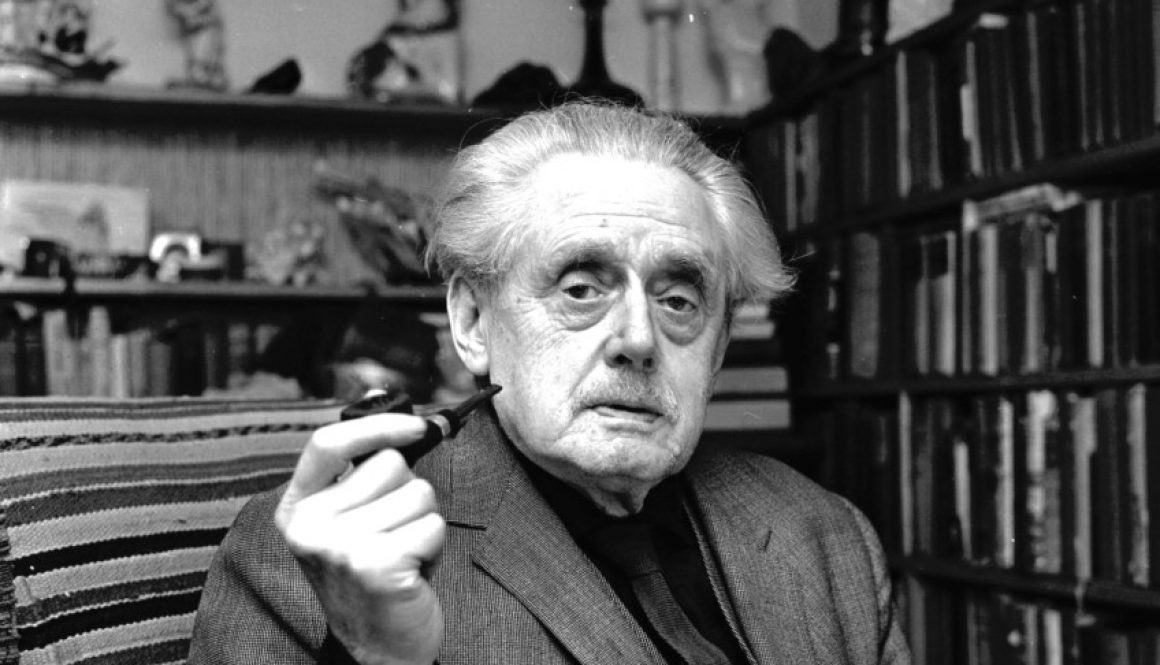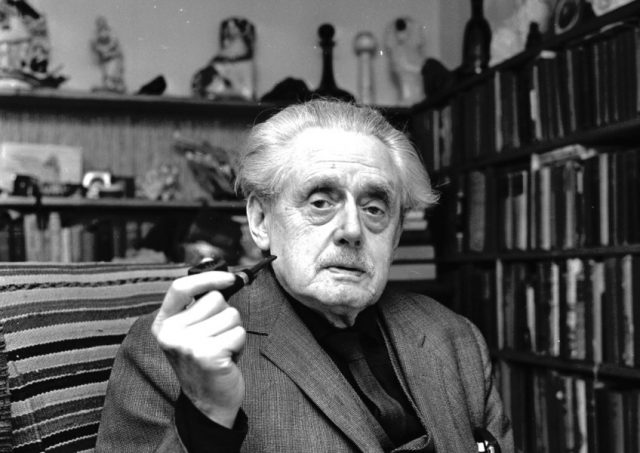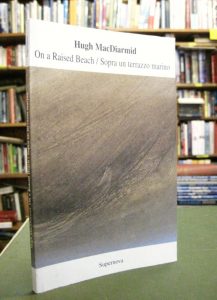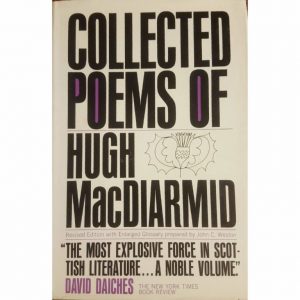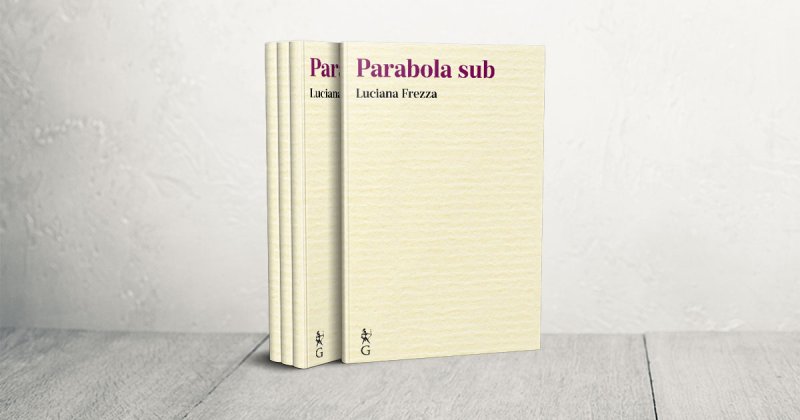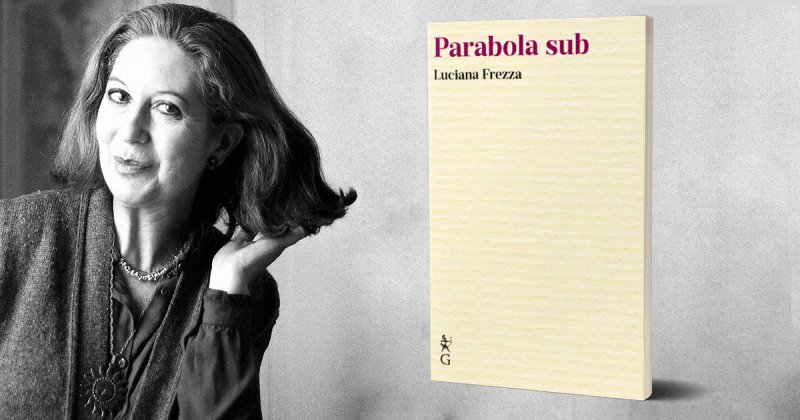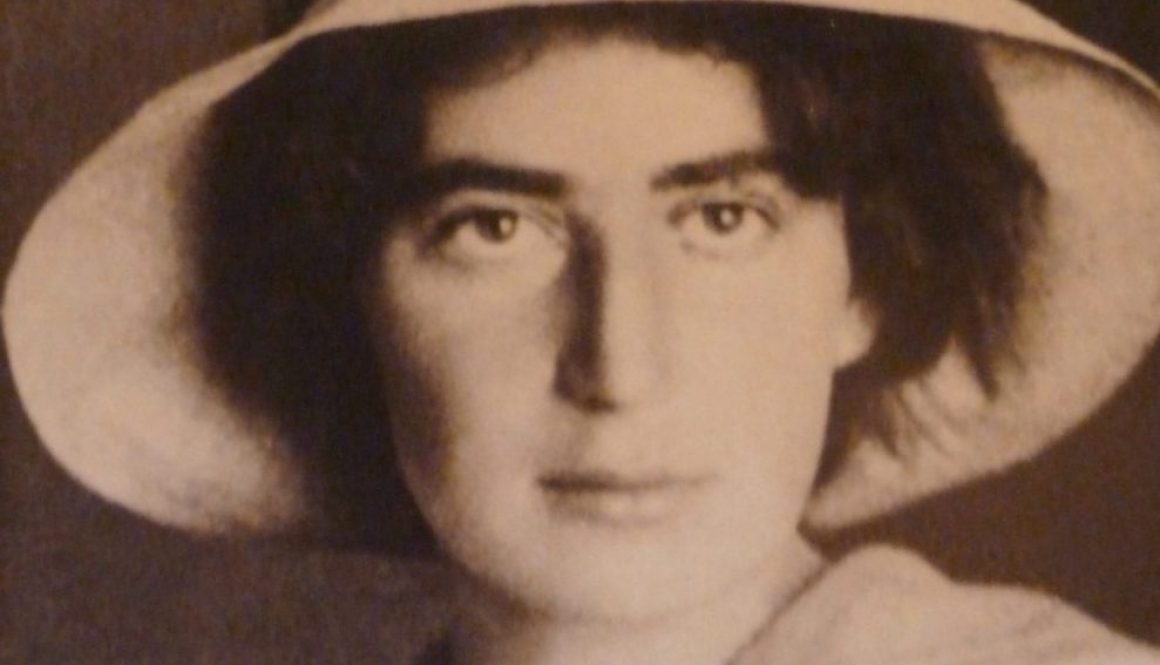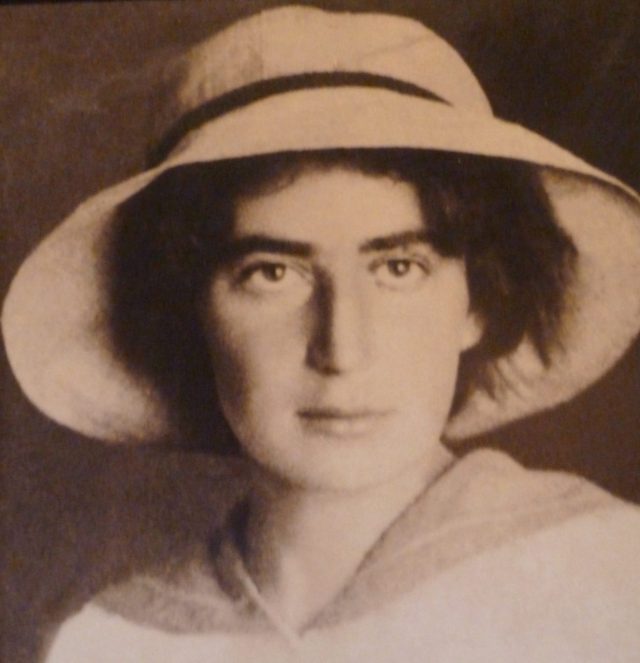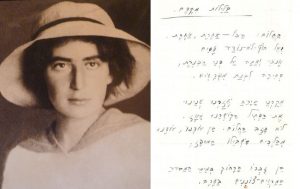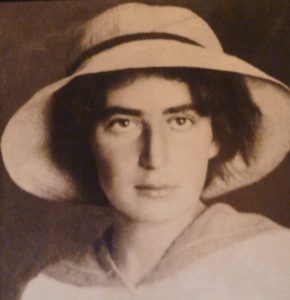Poemas de Maria do Rosário Pedreira- Poetessa e scrittrice portoghese-Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA

Poemas de Maria do Rosário Pedreira- Poetessa e scrittrice portoghese-
Maria do Rosário Pedreira è un’editrice, scrittrice, poetessa e paroliera portoghese. Laureata in Lingue e letterature moderne, con specializzazione in studi francesi e inglesi, ha insegnato per cinque anni negli anni ’80.Nel 1987 diventa editrice grazie all’impegno del prof. Antonio Manuel Baptista, iniziando questa attività nel campo dei libri di divulgazione scientifica.
Non c’è più nessun nome
Non c’è più nessun nome. Dopo di te
mi destinarono solo nomi che non amai,
volti sui quali non volli posare gli occhi per paura
di fissarli, mani che erano sempre l’ombra
delle tue mani sotto le lenzuola. Mai neanche le vidi
né toccai quelle dita che, nel buio, celebravano
nella mia la tua carne – se un altro motivo le portò,
per quanto vago, anche non volli udirlo, mai
lo seppi. Dopo di te, dopo gli altri uomini,
è ancora il tuo nome che dico. E nessun altro.
Lascia il tempo cadere sul tuo nome
Lasciai cadere il tempo sul tuo nome,
come si adagia il marmo sulla terra e
l’acqua si sparge sulle braci. Mi vestii
di lutto come le donne che disfano
le culle vuote da tanto le guardano; e vidi
il sangue scendere finalmente sulla ferita,
come la cera che si rapprende sul palmo della mano
prima di perdersi nelle dita in polvere. Se
ti dimenticai, fu perché volli qualcuno che mi
chiamasse, un corpo che fosse un altro sul mio
corpo, una voce offerta per la mattina. Ma
niente, ma nessuno. Se il tempo non si
fosse abbattuto sul tuo nome, avrei potuto
almeno ora ricordarti – poiché non c’è
lapide senza corpo né cenere che non abbia
arso. E la casa è oggi più fredda che
mai: lasciai passare il tempo sul tuo
nome, e non c’è focolare, non c’è nido, non ci sono
figli che si possano perdere da me, né
candele per riempire di memoria questo silenzio.
So chi sei, ma mi manca il tuo nome
So chi sei, ma mi manca il tuo nome – né
sempre le parole arrivano agli occhi. Ma
non dare importanza: ci sono altre cose che non
dimenticherò mai – le mie braccia ancorate al tuo
corpo, una cecità, e il mondo improvvisamente tanto
piccolo – e queste, tu non lo sai, mi mancano
anche. Il tuo volto, dammelo per un secondo, La
tua bocca, chiaro. Sono tanti gli anni senza te nelle pieghe
della mia gonna, tanta vita custodita per un giorno
così. Adesso ritorna, dunque. Lascia cadere quel sorriso
delle tue labbra, – nelle mie deve distendersi come
il sole, all’imbrunire, quando di nuovo sopra di loro
respirerai con il profumo salato delle maree. Ma
non dire niente del mio corpo stanco – è una camicia
d’estate dimenticata sulla spiaggia, e l’abito è sempre
il meno, tanto fa. Non vedi chi sono? Il tempo
non può aver castigato solo il mio sguardo. Vieni
più vicino e spia adagio: sono tanti gli anni
senza le tue braccia nelle maniche del mio vestito,
tanto sangue custodito nelle vene per una notte
così. E tu già te ne vai?
Fra noi c’è una ferita
Fra noi c’è una ferita che ormai non
sanguina, ma non si rimargina – un amore
che dura ancora ed è perso. Se rimaniamo
insieme, non vediamo mai passare la lamina
del tempo, ma diventiamo sempre
più vecchi di quando partimmo. Dicono
che ci sono bende e bavagli tra di noi,
ma sono tanti i lacci, tante le
fasciature, che mi domando perché si
allontanano gli occhi nel toccarsi, perché
solo dice il silenzio ciò che non dura. Non
ci sono parole possibili – fra di noi – il
vento è sempre più vento nella camicia
e il dolore più dolore nelle mani quando le
sciogliamo. Ma niente di questo conta, perché
gli occhi che ridono tanto nelle pieghe del
vestito sono i più tristi del mondo se
li guardiamo. So che mento quando
paragono ciò che la vita ci rubò a
ciò che ci ha dato; ma, se mi tocco e ormai non
sono un corpo, mi limito a indovinare
un nome per ciò che non sento e
mi rifiuto di credere che sia il tuo.

Ho messo un abito scollato
Ho messo un abito scollato e non so se ritorni,
ma le parole sono pronte sulle labbra come
segreti imperfetti o germogli di acqua custoditi per
l’estate. E, se di notte le ripeto in sordina, nel silenzio
della stanza, prima di addormentarmi, è come se all’improvviso
gli uccelli fossero già arrivati a sud e tu ritornassi
in cerca di questi antichi messaggi lavati dal tempo:
Andiamo a casa? Il sole dorme sui tetti la domenica
e c’è un intenso odore di lino sparso sui tetti.
Possiamo rivoltare i sogni al rovescio, dormire dentro
il pomeriggio
e lasciare che il tempo si occupi dei gesti più piccoli.
Andiamo a casa. Ho lasciato un libro aperto a metà sul
pavimento
della stanza, sono sole nella scatola le vecchie foto
del nonno, c’erano le tue mani strette con forza, quella
musica che eravamo soliti ascoltare d’inverno. E io voglio
rivedere
le nuvole ritagliate nelle finestre rosse del crepuscolo;
e voglio andare di nuovo a casa. Come le altre volte.
E così mi preparo per il sonno, notte dopo notte, dipanando la
lenta
matassa dei giorni per scontare l’attesa. E, quando la nidiata
allontanerà alla fine le ali della chiglia al suo primo volo,
di certo mi troverò ancora qui, ma potrò dire che, per lo
meno qualche volta, già inviai i messaggi, già dalla mia
bocca udii queste parole, che tu ritorni o non ritorni.
Non ho saputo il tuo nome
Non ho mai saputo il tuo nome. Entrasti un pomeriggio,
per sbaglio, a domandare se io ero un’altra persona –
un sole che improvvisamente aggiungeva calce ai muri,
un incendio capace di divorare il cuore del mondo.
Non ti mentii; mi alzai e ti condussi alla porta giusta
come un veliero trascina i sogni in mare; ma,
prima di lasciarti, ti dissi ancora che in quel pomeriggio
mi sarebbe piaciuto molto chiamarmi un’altra cosa – o
essere un gatto, per poter avere più di una vita.
Il cammino fino a te
È sempre stato così incerto il cammino fino a te:
tanti mesi di pietre e di spine, di
cattivi presagi, di rami che graffiavano la
carne come tridenti, di voci che mi
dicevano che non valeva la pena continuare, che
il tuo sguardo era già una menzogna; e il mio
cuore sempre così sordo a tutto questo,
sempre a gridare qualcos’altro più alto affinché
le gambe non potessero ricordare le
loro ferite, perché i piedi ignorassero
le pene del viaggio e avanzassero tutti
i giorni di un poco, quel poco che
era tutto per raggiungerti. Fu per questo che,
al contrario di te, non volli dormire quella
notte: i tuoi baci si trovavano ancora tutti
sulla mia bocca e il disegno delle tue mani
sulla mia pelle. Io sapevo che addormentarsi
era smettere di sentire, e non volevo perdere i
tuoi gesti sul mio corpo un secondo che
fosse. Allora mi sedetti sul letto a guardarti
dormire, e sorrisi come mai avevo sorriso prima
di quella notte, sorrisi tanto. Ma tu parlasti
improvvisamente nel sonno, allungasti il
braccio verso me e chiamasti sottovoce.
Chiamasti due volte. O tre. E sempre così
sottovoce. Ma nessuna fu per dire il mio nome.

A cosa mi è servito correre
A cosa mi è servito correre per tutto il mondo,
trascinare, di città in città, un amore
che pesava più di mille valigie; mostrare
a mille uomini il tuo nome scritto in mille
alfabeti e un’immagine del tuo volto
che io giudicavo felice? A cosa mi è servito
respingere questi mille uomini, e gli altri mille
che fecero di tutto perché mi fermassi, mille
volte pettinando le pieghe del mio vestito
stanco di viaggi, o dicendo il tuo nome
così bello in mille lingue che io mai
avrei compreso? Perché era solo dietro te
che correvo il mondo, era con la tua voce
nelle mie orecchie che io trascinavo il fardello
dell’amore di città in città, il tuo nome
sulle mie labbra di città in città, il tuo
volto nei miei occhi durante tutto il viaggio.
Si ricordava di lui
Si ricordava di lui e, per amore, anche se pensava
a un serpente, avrebbe detto solo un arabesco; e avrebbe nascosto
nella gonna il morso caldo, la ferita, l’impronta
di tutti gli inganni, avrebbe fatto quasi tutto
per amore: avrebbe dato il sonno e il sangue, la casa e la felicità,
e avrebbe custodito silenziosi i fantasmi della paura, che sono
i padroni delle piú grandi verità. Già un’altra volta aveva mentito
e per amore si sarebbe seduta alla tavola di lui
e avrebbe negato che lo amava, perché amarlo era un inganno
ancora piú grande che mentirgli. E, per amore, si mise
a disegnare il tempo come una linea stordita, sempre
al cadere di una pagina, a prolungare il mancato incontro.
E faceva stelle, anche se pensava alle croci;
arabeschi, anche se ricordava solo serpenti.
Non dire per cosa vieni.
Non dire per cosa vieni.
Lasciami indovinare
dalla polvere dei tuoi capelli
che vento ti ha mandato.
È lontana la … tua casa?
Ti do la mia:
leggo nei tuoi occhi la stanchezza del giorno che ti ha vinto;
e, sul tuo volto, le ombre mi raccontano il resto del viaggio.
Dai,
vieni a dar riposo ai tormenti del cammino
nelle curve del mio corpo
– è una meta senza dolore e senza memoria.
Hai sete?
Avanza dal pomeriggio solo una fetta d’arancia
– mordila nella mia bocca senza chiedere.
No, non dirmi chi sei né per che cosa vieni.
Decido io.
Paura dell’amore
Non aver paura dell’amore. Posa la tua mano
lentamente sul petto della terra e senti respirare
i nomi delle cose che lì stanno
crescendo: il lino e la genziana, la verzura odorosa
e le campanule blu; la menta profumata per
le bevande dell’estate e l’ordito delle radici di una
pianticella d’alloro che si organizza come un reticolo
di vene nella confusione di un corpo.
Mai la vita
è stata solo inverno.

Questa mattina
Questa mattina il sole è passato improvvisamente
dall’altra parte della via – sono così in ombra
le case quando di loro si perde il nome di
qualcuno, così scuri i cuori di quelli che
restano là dentro per abitare il dolore.

Maria do Rosário Pedreira (Lisbona , 21 settembre 1959) è un’editrice, scrittrice, poetessa e paroliera portoghese. Laureata in Lingue e letterature moderne, con specializzazione in studi francesi e inglesi, ha insegnato per cinque anni negli anni ’80.
Nel 1987 diventa editrice grazie all’impegno del prof. Antonio Manuel Baptista, iniziando questa attività nel campo dei libri di divulgazione scientifica.
Dal 1989 al 1998 è stata autrice della raccolta giovanile “Clube das Chaves”, con Maria Teresa Maia Gonzalez, pubblicandone 21 titoli. In seguito, nel 2000, ha pubblicato la raccolta giovanile “Detective Maravilhas”, con 17 volumi.
Cura attualmente autori come Nuno Camarneiro, Ana Cristina Silva, Vasco Luís Curado, Gabriela Ruivo Trindade, Norberto Morais, Nuno Amado, Cristina Drios, Carlos Campaniço, João Rebocho Pais e Paulo Moreiras.
Come scrittrice ha pubblicato diverse opere di narrativa, poesia, cronaca e letteratura giovanile, ricercando in quest’ultimo genere la trasmissione di valori umani e culturali. Per l’autrice, già premiata con alcuni premi letterari, la casa può essere considerata come un mondo dove tutto ciò che dura è contenuto, anche se sotto forma di memoria, con nostalgia.
È autrice di diversi testi musicali di fado, cantati da Carlos do Carmo, António Zambujo, Aldina Duarte, Ana Moura e, più recentemente, da Salvador Sobral.
Maria do Rosário Pedreira-Nació en Lisboa, Portugal, en 1959. Esta reconocida poeta, escritora y editora estudió Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad Clásica de Lisboa. En 1996 publicó su primer libro de poesía, A Casa e o Cheiro dos Livros, y desde entonces ha sido autora tanto de poesía como de novelas, literatura juvenil, ensayos, crónicas y letras para fado. Como editora, estuvo detrás del surgimiento de varios de los autores contemporáneos más destacados de Portugal, como José Luís Peixoto y Valter Hugo Mãe, y también publicó las colecciones de literatura juvenil O Clube das Chaves y Detective Maravilhas, las cuales han tenido una excelente acogida en Portugal. Entre sus libros publicados está su antología Poesía reunida, que en 2012 ganó el premio de literatura de la Fundación Inês de Castro.
Poemas de Maria do Rosário Pedreira

Arte poética
Num romance, uma chávena é apenas
uma chávena — que pode derramar
café sobre um poema, se o poeta,
bem entendido, for a personagem.
Num poema, mesmo manchado
de café, a chávena é certamente a
concha de uma mão — por onde eu
bebo o mundo em maravilha, se tu,
bem entendido, fores o poeta.
No nosso romance, não sou sempre
eu quem leva as chávenas para a mesa
a que nos sentamos à noite, de mãos
dadas, a dizer que a lata do café chegou
ao fim, mas a pensar que a vida é
que já vai bastante adiantada para os
livros todos que ainda pensamos ler.
No meu poema, não precisamos de café
para nos mantermos acordados: a minha
boca está sempre na concha da tua mão,
todos os dias há páginas nos teus olhos,
escreve-se a vida sem nunca envelhecermos.
Arte poética
En una historia, una taza es tan sólo
una taza, que puede derramar
café sobre un poema, si el poeta,
entiéndase bien, es el personaje.
En un poema, así esté manchado
de café, la taza es con seguridad el
cuenco de una mano; por donde yo
bebo el mundo en éxtasis si tú,
entiéndase bien, eres el poeta.
En nuestra historia, yo no soy siempre
quien lleva las tazas a la mesa
donde nos sentamos cada noche, enlazando
las manos, para comentar que la lata del café
se terminó, pero pensando que es la vida
la que ya ha avanzado mucho para los
libros que todavía quisiéramos leer.
En mi poema no necesitamos café
para mantenernos despiertos: mi
boca está siempre en el cuenco de tu mano,
todos los días hay páginas en tus ojos,
la vida se escribe y nunca envejecemos.
***
O meu mundo tem estado à tua espera; mas
não há flores nas jarras, nem velas sobre a mesa,
nem retratos escondidos no fundo das gavetas. Sei
que um poema se escreveria entre nós dois; mas
não comprei o vinho, não mudei os lençóis,
não perfumei o decote do vestido.
Se ouço falar de ti, comove-me o teu nome
(mas nem pensar em suspirá-lo ao teu ouvido);
se me dizem que vens, o corpo é uma fogueira —
estalam-me brasas no peito, desvairadas, e respiro
com a violência de um incêndio; mas parto
antes de saber como seria. Não me perguntes
porque se mata o sol na lâmina dos dias
e o meu mundo continua à tua espera:
houve sempre coisas de esguelha nas paisagens
e amores imperfeitos — Deus tem as mãos grandes.

***
Mi mundo ha estado esperándote; pero
no hay flores en los jarrones, ni velas sobre la mesa,
ni retratos escondidos al fondo de los cajones. Sé
que un poema se escribiría entre nosotros dos; pero
no compré el vino, no cambié las sábanas,
no perfumé el escote del vestido.
Si oigo hablar de ti, me conmueve tu nombre
(pero ni pensar en suspirarlo a tu oído);
si me dicen que vienes, el cuerpo es una hoguera:
me crepitan brasas en el pecho, trastornadas, y respiro
con la violencia de un incendio; pero parto
antes de saber cómo sería. No me preguntes
por qué el sol se mata en el filo de los días
y mi mundo continúa esperándote:
siempre hubo cosas de soslayo en los paisajes
y amores imperfectos; Dios tiene las manos grandes.
Fado
Dizem os ventos que as marés não dormem esta noite.
Estou assustada à espera que regresses: as ondas já
engoliram a praia mais pequena e entornaram algas
nos vasos da varanda. E, na cidade, conta-se que
as praças acoitaram à tarde dezenas de gaivotas
que perseguiram os pombos e os morderam.
A lareira crepita lentamente. O pão ainda está morno
à tua mesa. Mas a água já ferveu três vezes
para o caldo. E em casa a luz fraqueja, não tarda
que se apague. E tu não tardes, que eu fiz um bolo
de ervas com canela; e há compota de ameixas
e suspiros e um cobertor de lã na cama e eu
estou assustada. A lua está apenas por metade,
a terra treme. E eu tremo, com medo que não voltes.
Fado
Dicen los vientos que las mareas no duermen esta noche.
Estoy asustada esperando que regreses: las olas ya
se tragaron la playa más pequeña y derramaron algas
en las macetas del balcón. Y, en la ciudad, se cuenta que
la plazas acogieron por la tarde a decenas de gaviotas
que persiguieron a las palomas y las mordieron.
La chimenea crepita lentamente. El pan todavía está tibio
en tu mesa. Pero el agua ha hervido ya tres veces
para el caldo. Y en casa la luz se debilita, no tardará
en apagarse. Y tú no tardes, que hice una tarta
de hierbas con canela; y hay mermelada de ciruelas
y merengues y una manta de lana en la cama y yo
estoy asustada. Sólo está la mitad de la luna,
la tierra tiembla. Y yo tiemblo, temiendo que no vuelvas.

***
Mãe, oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão:
com o menino ao colo, fez-se a estrada maior do
que o meu desespero, amarrotou-se de velho meu
coração tão claro. Eu tinha catorze anos antes
do estrondo, catorze anos e meio antes do teu
grito, quinze anos cumpridos quando afastei o
véu dos teus cabelos: se me dizias sempre que não
fosse para longe, porque pediam o contrário os
teus olhos parados? Ainda por cima, mãe, chegar
ao campo foi como bater a uma porta cansada –
mil tendas que eram velas remendadas, barcos para
ficar de novo pelo caminho. Trouxeram-nos mantas
cheias de perguntas; tentaram-me com doces
para me pôr no lugar; mudaram ao meu irmão
a fralda com as mãos frias. Mãe, eu disse-lhes que
o menino era meu; e agora, quando ele procura os
teus seios no meu corpo sem formas, cubro com
o teu véu os meus cabelos e canto-lhe baixinho
canções de açúcar. Não sei que idade tenho, mãe,
mas oxalá eu nunca tivesse largado a tua mão.
***
Madre, ojalá yo nunca hubiera soltado tu mano:
con el niño en brazos, se hizo el camino más largo
que mi desesperación, se arrugó de viejo mí
corazón tan claro. Yo tenía catorce años antes
del estruendo, catorce años y medio antes de tu
grito, quince años cumplidos cuando alejé el
velo de tus cabellos: si me decías siempre que no
me alejara, ¿por qué pedían lo contrario
tus ojos parados? Además, madre, llegar
al campo fue como llamar a una puerta cansada;
mil tiendas que eran velas remendadas, barcos para
quedarse de nuevo por el camino. Nos trajeron cobijas
llenas de preguntas; me tentaron con dulces
para ponerme en mi lugar; con las manos frías
le cambiaron el pañal a mi hermano. Madre, yo les dije que
el niño era mío; y ahora, cuando él busca
tus senos en mi cuerpo sin formas, cubro con
tu velo mis cabellos y le canto bajito
canciones de azúcar. No sé qué edad tengo, madre,
pero ojalá yo nunca hubiera soltado tu mano.