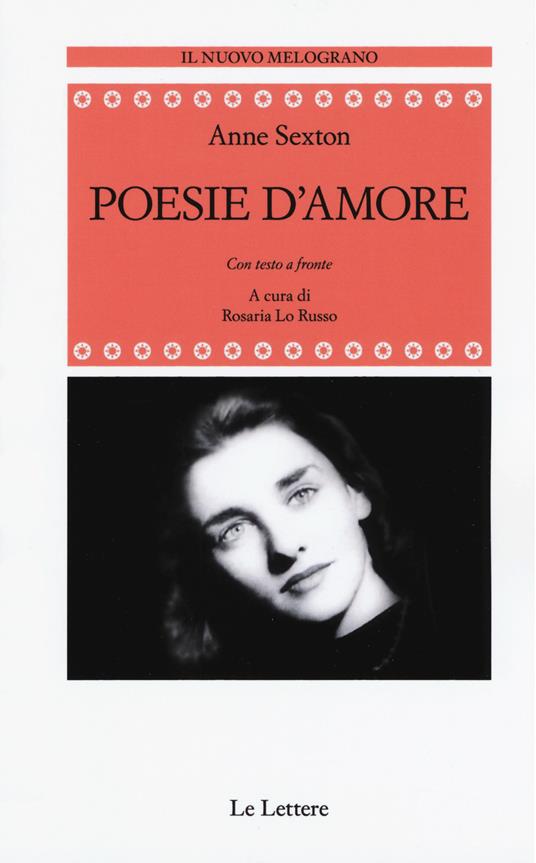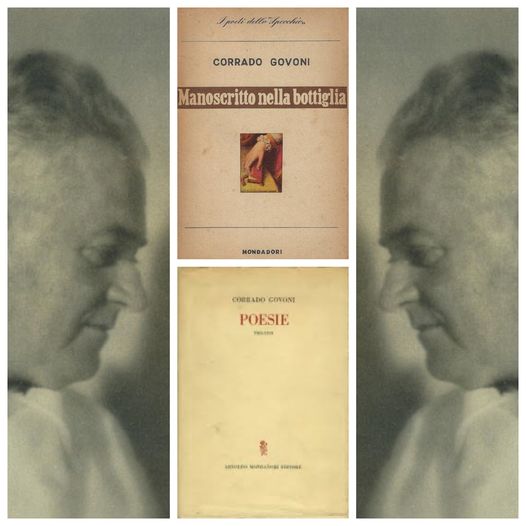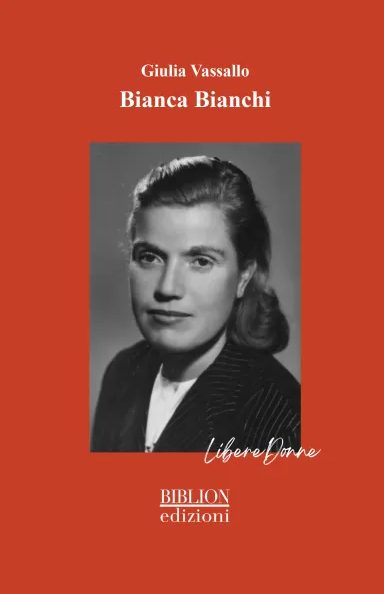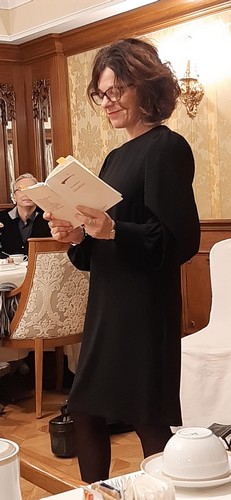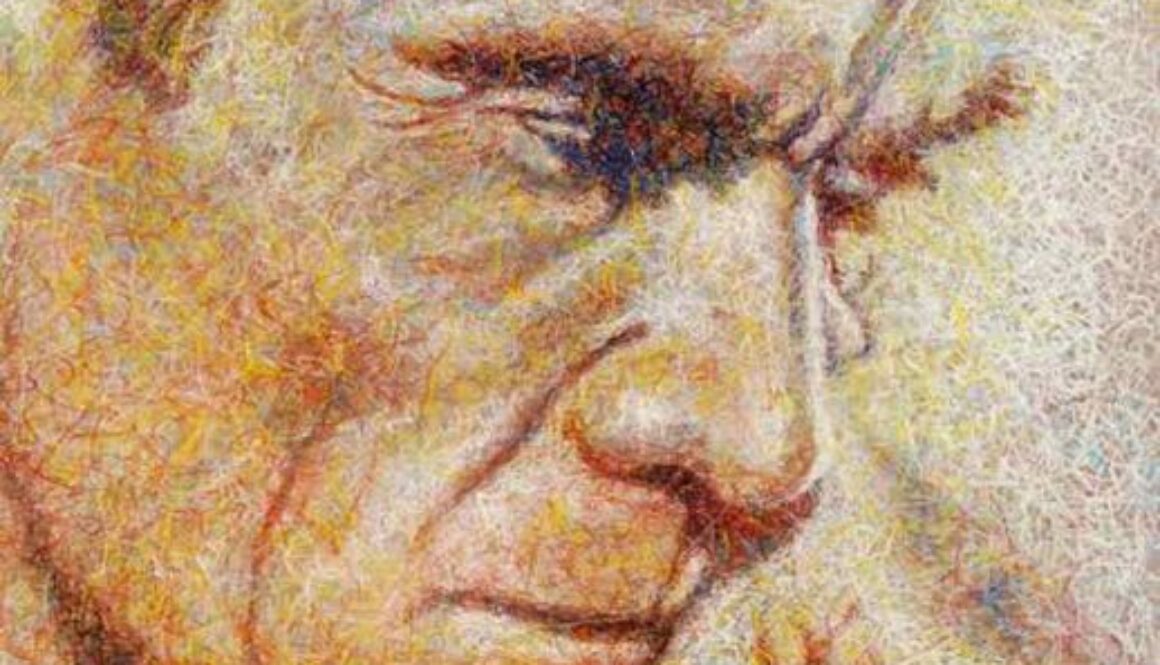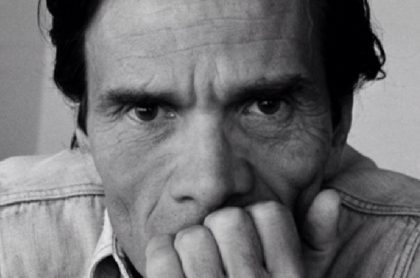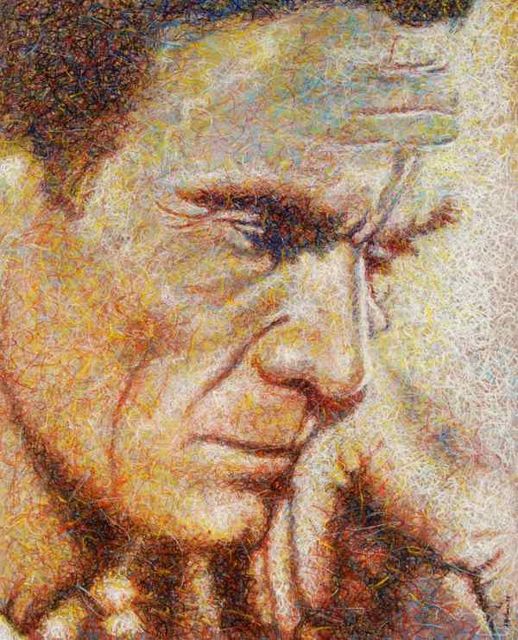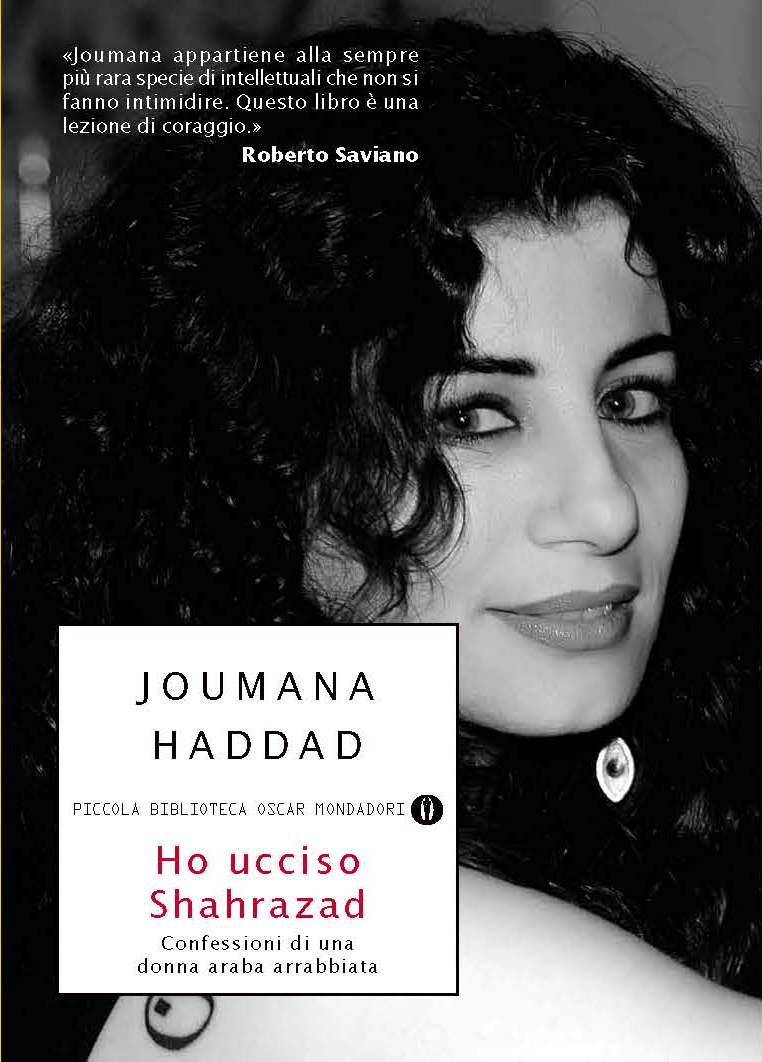Abbazia di FARFA -“𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮”-a cura di 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗲𝘀𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼, 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 e 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼-Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA-
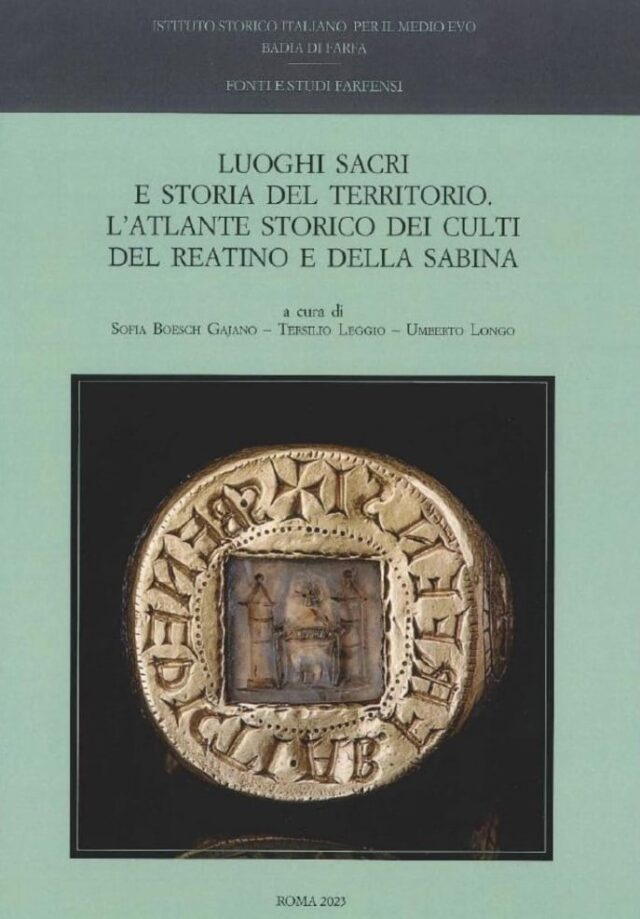
Abbazia di FARFA -“𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮”,
a cura di 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗲𝘀𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼, 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 e 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼
Descrizione -“𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮”, 𝗽𝗿𝗼𝗳.𝘀𝘀𝗮 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗲𝘀𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼: “𝗦𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗼𝗴𝗻𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲, 𝘀𝗰𝘂𝗼𝗹𝗮 𝗲 𝗽𝗮𝗿𝗿𝗼𝗰𝗰𝗵𝗶𝗮 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝘇𝗶 𝗹’𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗺𝘂𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼!”a cura di 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗲𝘀𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼, 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 e 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼

Il volume “Luoghi sacri e storia del territori. L’Atlante storico dei culti del reatino e della Sabina” a cura di 𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗲𝘀𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼, 𝗧𝗲𝗿𝘀𝗶𝗹𝗶𝗼 𝗟𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 e 𝗨𝗺𝗯𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼, è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coniuga gli studi e la ricerca storica, artistica e cultuale alla tecnologia digitale. Al contempo rappresenta il proseguo di un più ampio progetto – Fonti e studi farfensi – sostenuto dall’𝗜𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗼 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗠𝗲𝗱𝗶𝗼 𝗘𝘃𝗼 e dalla 𝗕𝗮𝗱𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗮𝗿𝗳𝗮.
𝗦𝗼𝗳𝗶𝗮 𝗕𝗼𝗲𝘀𝗰𝗵 𝗚𝗮𝗷𝗮𝗻𝗼, che ha insegnato Storia medievale nelle Università La Sapienza, Siena, L’Aquila e Roma Tre, ha tracciato un profilo del lavoro offrendo spunti interessanti per capire il valore sia dell’opera cartacea sia della piattaforma online 𝗔𝗦𝗖𝗥𝗲𝗦 (𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮): risultato informatico che poggia sulla precedente ricerca scientifica, i cui dati sono stati digitalizzati da esperti del settore facenti capo alla Sapienza Università di Roma.

“L’idea è nata per impulso di un finanziamento venuto dal professore 𝗔𝗻𝗱𝗿𝗲́ 𝗩𝗮𝘂𝗰𝗵𝗲𝘇 – spiega la prof.ssa Boesch Gajano -. Vorrei porre attenzione su questo importante preliminare aspetto per far capire che il lavoro è frutto di una collaborazione che va al di là dei nostri tre nomi, al di là delle istituzioni italiane, universitarie e locali.
Venuto a conoscenza delle iniziative del Centro Europeo di Studi Agiografici (CESA) con sede a Rieti, il prof. Vauchez, vincitore del premio Balzan 2013, ci propose un finanziamento per una ricerca legata a questi luoghi. Un’occasione straordinaria che, insieme a Tersilio Leggio e Umberto Longo, abbiamo colto mettendo a frutto delle ricerche pregresse, per sviluppare l’idea dell’Atlante Storico dei Culti del Reatino e della Sabina (ASCReS), di cui questo volume è il corredo a stampa. Un grande lavoro digitale: durato quasi due anni e affidato alle cure di un’equipe di studiosi e docenti della Sapienza Università di Roma.
Nonostante tutto, la carta stampata ha ancora un suo senso, ossia un suo pubblico: così abbiamo deciso di lasciare una traccia scritta del lavoro svolto per lo sviluppo dell’Atlante. A mio avviso la cosa interessante del progetto è quella di aver tentato un rapporto organico tra la ricerca storica sulle fonti e lo strumento informatico che in questo caso ha avuto la giusta pretesa di non essere soltanto un appoggio cioè un mezzo di divulgazione dei dati raggiunti ma anche uno strumento di ricerca e di possibili ulteriori ricerche.
Dopo diversi incontri con gli esperti, ho appurato che l’aspetto informatico costringe a mettere a fuoco tutta una serie di elementi: cosa, per esempio, si intende per luogo di culto attraverso una precisa definizione terminologica. Penso che si sia creato un punto di riferimento importante per questi territori.

Personalmente ho maggiormente seguito la ricerca storica e storico-artistica che ha dato frutti interessanti: il saggio sui culti di 𝗦𝘁𝗲𝗳𝗮𝗻𝗶𝗮 𝗔𝗻𝘇𝗼𝗶𝘀𝗲 e quello sulla Storia dell’Arte di 𝗘𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗢𝗻𝗼𝗿𝗶. Credo che in entrambi si siano fatte accurate ricerche che hanno arricchito il campo d’indagine all’interno di un vasto e variegato territorio, che oggi può beneficiare di uno strumento che permette di conoscere una rete di luoghi sacri, in ognuno dei quali sono stati rintracciati oggetti di culto e devozione che non erano noti.
Il volume segna un passo in avanti, perché poggia su un lavoro che intreccia aspetti storico religiosi con la storia del territorio di cui Tersilio Leggio è maestro, e al quale va il merito di aver inserito il territorio sabino e reatino all’interno di una grande storia che travalica confini netti e precisi. Tra questi due campi emergono interazioni interessanti: soprattutto i rapporti con altri territori limitrofi e le loro trasformazioni nel tempo.
Per me, che ho una limitata conoscenza di tipo informatico, è stata una bella esperienza capire la materia attraverso i saggi di Saverio Malatesta e di Massimiliano Vassalli: validi riferimenti per creare un rapporto fra la ricerca umanistica e quella informatica, estendibile ad altri campi.
Per quanto riguarda la fruizione del sito ASCRES è strutturato per essere accessibile a tutti: i giovani digitali sono senz’altro agevolati; i meno giovani possono trovare nel volume cartaceo un valido aiuto per navigare. Il mio auspicio è che non solo agli studiosi di professione ma ad ogni Comune, scuola, parrocchia del territorio sabino e reatino, sia data la possibilità di connettersi per utilizzare l’Atlante, che oltre a divulgare conoscenza scientifica – sfatando o integrando una serie di leggende – può essere un luogo di promozione culturale e turistica”.
Le riflessioni della prof.ssa Boesch Gajano invitano a sfogliare i frutti di un lungo lavoro di ricerche sulla storia del territorio sabino. Tra questi: “𝗖𝗼𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗻𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗶𝗶 𝗙𝗮𝗿𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘀” a cura di Umberto Longo, “𝗟’𝗔𝗯𝗯𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗔𝗹𝘁𝗼𝗺𝗲𝗱𝗶𝗲𝘃𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗶𝗰𝗮. 𝗜𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗙𝗮𝗿𝗳𝗮” a cura di Stefano Manganaro, “𝗔𝗹𝗹𝗲 𝗼𝗿𝗶𝗴𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗻𝗮𝗰𝗵𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗶𝗻 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮” di Tersilio Leggio, “𝗜𝗹 𝗦𝗮𝗻𝘁𝘂𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗦. 𝗠𝗶𝗰𝗵𝗲𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗧𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮. 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝗰𝗰𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗹𝘂𝗼𝗴𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼” a cura di T. Canella e U. Longo, “𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗩𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮. 𝗟𝗮 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝗿𝗲, 𝗶𝗹 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗲 𝗹𝗲 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁𝗮̀ 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶” a cura di Elena Onori, e naturalmente “𝗟𝘂𝗼𝗴𝗵𝗶 𝘀𝗮𝗰𝗿𝗶 𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗲𝗿𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶. 𝗟’𝗔𝘁𝗹𝗮𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝘂𝗹𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝗮𝗯𝗶𝗻𝗮” a cura di Sofia Boesch Gajano, Tersilio Leggio e Umberto Longo.
Sulla piattaforma 𝗔𝗦𝗖𝗥𝗘𝗦 (http://ascres.uniroma1.it/ ) basta fare un click per avventurarsi nella ricerca, senza dimenticare il valore e il piacere della carta che offre contenuti e quindi parole da digitare: un maggiore bagaglio storico, culturale e cultuale con il quale navigare!