Alessandro Sacchi-UN PROGETTO GLOBALE DI LIBERAZIONE- Paolo di Tarso interpella la chiesa di Roma- Biblioteca DEA SABINA
Biblioteca DEA SABINA
Alessandro Sacchi-UN PROGETTO GLOBALE DI LIBERAZIONE- Paolo di Tarso interpella la chiesa di Roma-
Descrizione del libro di Alessandro Sacchi-La lettera inviata da Paolo ai cristiani di Roma è forse il documento che più ha influito non solo sull’autocoscienza cristiana ma anche sulla cultura europea. In essa l’Apostolo approfondisce i valori della fede, dell’amore e della speranza, sui quali si basa un progetto di liberazione che coinvolge non solo una comunità religiosa ma tutta la società. Oggi appare più che mai necessario cogliere soprattutto il messaggio di speranza che Paolo ci ha lasciato, perché da esso dipende la possibilità stessa di immagine un futuro migliore per il quale vale la pena impegnarsi.
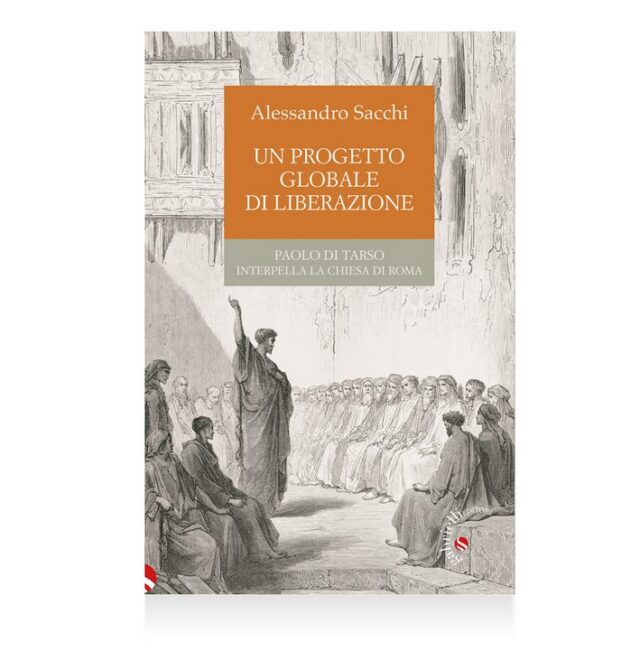
PREFAZIONE
Soprattutto però la lettura e la comprensione del testo paoli- no risultano particolarmente difficili in quanto Paolo è vissuto in un tempo per noi remoto e in un contesto storico-culturale molto diverso dal nostro. Egli infatti condivide con il mondo bi- blico e con tutto il mondo antico una visione mitologica secondo cui le sorti di questo mondo si decidono in un ambito superiore, abitato da una o più divinità e/o da esseri appartenenti alla sfe- ra divina. È in questo mondo superiore che si cerca, mediante racconti di carattere mitologico, la spiegazione delle origini di questo mondo e di quanto capita in esso. Oggi invece, in forza della mentalità scientifica ormai invalsa nel mondo moderno, si è portati a ricercare la spiegazione degli eventi di questo mondo risalendo alle loro cause, senza fare riferimento a entità superiori.
Per queste ragioni un semplice lavoro di esegesi difficilmente potrà aiutare il lettore moderno ad apprezzare il contributo che Paolo ha dato al pensiero religioso e anche a rendersi conto dei malintesi di cui è stato occasione. Se si vuole che il suo scritto dica qualcosa all’uomo moderno, è necessario ricostruire il suo ambiente d’origine, l’eredità che Paolo ha ricevuto dalla prima generazione cristiana circa la figura di Gesù, lo scontro che ha sostenuto con i sostenitori di altre interpretazioni del nascente cristianesimo, prima fra tutte quella dei giudaizzanti che faceva capo addirittura alla chiesa di Gerusalemme; inoltre non bisogna dimenticare che la cultura greca, in cui Paolo era immerso, ha esercitato un notevole influsso sul suo pensiero. Infine è necessa- rio tener presente che lo scopo della sua lettera non è dottrinale ma pastorale e quindi tende non tanto a formulare tesi accade- miche quanto piuttosto a risolvere problemi contingenti alla luce della fede comune.
Tenendo conto di queste difficoltà, mi sono proposto di non fare semplicemente un commento esegetico alla lettera e neppu- re entrare nel dibattito su singoli punti dello scritto. Lo scopo che mi sono prefisso è invece quello di situare la lettera all’in- terno del tessuto culturale in cui ha avuto origine e di proporne una rilettura che tenga presente le istanze del mondo moderno. A tal fine, ho ritenuto opportuno abbandonare la forma solita del commento che segue rigidamente la successione dei testi. Mi è sembrato più utile invece raggruppare i brani in cui si affronta
PREFAZIONE – 15
prevalentemente lo stesso tema in modo da esaminarne lo sfon- do culturale e i rapporti con la più antica tradizione riguardante Gesù di Nazaret, al fine di metterne in luce le implicazioni per i credenti di oggi. Quando si tratta di passaggi controversi, scelgo l’interpretazione che mi sembra più probabile, accennando ma- gari a una possibile alternativa o indicando in nota una fonte di ulteriore documentazione.
Nel c. I del volume presento il contesto storico-culturale della lettera. In esso abbozzo anzitutto una sintesi della storia e del- la letteratura biblico-giudaica, presentando poi i vangeli sinotti- ci, nei quali sono riportate le più antiche tradizioni riguardanti Gesù di Nazaret, e i momenti più salienti dell’attività di Paolo prima dell’invio della lettera. Naturalmente in questo primo ca- pitolo darò semplici indicazioni che il lettore potrà approfondire facendo ricorso alle fonti da me indicate e alle informazioni che attualmente si possono recuperare senza difficoltà anche in inter- net. Ciò vale soprattutto per la letteratura giudaica di cui certa- mente molti lettori sono all’oscuro.
Nel c. II affronterò più direttamente l’origine e i contenuti della lettera, tenendo conto delle informazioni che Paolo stesso fornisce nella cornice (prologo ed epilogo) della lettera stessa. Seguono due capitoli (cc. III e IV) nei quali delineo l’immagine di Dio e della legge mosaica a cui rispettivamente Paolo e Gesù si riferiscono sullo sfondo delle concezioni tipiche del mondo biblico-giudaico, con qualche riferimento alla cultura ellenistica. A questo punto affronterò il tema nevralgico del peccato (c. V); successivamente, dopo un capitolo riservato alla figura di Gesù nel cristianesimo primitivo(c. VI), esaminerò il tema della giu- stificazione mediante la fede (c. VII). Negli ultimi tre capitoli metterò a fuoco rispettivamente il pensiero di Paolo circa la vita secondo lo Spirito (c. VIII), la sua riflessione sul mistero di Israe- le (c. IX) e infine le esortazioni riguardanti la vita quotidiana dei credenti (c. X). Come conclusione tenterò una breve sintesi del messaggio della lettera all’interno di una cultura, la nostra, che non è più quella del suo autore (c. XI).
Al termine del volume riporto una bibliografia nella quale sono elencati per esteso i titoli delle opere citate nel testo. Per lo scopo che mi prefiggo, faccio riferimento quasi esclusivamente a
16 – PREFAZIONE
scritti in lingua italiana, nei quali il lettore può trovare la fonte di una particolare interpretazione oppure strumenti che aiutino ad approfondire un tema o un concetto specifico. Nelle note a piè di pagina mi limito a indicare in modo abbreviato i titoli delle ope- re utilizzate. Gli articoli che fanno parte di una raccolta di scritti dello stesso autore saranno segnalati solo in nota con il riferimen- to alla fonte da cui sono ripresi, il cui titolo è citato per esteso nella bibliografia. Alcune opere utilizzate in questo volume sono reperibili anche in internet: mi limito a segnalarle, lasciando al lettore il compito di ritrovarle facendo uso dei normali motori di ricerca. Per il testo della lettera mi servirò della traduzione uffi- ciale della CEI (2008), segnalando eventuali divergenze di inter- pretazione.
Per le sue caratteristiche, questo lavoro è rivolto soprattutto a quanti affrontano per la prima volta lo studio della lettera ai Ro- mani e non hanno ancora una sufficiente conoscenza della cul- tura e della letteratura biblico-giudaica di cui essa fa parte: non solo quindi agli studenti dei seminari e degli Istituti di scienze re- ligiose e ai catechisti, ma anche a tutti coloro che sono interessati a una lettura critica della Bibbia.
- CONTESTO STORICO-CULTURALE
La lettera ai Romani è uno scritto che nasce all’interno della religione e della cultura giudaiche, in quanto sia il mittente che i destinatari facevano parte di un movimento che, nel giudaismo, si rifaceva a Gesù di Nazaret, riconosciuto come il Messia (Cri- sto) annunziato dai profeti. Per questo i suoi seguaci sono stati chiamati «cristiani» (cfr. At 11,26), un appellativo che è stato at- tribuito loro per designare non l’appartenenza a una diversa re- ligione ma semplicemente l’adesione a un gruppo giudaico nel quale le Scritture ebraiche erano lette alla luce dell’insegnamento di Gesù, considerato come il Messia (gr. Cristo) di Israele.
Per affrontare in modo fruttuoso lo studio di questo antico documento è necessario perciò anzitutto avere un’adeguata co- noscenza del giudaismo, che ai tempi di Paolo non si presen- tava ancora come una realtà omogenea, ma raccoglieva nel suo seno numerosi movimenti con caratteristiche diverse e a volte contrastanti. Siccome sia Paolo che i destinatari della sua let- tera si rifacevano all’insegnamento di Gesù, è anche necessa- rio conoscere i tratti caratteristici della sua persona come sono stati ricordati e trasmessi dai suoi primi discepoli. Infine è op- portuno indicare qual è stato il percorso che ha portato Paolo, all’interno di un’intensa attività come propagatore del vangelo di Gesù, a elaborare le idee che esprime nella sua lettera ai Ro- mani, l’ultima delle sette che, secondo la critica moderna, sono sicuramente autentiche (1Tessalonicesi, 1-2 Corinzi, Filippesi, Galati, Filemone, Romani).
- Le origini del giudaismo
Nella Bibbia l’origine di quella realtà etnica, politica e religiosa chiamata giudaismo viene fatta risalire a un gruppo di pastori se- minomadi che riconoscevano come loro progenitore, Giacobbe, chiamato anche Israele, i cui discendenti si chiamavano perciò
18 – I. CONTESTO STORICO-CULTURALE
«figli d’Israele»1. A essi veniva attribuito anche, specialmente da stranieri, il nome di «ebrei». Il nome «giudei» subentra invece in un periodo successivo, determinato dalle vicende storiche di questo popolo.
- Il periodo monarchico
Nella Bibbia ebraica si racconta che Giacobbe era nipote di Abramo, che da Ur dei Caldei, in Mesopotamia, era emigrato con i suoi greggi nella terra di Canaan, una regione attualmente chia- mata Palestina2, che Dio aveva promessa a lui e ai suoi discendenti. Giacobbe, con i suoi dodici figli, era disceso in Egitto a motivo di una carestia; lì i suoi figli si erano moltiplicati e avevano dato ori- gine a dodici tribù. Il loro sviluppo però aveva suscitato i timori degli egiziani, che li avevano ridotti in schiavitù; il loro Dio però era intervenuto in loro aiuto e li aveva liberati per mezzo di Mosè il quale li aveva condotti, attraverso il deserto, fino ai confini della terra promessa3. A Mosè era succeduto Giosuè che li aveva guidati alla conquista di tutto questo territorio. Per un certo periodo essi erano stati governati da capi improvvisati, i giudici, finché si erano organizzati in un regno prima sotto il re Saul e poi sotto Davide e suo figlio Salomone, al quale è attribuita la costruzione di un gran- de tempio a Gerusalemme dedicato al loro Dio. Sotto il figlio di Salomone, Roboamo, il regno si era diviso, dando origine a due re- gni spesso rivali: quello situato nel Nord della regione con capitale Samaria, portava il nome di Israele, mentre l’altro, più a Sud, la cui capitale era Gerusalemme, aveva preso nome da uno dei figli di Giacobbe/Israele, Giuda. Mentre il regno di Israele ha registrato diversi sovrani, quello di Giuda è stato governato senza interruzio- ne dalla dinastia di Davide.
1 Per la storia di Israele così come è narrata nella Bibbia cfr. il mio Israele racconta la sua storia. Per un tentativo di ricostruire la storia reale di questo popolo cfr. per esempio M. LiveRani, Oltre la Bibbia (vedi bibliografia).
2 Il nome Palestina deriva dai filistei, i quali anticamente occupavano la regione costiera. Esso è stato usato solo a partire dal II sec. d.C. dalle auto- rità romane, le quali applicarono a tutta la regione a sud della Mesopotamia il nome di Syria-Palaestina.
3 L’uscita dall’Egitto viene situata dagli studiosi verso il 1200 a.C., sempre che si tratti di un evento storico, cosa spesso negata dagli studiosi.
- CONTESTO STORICO-CULTURALE – 19
Nel 722 a.C. il regno di Israele, più esposto alle invasioni pro- venienti dal Nord, cadde sotto i colpi dell’Assiria, che allora era la potenza dominante in Mesopotamia: Samaria venne distrutta e parte della sua popolazione fu deportata. Il regno di Giuda riu- scì invece a sopravvivere ancora per circa un secolo e mezzo; ma nel 587 a.C. i babilonesi, che da poco erano subentrati agli assiri nel controllo della regione, conquistarono e rasero al suolo Ge- rusalemme, distrussero il tempio che vi aveva costruito Salomone e deportarono in Mesopotamia molti dei suoi abitanti. Termina così il periodo monarchico della storia d’Israele.
Il Dio adorato nei due regni era una divinità etnica, chiamata con un nome la cui pronunzia è andata perduta a motivo dell’a- bitudine, invalsa fra i suoi adoratori, di sostituirlo con Adonay (Signore). Di esso sono rimaste quattro consonanti Y H W H (sa- cro tetragramma), pronunziate oggi, in base a una ricostruzione comunemente accettata, Yahweh4. Durante il periodo monarchi- co, non era esclusa l’esistenza delle divinità di altri popoli a cui occasionalmente si ricorreva quando ciò era ritenuto necessario. Particolare attrattiva esercitava Baal, il dio della pioggia e della fertilità, di cui gli israeliti avevano particolare bisogno per la loro attività agricola. Contro questa mentalità sincretistica si scaglia- vano gli antichi profeti i quali minacciavano, come conseguenza, terribili castighi da parte di yhwh5.
continua
ALESSANDRO SACCHI, presbitero del Pontificio Istituto Missioni Estere, ha conseguito il Dottorato in scienze bibliche presso il Pontificio Istituto Biblico con una tesi diretta dal P. Stanislas Lyonnet dal titolo: «Il problema della “legge naturale” nell’esegesi di Rom 2,14-16», pubblicata successivamente presso le Edizioni Paoline con il titolo «Paolo e i non credenti. Lettera ai Romani 2,14-16.26-29» (Paoline Ed. Libri 2008). Ha svolto il suo insegnamento presso lo Studio Teologico-Missionario del suo Istituto, l’Università Cattolica del S. Cuore e il Seminario Regionale di Hyderabad (India). Ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Tiene un sito web denominato www.nicodemo.net orientato soprattutto allo studio delle letture della liturgia domenicale.



