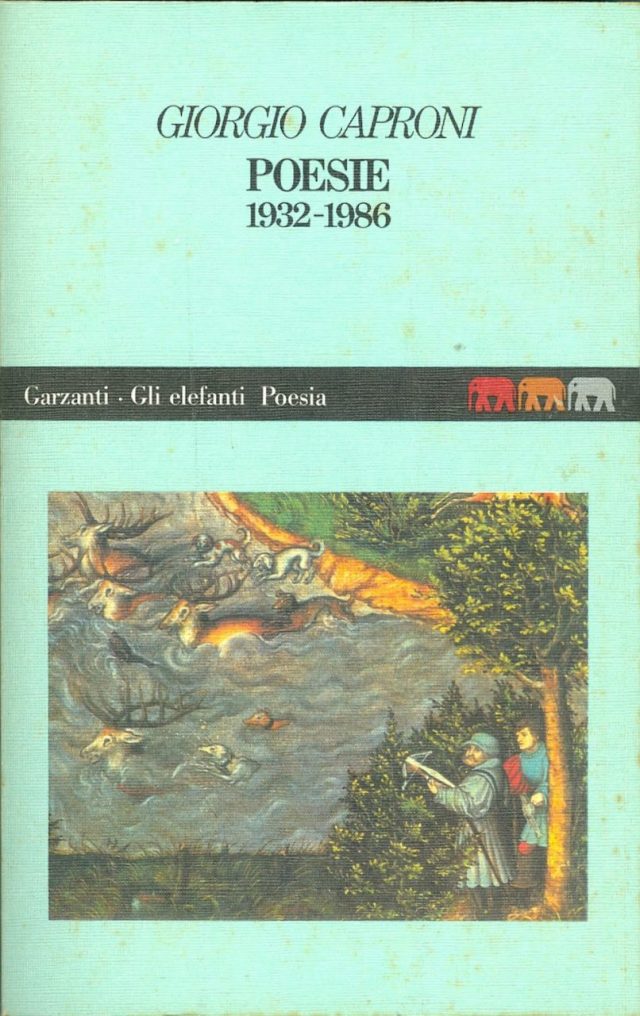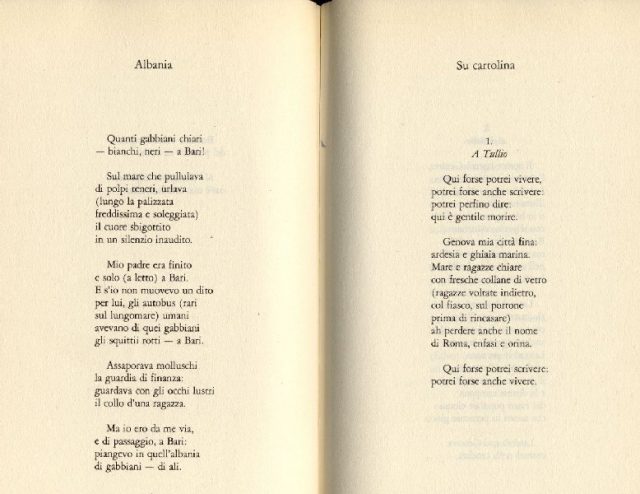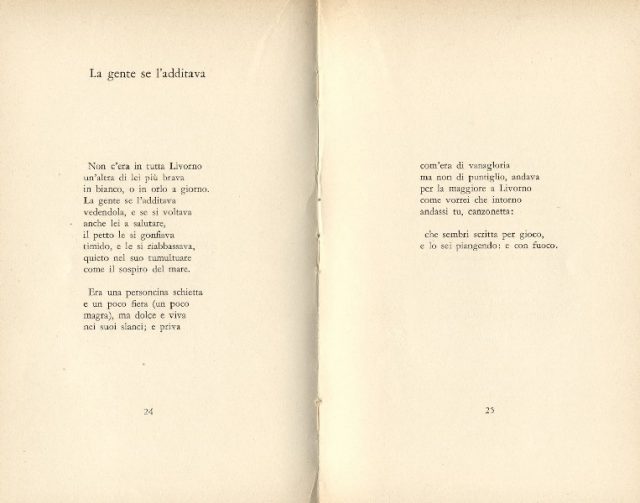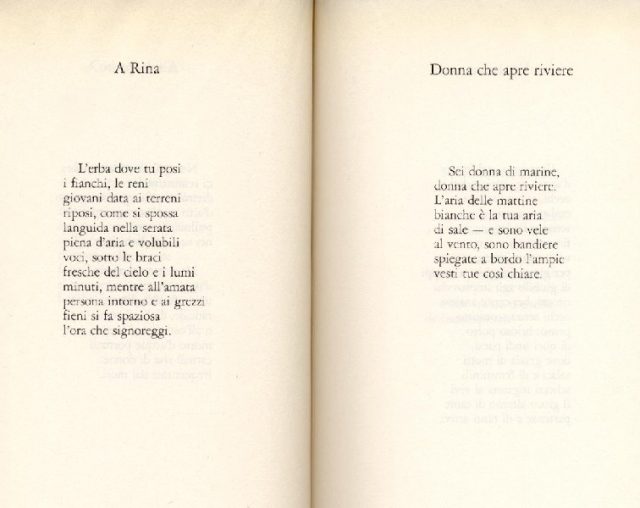Giorgio Caproni il Poeta
Biblioteca DEA SABINA
Il poeta Giorgio Caproni

Il poeta Giorgio Caproni
Da: Il passaggio d’ Enea
I – DIDASCALIA
Fu in una casa rossa:
la Casa Cantoniera.
Mi ci trovai una sera
di tenebra, e pareva scossa
la mente da un transitare
continuo come il mare.
Sentivo foglie secche,
nel buio, scricchiolare.
Attraversando le stecche
delle persiane, del mare
avevano la luminescenza
scheletri di luci rare.
Erano lampi erranti
d’ ammotorati viandanti.
frusciavano in me l’ idea
che fosse il passaggio d’ Enea.
II – VERSI
«A l’ accent familier
nous devinons le spectre»
La notte quali elastiche automobili
vagano nel profondo e con i fari
accesi, deragliando sulle mobili
curve sterzate a secco, di lunari
vampe fanno spettrali le ramaglie
e tramano di scheletri di luce
i soffitti imbiancati? Fra le maglie
fitte d’ un dormiveglia che conduce
il sangue a sabbie di verdi e fosforiche
prosciugazioni, ahi se colpisce l’ occhio
della mente quel transito, e a teoriche
lo spinge dissennate cui il malocchio
fa da deus ex machina!…Leggère
di metallo e di gas, le vive piume
celeri t’ aggrediscono – l’ acume
t’ aprono in petto, e il fruscio, delle vele.
T’ aprono in petto le folli falene
accecate di luce, e nel silenzio
mortale delle mobili cantilene
soffici delle gomme, entri nel denso
fantasma – entri nei lievi stritolii
lucidi del ghiaino che gremisce
le giunture dell’ ossa, e in pigolii
minimi penetrando ove finisce
sul suo orlo la vita, là Euridice
tocchi, cui nebulosa e sfatta casca
la palla morta di mano. E si dice
il sangue che c’ è amore ancora, e schianta
inutilmente la tempia, oh le leghe
lunghe che ti trascinano – il rumore
di tenebra, in cui il battito del cuore
ti ferma in petto il fruscio delle streghe!
Ti ferma in petto il richiamo d’ Averno
che dai banchi di scuola ti sovrasta
metallurgico, il senso è in quell’ eterno
rombo di fibre rotolanti a un’ asta
assurda di chilometri, sui lidi
nubescenti di latte trovi requie
nell’ assurdo delirio -Trovi i gridi
spenti in un’ acqua che appanna una quiete
senza umano riscontro, ed è nel raggio
d’ ombra che di qua penetra i pensieri
che là prendono corpo, che al paesaggio
di siero, lungo i campi dei Cimmeri
del tuo occhio disfatto, riconosci
il tuo lémure magro (il familiare
spettro della tua scienza) nel pulsare
di quei pistoni nel fitto dei boschi.
Nel pulsare del sangue del tuo Enea
solo nella catastrofe, cui sgalla
il piede ossuto la rossa fumea
bassa che arrazza il lido. Enea che in spalla
un passato che crolla tenta invano
di porre in salvo, e al rullo d’ un tamburo
ch’è uno schianto di mura, per la mano
ha ancora così gracile un futuro
da non reggersi ritto. Nell’ avvampa
funebre d’ una fuga su una rena
che scotta ancora di sangue, che scampo
può mai esserti il mare (la falena
verde dai fari bianchi) se con lui
senti di soprassalto che nel punto
d’ estrema solitudine, sei giunto
più esatto e incerto dei nostri anni bui?
Nel punto in cui, trascinando il fanale
rosso del suo calcagno, Enea un pontile
cerca che al lancinante occhio via mare
possa offrire altro suolo – possa offrire
al suo cuore di vedovo (di padre,
di figlio – al cuore dell’ ottenebrato
principe d’ Aquitania), oltre le magre
torri abolite l’ imbarco sperato
da chiunque non vuol piegarsi. E,
con l’ alba già spuntata a cancellare
sul soffitto quel transito, non è
certo un risveglio la luce che appare
timida sulla calce. Il tremolio
scialbo del giorno in erba, in cui già un sole
che stenta a alzarsi allontana anche in cuore
di quei motori il perduto ronzio.
III – EPILOGO
Sentivo lo scricchiolio,
nel buio, delle mie scarpe:
sentivo quasi di talpe
seppellite un rodio
sul volto, ma sentivo
già prossimo ventilare
anche il respiro del mare.
Era una sera di tenebra,
mi pare a Pegli, o a Sestri.
Avevo lasciato Genova
a piedi, e freschi
nel sangue i miei rancori
bruciavano, come amori.
M’ approssimavo al mare
sentendomi annientare
dal pigolio delle scarpe:
sentendo già di barche
al largo un odore
di catrame e di notte
sciacquante, ma anche
sentendo già al sol, rotte,
le mie costole, bianche.
Avevo raggiunto la rena,
ma senza avere più lena.
Forse era il peso nei panni,
dell’ acqua dei miei anni.
* * * * *
DEUS ABSCONDITUS
Un semplice dato: Dio non si è nascosto, Dio si è suicidato.
(SENZA TITOLO?)
Dio non c’é ma non si vede. Non è una battuta: è una professione di fede.
LA VITA
Adesca ma è micidiale.
Le basta, per l’invidia, un sasso.
Per quanto sia cauto il tuo passo,
rassegnati! ti riuscirà mortale.
CONDIZIONE
Un uomo solo,
chiuso nella sua stanza.
Con tutte le sue ragioni.
Tutti i suoi torti.
Solo in una stanza vuota,
a parlare. Ai morti.
(Da Il muro della terra [1964-1975])
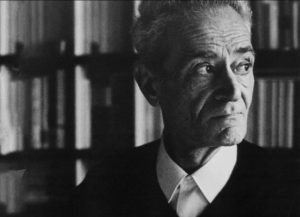
EPILOGO
Annina è nella tomba.
Annina, ormai, è un’ombra.
E chi potrà più appoggiare
l’orecchio al suo petto,
e ascoltare come una volta il cuore,
timido, tumultuare?
(da Versi livornesi)
ULTIMA PREGHIERA
Anima mia, fa’ in fretta.
Ti presto la bicicletta
ma corri. E con la gente
(ti prego, sii prudente)
non ti fermare a parlare
smettendo di pedalare.
Arriverai a Livorno
vedrai, prima di giorno.
Non ci sarà nessuno
ancora, ma uno
per uno guarda chi esce
da ogni portone, e aspetta
(mentre odora di pesce
e di notte il selciato)
la figurina netta,
nei buio, volta al mercato.
Io so che non potrà tardare
oltre quel primo albeggiare.
Pedala, vola. E bada
(un nulla potrebbe bastare)
di non lasciarti sviare
da un’altra, sulla stessa strada.
Livorno, come aggiorna,
col vento una torma
popola di ragazze
aperte come le sue piazze.
Ragazze grandi e vive
ma, attenta!, così sensitive
di reni (ragazze che hanno,
si dice, una dolcezza
tale nel petto, e tale
energia nella stretta)
che, se dovessi arrivare
col bianco vento che fanno,
so bene che andrebbe a finire
che ti lasceresti rapire.
Mia anima, non aspettare,
no, il loro apparire.
Faresti così fallire
con dolore il mio piano,
e io un’altra volta Annina,
di tutte la più mattutina,
vedrei anche a te sfuggita,
ahimè, come già alla vita.
Ricordati perché ti mando:
altro non ti raccomando.
Ricordati che ti dovrà apparire
prima di giorno, e spia
(giacché, non so più come
ho scordato il portone)
da un capo all’altro la via,
da Cors’Amedeo al Cisterone.
Porterà uno scialletto
nero, e una gonna verde.
Terrà stretto sul petto
il borsellino, e d’erbe
già sapendo e di mare
rinfrescato il mattino,
non ti potrai sbagliare
vedendola attraversare.
Seguila prudentemente,
allora, e con la mente
all’erta. E, circospetta,
buttata la sigaretta,
accostati a lei soltanto,
anima, quando il mio pianto
sentirai che di piombo
è diventato in fondo
al mio cuore lontano.
Anche se io, così vecchio,
non potrò darti mano,
tu mormorale all’orecchio
(più lieve del mio sospiro,
messole un braccio in giro
alla vita) in un soffio
ciò ch’io e il mio rimorso
pur parlassimo piano,
non le potremmo mai dire
senza vederla arrossire.
Dille chi ti ha mandato:
suo figlio, il suo fidanzato.
D’altro non ti richiedo.
Poi, va’ pure in congedo.
(da Versi livornesi)
CONGEDO DEL VIAGGIATORE CERIMONIOSO
Amici, credo che sia
meglio per me cominciare
a tirar giù la valigia.
Anche se non so bene l’ora
d’arrivo, e neppure
conosca quali stazioni
precedano la mia,
sicuri segni mi dicono,
da quanto m’è giunto all’orecchio
di questi luoghi, ch’io
vi dovrò presto lasciare.
Vogliatemi perdonare
quel po’ di disturbo che reco.
Con voi sono stato lieto
dalla partenza, e molto
vi sono grato, credetemi
per l’ottima compagnia.
Ancora vorrei conversare
a lungo con voi. Ma sia.
Il luogo del trasferimento
lo ignoro. Sento
però che vi dovrò ricordare
spesso, nella nuova sede,
mentre il mio occhio già vede
dal finestrino, oltre il fumo
umido del nebbione
che ci avvolge, rosso
il disco della mia stazione.
Chiedo congedo a voi
senza potervi nascondere,
lieve, una costernazione.
Era così bello parlare
insieme, seduti di fronte:
così bello confondere
i volti (fumare,
scambiandoci le sigarette),
e tutto quel raccontare
di noi (quell’inventare
facile, nel dire agli altri),
fino a poter confessare
quanto, anche messi alle strette
mai avremmo osato un istante
(per sbaglio)’ confidare.
(Scusate. E una valigia pesante
anche se non contiene gran che:
tanto ch’io mi domando perché
l’ho recata, e quale
aiuto mi potrà dare
poi, quando l’avrò con me.
Ma pur la debbo portare,
non fosse che per seguire l’uso.
Lasciatemi, vi prego, passare.
Ecco. Ora ch’essa è
nel corridoio, mi sento
più sciolto. Vogliate scusare.)
Dicevo, ch’era bello stare
insieme. Chiacchierare.
Abbiamo avuto qualche
diverbio, è naturale.
Ci siamo – ed è normale
anche questo – odiati
su più d’un punto, e frenati
soltanto per cortesia.
Ma, cos’importa. Sia
come sia, torno
a dirvi, e di cuore, grazie
per l’ottima compagnia.
Congedo a lei, dottore,
e alla sua faconda dottrina.
Congedo a te, ragazzina
smilza, e al tuo lieve afrore
di ricreatorio e di prato
sul volto, la cui tinta
mite è sì lieve spinta.
Congedo, o militare
(o marinaio! In terra
come in cielo ed in mare)
alla pace e alla guerra.
Ed anche a lei, sacerdote,
congedo, che m’ha chiesto se io
(scherzava!) ho avuto in dote
di credere al vero Dio.
Congedo alla sapienza
e congedo all’amore.
Congedo anche alla religione.
Ormai sono a destinazione.
Ora che più forte sento
stridere il freno, vi lascio
davvero, amici. Addio.
Di questo, sono certo: io
son giunto alla disperazione
calma, senza sgomento.
(da Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee [’60-’64])
Fonte- sito web VAGHEGGIANDO…
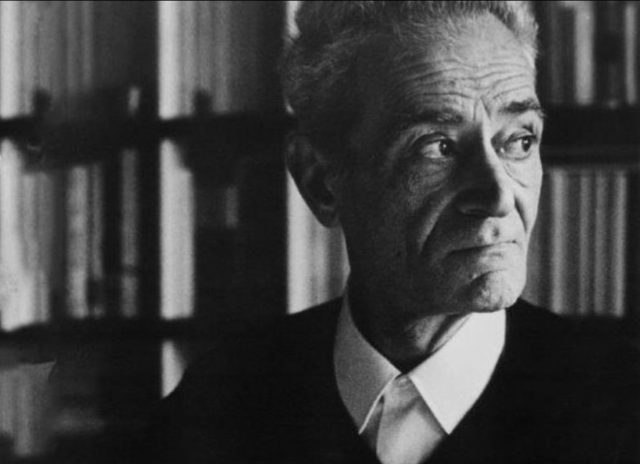
Roberto Pasanisi
Giorgio Caproni: l’assoluto e le cose
[Originariamente pubblicato su Fucine Mute 65]
Una vocazione precoce per la poesia, scandita per cinquanta anni sul filo d’una posizione appartata ma risentita, di là dalle mode e dal volgere turbinoso degli anni, è certo una delle cifre caratterizzanti dell’arte di Giorgio Caproni. Negli anni dell’Ermetismo, la sua poesia si ritaglia uno spazio autonomo, il cui primo referente sono piuttosto Ceccardo Roccatagliata Ceccardi (uno degli autori alle origini della poesia moderna in Italia) e «gli altri ribelli apuani», lungo quella grande tradizione ligure che lui stesso avrebbe contribuito a disegnare, non senza polemiche, sul piano critico.
Nato a Livorno nel 1912, non è azzardato né difficile rintracciare nella sua stessa in fondo scarna biografia la radice di quell’aerea e fresca musicalità, di quella grazia un po’ alla Chiabrera, quasi da canzonetta settecentesca, esile come un fiore di serra, che contrassegna fortemente tutta la sua produzione giovanile, da Come un’allegoria (1932-1935) (1936; il suo libro d’esordio) a Cronistoria (1943), ma che il poeta non dimenticherà del tutto nemmeno nei libri della maturità. Fino ai diciotto anni, infatti, Caproni studia violino, musicando fra l’altro brani del Poliziano (l’Orfeo), del Tasso e del Rinuccini; abbandonàti gli studi regolari, continuerà tuttavia ad esercitarsi sull’amato strumento per tutta la vita.
La sua poesia, del resto, si contrassegna sin dall’inizio per un’attenzione elettiva alla tecnica, sul filo d’una sapienza formale volta a costruire il verso con un’accurata opera di cesellatura, di oraziano labor limae: caratteristici sono l’uso della parentesi e dei trattini, che genialmente disegnano differenti piani nel verso, creando un affascinante e spericolato giuoco d’intersezioni e di rimandi, quasi che il filo del discorso si insegua e ricada continuamente su se stesso, procedendo a spirale piuttosto che in linea retta.
E il poeta stesso, in un continuo ed illuminante intersecarsi di produzione poetica e meditazione critica ed autoriflessione su di essa – secondo una cifra caratteristica del poeta moderno, da Baudelaire in poi -, ad indicare i Leitmotiv fondamentali della sua poesia: «All’origine dei miei versi […] direi che c’è la giovinezza e il gusto quasi fisico della vita, ombreggiata da un vivo senso della labilità delle cose, della loro fuggevolezza: coup de cloche, come dicono i francesi, o continuo avverti mento della presenza, in tutto, della morte. Sono versi un poco “macchiaioli”, che risentono molto del mio soggiorno, da bambino, nelle campagne fra Pisa e Livorno, in casa di un certo Cecco, allevatore e domatore di cavalli.»
Già nei primi versi emergono i paesaggi e la luce delle campagne toscane, ocra e verde, còlte attraverso una musica ora ariosa ora dissonante, ma che improvvisamente si slansia in aperture di stupefatta largura, come nell’explicit di Prima luce:
La terra, con la sua faccia
madida di sudore,
apre assonnati occhi d’acqua
alla notte che sbianca.
Gli uccelli sono sempre i primi
pensieri del mondo.
Si colgono qui alcuni dei moduli compositivi proprî della poesia caproniana: la leggerezza quasi impressionistica del tocco, il morbido surrealismo delle immagini («apre assonnati occhi d’acqua»), in cui si stempera la pur presente concretezza delle cose, l’aspra dissonanza dell’enjambement attributo/sostantivo («primi / pensieri»), la ricchezza dei referenti culturali (i carducciani pensieri della conclusio, tutt’uno con quelli di San Martino). La figura femminile, evocata nei tratti diafani del ricordo, manifesta montalianamente una sua lontana funzione salvifica soltanto attraverso la memoria: «[…] Dietro / i vetri, nello specchiato / cielo coi suoi rondoni / più fioco, / da me segreta ormai / silenziosa t’affanni / come nella memoria.»
L’immagine, tutta giocata sulla connotazione della ‘trasparenza’ dei vetri (metafora, d’altronde, del ricordo), ha la delicatezza impalpabile e pur luminosa dell’acquerello, espressa nella medietas di uno stile che spazia senza sussulti dal registro ‘alto’ a quello quotidiano, secondo un modus scribendi proprio di tutta la lirica caproniana.
Anche sugli exempla e sulla temperie più profonda dei suoi versi è ancóra il poeta stesso ad illuminarci: «Le mie vere fonti sono i poeti delle origini, dai siciliani ai toscani prima di Cavalcanti: poeti che usavano una lingua ancora inesistente, e quindi dura, spigolosa, non addomesticata a ritmi cantabili. Ed è stata proprio questa durezza, questa musicalità non dico sgradevole, ma tuttavia non consolatoria, che ho cercato di riprodurre, almeno da un certo punto in poi.» A quelli citati da Caproni vanno aggiunti i modelli di Lorca, di Antonio e Manuel Machado, di Azorín, di Ungaretti. Si vedano, a mo’ di specimen, versi come «il paese, tale nel cuore / si turba, / sebben lo tenga / amore, il tuo remoto / viso al cadere fitto / dell’ore.», in cui sapientemente si mescidano suggestioni dugentesche e scansione ungarettiana, sottese al tema tutto caproniano della labilità irreversibile e nostalgicamente rivissuta d’uomini e cose.
In Finzioni, la sua terza raccolta, del ’41, il poeta livornese prosegue con strenua coerenza il suo discorso poetico, sempre intessuto di ariose e magiche ouverture, sul filo d’una stilnovistica dulcedo e d’un senso di continuo e stupefatto miracolo:
di sale – e sono vele
al vento, sono bandiere
spiegate a bordo l’ampie
vesti tue così chiare.
Il prodigio della presenza metafisica di madonna è còlto, ancóra una volta, tramite il consueto ‘tu’ di sapore montaliano: l’insegnamento del maestro dell’Ermetismo è in effetti qua e là presente, come nei versi di Cronistoria (1943), l’ultima raccolta di quella che potremmo definire la prima maniera caproniana:
Alzata la brace nera
di gioventù, un linguaggio
più esteso alla bandiera
del Quirinale impone
la tua insegna – il tuo nome.
Tutta la produzione successiva, da Stanze della funicolare in poi (1952), appare segnata dall’esperienza tragica della guerra, e poi dal sempre crescente smarrimento di fronte al nuovo mondo emerso dalle macerie, in cui il poeta stenta ormai a riconoscersi: la scansione poetica si amplia, fino a rendere misura del discorso non più il verso, ma l’intera strofa, che acquisisce un’architettura più complessa e difficile, ma non per questo meno persuasiva, segnata com’è da un uso ancor più rimarcato dell’enjambement. E il poeta stesso, coniugando, more solito, un’acuta autoriflessione critica al suo fare poetico, che ci informa sulla sua metánoia; che non è, scilicet, solo stilistica, ma che implica un’evoluzione ed un approfondimento coerente e spericolato della sua Weltanschauung: «[…] ormai è giunto il momento, dopo tanto paziente e isolato lavoro sulla parola […] di indirizzare risolutamente il gusto al discorso: di ritentare insomma, dopo tanta effusione, la composizione, un’ombra almeno di ciò che comunemente s’intende per poema, tentando alfine il salto, ricchi di tanta esperienza formale, dalla lirica pura alla poesia. Un salto sì, dall’alto in basso, ma appunto per questo dall’astrazione (dalla solitudine) alla vita concreta (alla società).»
La poesia di Caproni appare sempre più intessuta di echi e iterationes fittissimi, che sovente gli servono per evocare scenarî di squallida e grigia quotidianità, di ascendenza eliotiana, nei quali la stessa figura femminile, smessa ogni soave suggestione trascendente, è solo una pallida immagine dell’inferno terreno, la cui ambientazione è ancóra quella delle trattorie vocianti e dei bar fumosi dell’anteguerra, ma stavolta divenuti metafora e luoghi elettivi d’una desolata modernità:
Perché è nebbia, e la nebbia è nebbia, e il latte
nei bicchieri è ancor nebbia, e nebbia ha
nella cornea la donna che in ciabatte
lava la soglia di quei magri bar
dove in Erebo è il passo. E, Proserpína
o una scialba ragazza, mentre sciacqua
i nebbiosi bicchieri, la mattina
è lei che apre alla nebbia che acqua
(solo acqua di nebbia) ha nella nebbia
molle del sole in cui vana scompare
l’arca alla vista. […]
E in questi anni, in effetti, che Genova (dove il poeta si era trasferito dall’età di dieci anni) diventa per Caproni luogo mitico d’ogni fare poetico ed irripetibile «città dell’anima»: «Il punto di stazione da cui guardo Genova non è quello, scelto ad arte, del turista. E un punto di stazione che si trova dentro di me. Perché Genova l’ho tutta dentro. Anzi. Genova sono io. Sono io che sono fatto di Genova.» Il referente lo apparenta, per certi aspetti, a quell’altro grande cantore della città ligure che fu il Campana dei Canti orfici (1914), specialmente in una poesia come Genova, o di quella sorta di frammentario abbozzo d’un poema sulla città, di cui una lirica come Piazza San Giorgio costituisce uno dei momenti più significativi.
Con Il seme del piangere (1959) Giorgio Caproni sembra riprendere alcune movenze giovanili, ripercorrere, con più matura consapevolezza, le antiche, soavissime ariette, malinconicamente addolcite, stavolta, di vaghe ascendenze sabiane e penniane; la morte, uno dei temi cruciali dell’ultimo Caproni, comincia a farsi strada in maniera preponderante, seppure ancóra esorcizzata in tristi ma musicali cantabili, nello scenario tipicamente caproniano della stazione:
Chi avrebbe mai pensato, allora,
di doverla incontrare
un’alba (così sola
e debole, e senza
l’appoggio d’una parola)
seduta in quella stazione,
la mano sul tavolino
freddo, ad aspettare
l’ultima coincidenza
per l’ultima destinazione?
Nella raccolta successiva, Congedo del viaggiatore cerimonioso & altre prosopopee (1965), il poeta approfondisce ulteriormente le sue tematiche, rendendo sempre più universale la sua solitudine ed il suo straniamento in un mondo inesorabilmente travolto dalla sirena del tecnologismo e della mercificazione: Il gibbone costituisce uno specimen particolarmente emblematico del motivo, nonché una delle liriche più famose ed antologizzate del poeta; qui il contrasto fra città ideale e città reale si fa straordinariamente struggente nella sua definitiva insanabilità, là dove la città dell’anima si risolve in uno scintillio favoloso di luci:
Nell’ossa ho un’altra città
che mi strugge. E là.
L’ho perduta. Città
grigia di giorno e, a notte,
tutta una scintillazione
di lumi – un lume
per ogni vivo, come
qui al cimitero, un lume
per ogni morto. Città
cui nulla, nemmeno la morte
– mai, – mi ricondurrà.
L’ultimo Caproni, da Il muro della terra in poi (1975), amplia il suo discorso anche sul piano dei referenti culturali, intessendo i suoi libri, attraverso una ricca mèsse di note, d’un fitto e sapiente giuoco di richiami letterari, che ne accresce fortemente la risonanza; la sua poesia, nel contempo, perde ulteriormente di concretezza, e le cose si riducono a pallidi, inafferrabili simulacri, còlte sul filo di risentiti ossimori:
Sono tornato là
dove non ero mai stato.
Nulla, da come non fu, è mutato.
Sul tavolo (sull’incerato
a quadretti) ammezzato
ho ritrovato il bicchiere
mai riempito. Tutto
è ancora rimasto quale
mai l’avevo lasciato.
Nella raccolte successive, fino a Il franco cacciatore (1982), l’ispirazione capronoana sembra ulteriormente incupirsi, eleggendo a modello il I canto dell’Inferno dantesco, ma attingendo a tratti echi vagamente eliotiani: «Gli amici sono spariti / tutti. Le piazze / sono rimaste bianche.» Il tema centrale diviene quello del doppio: come dice in Geometria, «[…] Così si forma un cerchio / dove l’inseguito insegue / il suo inseguitore. / Dove non si può più dire / (figure concomitanti / fra loro, e equidistanti) / chi sia il perseguitato / e chi il persecutore.»; o ancóra, in Rivelazione: «Mi sono risolto. / Mi sono voltato indietro. / Ho scorto / uno per uno negli occhi / i miei assassini. / Hanno / – tutti quanti – il mio volto.»
Siamo così all’ultima raccolta, pubblicata postuma a cura di Giorgio Agamben: «La res amissa, che doveva essere l’idea centrale, rimanda anch’essa a una ricerca, a una caccia: quella al Bene perduto, a un regalo prezioso di cui si è cancellata ogni memoria […]. Ma l’assenza può riempire ogni fessura, diventare tema conduttore ineludibile; e la `cosa’ perduta prende il posto della guida, da tempo smarrita e mancante» nel cháos informe della postmodernità. Così quel bene perduto può farsi a tratti metafora politica, in versi epigrammatici dove un acre ed amaro umorismo scaglia la sua maledizione contro l’Italia ribalda e allo sfascio di questi anni oscuri: «Laida e meschina Italietta. / Aspetta quello che ti aspetta. / Laida e furbastra Italietta.»; oppure: «Fra le disgrazie tante / che mi son capitate, / ahi quella d’esser nato / nella “terra di Dante”.»
Così l’ultimo Caproni, attraverso una poesia sempre più filosofica, si misura col tema dell’assenza di Dio, alla ricerca della comprensione di tutta un’epoca, del senso ultimo dell’uomo e delle cose: ne nasce una poesia enigmatica e misteriosa, tutta accesa di improvvisi baluginii nel buio, eterna metafora della ricerca dell’uomo che insegue infinitamente se stesso. Sullo sfondo, il dramma già fatto magistralmente presente da Novalis: «Noi cerchiamo dappertutto l’assoluto e troviamo sempre e soltanto cose».
Breve biografia di Giorgio Caproni, nato a Livorno nel 1921 (morto il 22 gennaio 1990 a Roma). Il padre Attilio era ragioniere, la madre Anna Picchi sarta. Studiò a Genova, poi al magistero di Torino dove seguì le lezioni del filosofo antifascista Alfredo Poggi. Dovette interrompere la sua frequenza, dedicandosi solo agli studi di violino. Nel 1935 inizia la sua attività di insegnante a Rovegno [alta Val Trebbia], proseguita poi in provincia di Padova e a Roma (1938). Nel 1939 fu richiamato alle armi. L’8 settembre 1943 era in Val Trebbia, e vi rimase fino alla fine della guerra civile affiancandosi ai partigiani. Dopo la guerra si stabilì a Roma, con la moglie Rina, e i figli Attilio Mauro e Silvana, continuando a fare il maestro elementare.
Fondamentale per Caproni fu la lettura nel 1930 di “Ossi di seppia” di Montale. Importanti per la sua formazione prima della guerra furono le letture dei poeti francesi e spagnoli, Apollinaire e Machado, e dei filosofi antichi e moderni (tra cui Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard de “Il concetto dell’angoscia”). Solo nel 1933 fu pubblicata la sua prima poesia, Prima luce sulla rivista “Espero”, poi compresa nella sua prima raccolta poetica. Ha pubblicato i volumi di versi Come un’allegoria (1936), Ballo a Fontanigorda (1938), Cronistoria (1943). Dopo la guerra sono Stanze della funicolare (1952), Il passaggio di Enea (1956), Il seme del piangere (1959), Il muro della terra (1975), Il franco cacciatore (1982). Collabora a varie riviste e quotidiani (L’Unità, Avanti!, Paragone), per molti anni curò la pagina culturale di “Mondo operaio”, e tenne una rubrica su “La fiera letteraria”. Nel 1983 è l’edizione di Tutte le poesie edito da Garzanti. Seguirono Il conte di Kevenhuller (1986) e, postumo, Res amissa (1991).
Caproni mescola lingua popolare e lingua colta, con una sintassi strappata, ansiosa, in una musica dissonante ma anche squisita. Esprime un attaccamento sofferto alla realtà quotidiana, sublimando la sua matrice di pena in una suggestiva epica casalinga. Gli accenti di aspra solitudine delle ultime raccolte approdano a una religiosità senza fede, senza la possibilità di dio. Il mondo poetico di Caproni ha consumato ogni illusione, è sceso al silenzio, ha varcato in modo conseguenziale la frontiera di un mondo definitivamente senza ‘grazia’. La sua poesia affonda in una memoria corrosa, in un vissuto che muore a ogni istante: egli è uno scrittore del disincanto.
Caproni è stato anche un ottimo traduttore: iniziò nel 1951 quando Natalia Ginzburg gli commissionò la traduzione de Il tempo ritrovato di Proust per Einaudi; ha poi tradotto Maupassant (Bel Ami, 1965), Céline (Morte a credito, 1964), Apollinaire (Poesie, 1979), Jean Genet (4 romanzi, 1975). Volume di racconti sono L’ultimo borgo (1980) e Il labirinto (1984).
Fonte- sito web VAGHEGGIANDO…