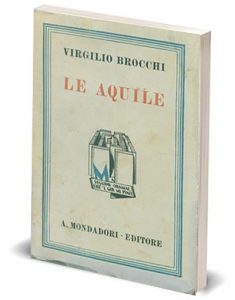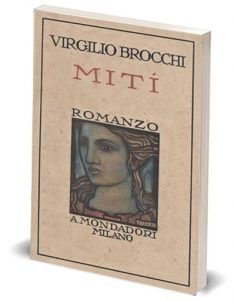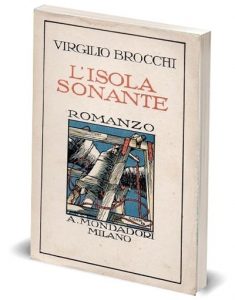ORVINIO OMAGGIA LO SCRITTORE VIRGILIO BROCCHI
Biblioteca DEA SABINA

ORVINIO (Rieti)- OMAGGIA LO SCRITTORE VIRGILIO BROCCHI A
-Lo scrittore italiano più letto a fine anni Venti-
Virgilio Brocchi è stato uno scrittore italiano. Fu autore, nella prima metà del XX secolo, di una serie di romanzi destinati al grande pubblico che riscossero un discreto successo. I romanzi, scritti e pubblicati al ritmo di circa uno all’anno, furono la versione dell’epoca dell’attuale “best seller”. Di dichiarata fede socialista fu molto vicino ad esponenti di spicco di questa corrente politica fra i quali Filippo Turati ed Anna Kuliscioff. Trascorse gli ultimi anni della sua vita in Liguria, sulle alture sopra Nervi.
Virgilio Brocchi, il narratore garbato-
Virgilio Brocchi, un narratore molto differente dai colleghi dell’epoca nutriti di dannunzianesimo e avanguardismo. Brocchi viene dall’“altra Italia”, più pacata, meno chiassosa e più incline al romanticismo e ai buoni sentimenti. Uno spaccato del paese che vive ancor’oggi.
Un nuovo scrittore
Se Da Verona, Pitigrilli e Mariani rappresentano l’ala più “trasgressiva” degli scrittori di successo negli anni Venti, con i loro romanzi venati di pornografia e talvolta di idealità lontane da quelle del regime, vedi a questo proposito Mario Mariani, non mancano scrittori politicamente più rassicuranti, sia nei contenuti che nell’aspetto ideologico. Rispondono ai nomi di Virgilio Brocchi, Salvator Gotta, Lucio D’Ambra, Guido Milanesi e altri ancora.
Quello che vediamo stavolta è Virgilio Brocchi, uno scrittore dai toni romantici, talvolta languidamente sentimentali, adatti ai lettori piccolo borghesi, anche se blandamente improntati a ideali socialisti-riformisti e cristiani.
Discende da una agiata famiglia di Bassano del Grappa, il padre è un avvocato, ma nasce in provincia di Rieti nel 1876. Compie gli studi classici fra Cremona e Padova, dove si laurea in lettere. Inizia subito la lunga e travagliata carriera di docente in giro per l’Italia, come è d’uso allora, e in parte anche oggi. Passa da Modica, in Sicilia, a Macerata, da Bologna a Milano, alternando ai doveri dell’insegnamento quelli di saggista e critico letterario e artistico, con scritti non disprezzabili. Già a 21 anni ha pubblicato un lavoro su un novelliere del Seicento; negli anni successivi escono saggi su Zola, su Hugo, sul Petrarca, sul Goldoni e altri ancora. Ma questo promettente avvio di critico e di saggista si interrompe ai primi del Novecento, allorché prevale in lui la passione per la narrativa.
L’esordio nella narrativa
Inizia così ai primi del Novecento, appena venticinquenne, l’attività di scrittore, mentre continua ad insegnare nelle scuole superiori, professione che eserciterà ancora sino agli anni venti.
Escono le prime opere, che, come capita spesso agli esordienti, sono da dimenticare e che lo scrittore, una volta arrivato al successo, ripudierà e ne impedirà la ristampa. Una di queste era uscita nel 1901presso l’editore Giannotta di Catania, dietro un contributo per la pubblicazione di 300 lire, mentre insegnava all’istituto tecnico di Modica.
L’esordio vero e proprio come narratore si ha nel 1906 con un romanzo, Le aquile, pubblicato da Treves, che è l’editore più importante del periodo. Il libro incontra un’accoglienza tiepida, roba da pochissime migliaia di copie nell’arco di oltre dieci anni. E su quei livelli, di scrittore noto solo a un ristretto ambito di lettori, Brocchi rimane anche con le opere successive.
Nel 1911 è la volta de L’isola sonante, che amplia un po’ la sua notorietà presso il pubblico. Tuttavia il romanzo, che si può considerare una significativa testimonianza sulle condizioni sociali, politiche e religiose nel Nord Italia, si avvale di una favorevole recensione di Ettore Janni. All’epoca egli è uno dei critici più promettenti del paese, e il suo intervento nel “Corriere della sera” nel 1911 gli conferisce una maggiore visibilità. Un altro critico, allora giovane ma molto promettente, G.A.Borgese, coglie nelle vicende e nei personaggi del romanzo apprezzabili spunti sulle tematiche al centro del dibattito politico, filosofico e religioso del paese: il socialismo, il positivismo e il modernismo. Sono gli ideali ai quali aderisce con piena convinzione il Brocchi stesso, e per i quali poi si impegna concretamente nell’ambito del partito socialista, quando entra come assessore all’istruzione superiore nella giunta socialista di Milano presieduta da Caldara, che governa la città dal 1914 al 1920.
Ma le tirature dei libri restano abbastanza limitate: Brocchi appare come uno scrittore dalle buone potenzialità, dotato di un tipo di scrittura piacevole e accattivante, con contenuti che risentono degli echi di Fogazzaro e soprattutto di Rovetta, scrittore quest’ultimo forse colpevolmente dimenticato ai nostri tempi. È animato da idealità sincere, ma è ancora ben lontano dalle masse dei lettori. Queste continuano a prediligere nei primi due decenni del secolo altri narratori, fra cui Luciano Zuccoli, Carolina Invernizio, Annie Vivanti, De Amicis, gli appena ricordati Fogazzaro e Rovetta, mentre sta esplodendo la popolarità di Guido Da Verona, che surclasserà tutti, in attesa che al suo nome si affianchi dal 1920 in poi quello di Pitigrilli.
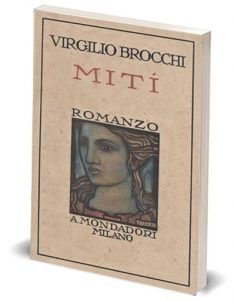
Arriva il successo con Mitì
Nel 1917 arriva finalmente il grande successo di pubblico. E questo si deve a Mitì. Il titolo sembra riecheggiare quello di Mimì Bluette di Guido Da Verona, uscito l’anno prima, che sta spopolando in tutto il paese, persino fra i soldati al fronte, dove riesce a dare corpo ai sogni di evasione nei terribili momenti di Caporetto. Ma l’accostamento fra i due romanzi è solo nel nome della protagonista, perché poi essi non hanno nient’altro in comune. Così come i due autori. Mitì infatti è una tenera storia d’amore, fatta di romanticismo e di buoni sentimenti: una di quelle che nel segreto ogni lettore sogna e vorrebbe vivere.
Questo romanzo impone Brocchi all’attenzione del grande pubblico, e viene confermato subito dopo da altre opere che escono con regolarità negli anni successivi: Secondo il cuor mio nel 1919, Il posto nel mondo nel 1921, Il destino in pugno nel 1923, Netty del 1924 e altri ancora in seguito.
Il passaggio alla Mondadori
Il successo di Mitì e dei romanzi successivi determina, come avviene sempre, una ripresa di interesse sulle opere precedenti. E così Le aquile del lontano 1906, che sino ad allora avevano venducchiato qualche migliaio di copie in oltre dieci anni, vengono riscoperte e riproposte all’attenzione del pubblico. In tal modo raggiungono le 60.000 copie, che sarebbero potute essere 100.000 se fossero state ristampate in tempo quando si esaurivano, come ammetterà lo stesso Brocchi nelle sue memorie (Confidenze, 1946). Questa circostanza determina un raffreddamento dello scrittore nei confronti del suo editore tradizionale, Treves, e il convinto avvicinamento a quello che nel primo dopoguerra si sta rivelando l’astro nascente dell’editoria: Arnoldo Mondadori.
Nel 1922 fra i due si stringe uno stretto sodalizio, con vantaggio reciproco. Brocchi sarà il primo autore di successo ad entrare nella scuderia della Mondadori, e vi svolgerà un ruolo d’attrazione per una nutrita schiera di altri scrittori. E sarà ricambiato con una attenzione particolare da parte dell’editore, sia da un punto di vista umano, che professionale. Unisce i due anche una comune matrice ideologica: sono entrambi socialisti. Anche Mondadori, che ha iniziato la sua attività nel lontano 1907, è di idee e di formazione socialista, e l’intesa fra i due è davvero vincente.
Da questo momento Brocchi abbandona l’attività politica che lo ha molto impegnato, e abbandona anche l’insegnamento, per dedicarsi esclusivamente alla narrativa. Tutti i suoi libri d’ora in poi usciranno presso l’editore veronese-milanese, con il risalto che meritano, la promozione adeguata, la distribuzione inappuntabile e puntuale, la pubblicità efficace, la sinergia con le riviste della casa: tutte caratteristiche che stanno facendo di Arnoldo Mondadori il maggior editore italiano.

Lo scrittore italiano più letto a fine anni Venti
Da metà anni Venti in poi, quando la fortuna di Da Verona inizia a declinare e Pitigrilli si dedica più alle riviste che ai libri, ecco che Brocchi assurge ai vertici del mercato librario, come riconosce un altro principe dei critici del tempo, Antonio Baldini, che dalle colonne del “Corriere della sera” lo proclama lo scrittore italiano più letto del periodo. Un’affermazione che pesa, e parecchio, e che trova conferma nelle tirature dei vari libri: mediamente dalle 100 alle 160.000 copie a titolo per i libri più fortunati. Certo, è la metà di quelle dei maggiori best seller di Da Verona e di Pitigrilli, ma in quegli anni lo pongono sicuramente ai vertici del mercato librario, dove resterà ancora a lungo.
Brocchi, da parte sua, non si adagia sugli allori e continua imperterrito a sfornare puntualmente i libri, al ritmo di uno l’anno, a volte anche di più. In tutto saranno circa sessanta. Vengono riuniti in cicli, in genere trilogie e quadrilogie, in modo che i lettori sappiano già prima dell’acquisto in quale contesto si svolgeranno le vicende, con quale tipo di scrittura saranno narrate, quali personaggi vi troveranno, e quant’altro. Ne ricordiamo qualcuno: il ciclo dell’ “Isola sonante”, del “Figliuol d’uomo”, “Dei casti libri delle donne che mi hanno amato”, “Dell’ansia dell’eterno”, “De i romanzi del piacere di raccontare” e altri ancora.
Tale pratica, di includere cioè i romanzi in serie più o meno lunghe, verrà ripresa anche da altri scrittori, come per esempio Lucio D’Ambra e Salvator Gotta. A quest’ultimo spetterà incontrovertibilmente il primato, in quanto autore di una saga, la saga dei “Vela”, composta da oltre 20 titoli!
I romanzi di Virgilio Brocchi piacciono, i suoi personaggi si fanno amare, tanto che ogni nuova uscita diventa un appuntamento irrinunciabile per i lettori. La sua prosa elegante, piana, accattivante come poche altre, rassicura il pubblico sia borghese che popolare, lo asseconda nei gusti e nelle aspettative più profonde. E d’ora in poi i titoli che escono raggiungono sempre i vertici del mercato librario.
Così i libri che pubblica vengono ristampati più volte, sia pur con una progressiva riduzione delle tirature via via che passano i decenni. Però Brocchi non perde mai quello zoccolo duro di lettori che in lui ritrovano modelli narrativi di sicuro impatto. Anche negli anni Cinquanta e Sessanta, nei quali molti autori del periodo sono oramai dimenticati, restano sempre abbastanza numerosi i lettori che continuano a leggerne i romanzi.
Brocchi compone anche dei libri per ragazzi, oggi del tutto dimenticati, ma che all’epoca ottengono un successo addirittura superiore a quello dei suoi maggiori best seller. Ricordiamo fra questi La storia di Allegretto e Serenella, uscita nel 1920 e venduta in centinaia di migliaia di copie, come avviene anche per gli altri titoli che compongono la serie dei libri per ragazzi.
Stabilitosi definitivamente nella costiera ligure, Brocchi trascorre i suoi ultimi anni anche impegnandosi in battaglie ambientaliste, come quella per la salvaguardia del territorio di Nervi, dove risiede.
Muore nel 1961 all’età di 85 anni, dopo una vita operosa e ricca di soddisfazioni, dedita in gran parte, ma non solo, alla scrittura.

LETTERATURA: Virgilio Brocchi: “Il posto nel mondo”, 1920
di Bartolomeo Di Monaco
Il romanzo appartiene al ciclo narrativo “Figliuol d’uomo”, uno dei molti cicli di cui Brocchi fu autore.
Leggendo l’incipit, la prima immagine che ci viene in mente è quella della bottega di Mastro Ciliegia, il quale, mentre taglia il famoso “pezzo di legno” per ricavarci un burattino, sente uscirne la voce di Pinocchio (“Le avventure di Pinocchio”, di Collodi, uscì in volume nel 1883). Qui invece siamo nella officina, nei pressi di Albano, del fabbro di carri Decio Battilasso, il quale mentre sta chiudendo bottega per fine giornata ode alle spalle la vocetta del tredicenne Pietruccio Barra che è in cerca di lavoro, fuggito da Roma giacché il padre lo picchiava, e trattava male anche la mamma. Nel lavoro il ragazzo, nonostante la giovane età, mostra di sapere il fatto suo. Tutti gli vogliono bene, operai e padrone. La mamma risponde a una sua lettera pregandolo di ritornare, ma lui, pur sollecitato da mastro Decio, decide di restare. Dormirà a casa di Scipione Manuzzi, uno degli operai, poco più grande di lui, che ne ammira il talento. In quattro e quattr’otto, con uno stile limpido e con poche smancerie, è disegnato l’ambiente di una bottega del tempo e la solidale amicizia che vi regna. Ce ne sentiamo attratti. Il romanzo – lo si avverte subito – può interessare anche un pubblico giovanile, catturato dalla sua piacevole scrittura. Un esempio: “Il giorno dopo s’arrestò dinanzi all’officina un carro tirato da due buoi, e tutta l’abbuiò, ché sul carro torreggiava un gran torchio meccanico da vinacce. Ne balzò giù un uomo di quarant’anni, tarchiato, coi calzoni nella tromba degli stivali, il panciotto solcato da una catena d’oro, i lunghi baffi con riflessi rossi, e in testa un cappello a cono con le falde larghe e distese.”. È il ritratto di Menico Tantarini, un agricoltore che ospiterà Pietruccio a casa sua, a Genzano, una località poco distante. Ma Pietruccio teme che il padre lo ritrovi e desidera allontanarsi di più. Così, di nascosto, lascia anche la casa di Menico e si mette in viaggio sulla via Appia per una nuova destinazione. Se non fosse per la tristezza e la paura che opprimono il cuore del ragazzo, si penserebbe alle peregrinazioni di Lazarillo di Tormes, il protagonista del romanzo omonimo, di autore ignoto, del XVI secolo, e anche a quelle di Tartarino di Tarascona, il personaggio del romanzo omonimo di Alphonse Daudet, pubblicato nel 1872. Il meccanismo narrativo è molto simile. E perché non pensare anche al racconto “Dagli Appennini alle Ande” di Edmondo De Amicis, contenuto nel libro “Cuore”, del 1889? Solo che qui il ragazzo va in cerca della madre mentre nel romanzo di Brocchi, Pietruccio fugge dal padre. La sua fuga è un percorso di formazione alla ricerca del proprio posto nel mondo, come suggerisce il titolo. Ha alti e bassi, questa ricerca. Rintracciato dal padre torna a Roma, ma il padre, Stefano Barra, non è cambiato e soprattutto continua a trascurare la madre, Giulia, avendo un’amante da cui ha avuto un figlio ancora in fasce. Troviamo una bella descrizione dell’officina in cui Pietruccio è costretto dal padre a lavorare, con bei dettagli sugli utensili adoperati, e si capisce che Pietruccio sarebbe anche disposto a fare quella vita, nonostante non ami il mestiere, se non avvertisse la necessità di fuggire da una situazione familiare di grande sofferenza. Forse è altrove che potrà sentirsi felice. Il padre fa di tutto per fargli amare il mestiere: “Non c’è arte più bella! Qui c’è tutto: la forza, la delicatezza, la difficoltà da vincere, il pericolo da superare. Col ferro tu fai tutto, l’architettura, la scultura, e anche la pittura. Guarda che colore ha il ferro! Guardalo bene adesso che ci batte il sole: c’è il viola, c’è il verde, c’è il rosso, c’è il brillare dell’argento, il caldo dell’oro, nel bruno c’è la traccia del fuoco, il riflesso della fiamma di carbone: lo morderesti per la felicità.”. Quando si leggono descrizioni come questa o come quella della modellazione con il fuoco di una serpe ornamentale, oppure come quella della fattoria di Santa Maria delle rondini, dove vivono il nonno Bastiano Maresi e lo zio di Pietruccio, Giovanni, verrebbe da pensare – se poi vi aggiungiamo i grandi scrittori del passato che ancora oggi sono ricordati e fanno parte dell’olimpo letterario – che resti poco o nulla da raccontare ai narratori di oggi. Un altro esempio: “C’era Francesco Cucchi detto Sbruscia, dalla faccia piatta, il naso schiacciato al mezzo, e la punta protesa come un becco d’anitra.”. E non si trovano già qui i ragazzi di vita che anni dopo saranno oggetto di attenzione da parte di Pier Paolo Pasolini? Si pensi a Giunio Dicòla, detto Rugantino di cui ci dice che “aveva perduto il padre a dieci anni, e a tredici picchiava la madre: dormiva allora tra i ruderi del Foro, viveva con una banda di piccoli malfattori saccheggiando i negozi o dando la scalata alle ville dei quartieri lontani: a quattordici anni era stato condannato, e da trenta mesi era chiuso nel riformatorio covando la smania della fuga.”.
Finalmente Pietruccio si libera del padre e apre un’officina per conto suo, “ma quel lavoro troppo umile di fabbro (…) lo scorava e gli metteva nel cuore il disgusto del suo mestiere e l’inquieta aspirazione a salire. Verso qual segno non sapeva.”. Dunque, è confermato che questo è il percorso formativo del ragazzo. Quel lavoro è transitorio e lo esercita solo per alleviare le fatiche e le sofferenze della mamma e delle amate sorelle Nella e Rina. L’occasione per cominciare un po’ a studiare, gliela dà l’amico Scipione Manuzzi, il ragazzone che lavorava con lui ad Albano, dal fabbro Decio Battilasso, il quale è venuto a Roma per prendere lezioni di canto, poiché ha una bella voce, ma gli occorre anche dell’istruzione. Per il tempo necessario, lavorerà alla bottega di Pietruccio e dormirà con lui dalla sua mamma. Studieranno insieme, e la sorella Nella, ormai prossima a prendere il diploma, le farà da maestra. Più si va avanti nella storia, più ci si accorge che vi è un filo deamicisiano che non l’abbandona mai. La scrittura si sa controllare e il sentimento non ridonda, ma affiora con misura.
Con il padre Stefano, gli altri della famiglia non riescono più a viverci insieme, così che si trasferiscono dal nonno materno Bastiano Maresi, che lavora le terre del padrone Filippaccio Frezzi, il quale li accoglie amorevolmente. Presso il nonno vive anche il fratello di Giulia, Giovanni Maresi, il pittore, con la moglie Teresa. Lì, l’atmosfera è del tutto diversa: affettuosa e calda. Vi troviamo brani di una prosa che sa pennellare ambiente e sentimenti. Questo è il bel ritratto di don Ambrogio Favotti, il curato di Santa Maria delle rondini: “aveva preferito per umiltà e indolenza invecchiare nella chiesola silenziosa tra le cascine sparse in mezzo alla campagna. Era alto e quasi esile nella veste nera abbottonata dalla gola ai piedi e serrata alla cintola da una larga fascia di seta. Non portava mai il cappello a falda; un nicchio leggero appena posava sui soffici capelli, fini e bianchi come il piumino del cigno, sotto cui si arrotondava un bel volto pacato di vegliardo.”. Si avvertono echi manzoniani. La stessa quiete stilistica, la stessa precisione nel dettaglio.
È don Ambrogio che, quando Giulia, la madre di Pietruccio, andrà a trovarlo, ci farà capire che la donna non è sposata con Stefano Barra, ma è convivente; perciò, se Stefano si sposasse con l’amante, quello sarebbe il matrimonio legittimo: “E se sposasse quella disgraziata? Davanti a Dio, essa sarebbe la moglie legittima: e tu poverina…”. Una tragedia, che promette di impedire.
Il peregrinare di Pietruccio trova un momento di approdo grazie a don Ambrogio, che si prende cura di farlo studiare. Come prima il ragazzo camminava con le proprie gambe girando di paese in paese, ora è la sua mente che naviga in mezzo ai marosi ogni volta che pensa allo sbocco dei suoi studi. Che farà? Il medico, il cantante, il musicista, il fabbro, il coltivatore, l’ingegnere, l’esploratore? Intanto ammira suo zio Giovanni che fa il pittore e ha dipinto un grosso quadro che spera di vendere per pagare i suoi debiti. Ma non ha successo e torna a casa sconsolato. Su Pietruccio, invece, cominciano ad indirizzarsi le attenzioni di don Ambrogio per persuaderlo ad entrare in seminario. Nasce tra lo zio Giovanni e Pietruccio una intensa affinità, proprio nel momento in cui le due vite paiono in antitesi. Il pittore deluso, divenuto anche vedovo per la morte di Teresa, e il ragazzo, a cui la vita si sta aprendo, si legano di una forza spirituale che li fa soffrire e sperare insieme: “Pietruccio s’era fatto lui il protettore del fanciullo desolato che era diventato Giovanni”. A proposito di Pietruccio: “Giovanni non lo sentiva estraneo alla propria desolazione, né fuori dell’insondabile abisso in cui egli viveva.”. Ma con il passare del tempo, questa affinità viene travolta, dura lo spazio di un mattino. Il dolore per la morte di Teresa è così forte che lo zio ne è piegato e si uccide. Tutto ciò si rivelerà come una specie di trapasso per Pietruccio, il quale, preso da un assalto di misticismo, entrerà così in seminario, dove subirà ogni sorta di dispetti da parte dei compagni, giacché, essendo pronipote del canonico e filosofo Agostino Maresi, in odore di apostasia, verrà considerato una specie di indiavolato. Qui incontriamo un’altra eccellente descrizione: quella della vita in seminario con le sue regole a volte eccessive e le conseguenti indiscipline degli allievi.
Il nostro protagonista, però, non ha ancora trovato la sua strada. Frequenta il seminario per imparare musica, e a chi gli domanda se si farà prete cerca di non dare una risposta diretta. Alla sorella Nella dice: “Non ho mai promesso a nessuno di farmi prete.”. È in seminario che per la prima volta, dalla voce di due sacerdoti, sente parlare di proletariato e di socialismo. Si stanno formando i primi circoli cattolici in antagonismo con quelli socialisti. Pietruccio vuole prendervi parte. È uno spaccato che poi non troverà uno sviluppo più approfondito e più articolato nella storia, come non troveranno sviluppo altri filoni tra cui quello dell’amore di Scipione per Nella.
Uno dei migliori seminaristi, Nino Beroldi, gli pone la questione dell’esistenza di Dio, poiché ne invoca un segno, che non viene. Pietruccio è assalito, così, da problematiche spirituali e sociali di grande spessore per la sua età. Questa parte del romanzo rappresenta con una nostalgica bellezza un mondo che non c’è più. I primi movimenti operai, le prime richieste di giustizia sociale, le ribellioni, i seminari pieni di novizi (a cui erano vietate amicizie troppo strette, come a Pietruccio con l’amico Lino Roccelli), i sacerdoti quali maestri di formazione di molti giovani, sono sezioni di un grande quadro che ebbe in quegli anni i suoi vividi colori. L’autore riesce mantenere un tono narrativo di costante robustezza, dimostrando di sapersi esprimere con proprietà e garbo in ogni situazione: “per riscaldarsi i seminaristi pestavano i piedi, saltavano, lottavano, si battevano forte il torso incrociando le braccia a manate.”. Difficile immaginare come sia stato possibile che questo romanzo, che può stare alla pari, ad esempio, con quelli di un De Amicis, sia scomparso del tutto dalla nostra nomenclatura letteraria.
Anche l’esperienza del seminario fallisce. Pietruccio viene cacciato giacché i suoi pensieri si discostano da quelli della Chiesa. Ne parlano per una settimana i giornali. In famiglia si è tristi. Tranne la sorella Nella che lo accoglie sorridendo e gli dice che è meglio tornare a fare il fabbro piuttosto che farsi prete. Legge le opere dell’ex canonico in odore di eresia Agostino Marresi, il quale, lo ricordiamo, è suo parente per parte di madre. Ne è invaghito. La sua fede è ormai vacillante e per lui comincia un cammino tutto speciale, che non è più quello alla ricerca del mestiere da esercitare nel suo futuro, che pure resta, ma il cammino della sua fede la quale a poco a poco, con strappi dolorosi, si sta sradicando dalla sua mente e dal suo cuore.
Avrà un incontro importante con lo zio Agostino Marresi (cugino del nonno Bastiano), un vecchio di ottantacinque anni, che si mostra affettuoso e intenzionato a consigliarlo, e da questo incontro trarrà la forza per tornare dalla madre e dirle che è cambiato e non andrà più alla messa domenicale (ma più avanti troveremo: “alle undici usciva di casa per correre in Duomo ad ascoltare la messa cantata.”).
Tanto questo incontro quanto altre scene che si aprono all’improvviso a siparietto rivelano una straordinaria capacità narrativa dell’autore, il quale sa tenere e variare con leggerezza i fili della sua storia. Si pensi, ad esempio, alla cena in una povera trattoria di Milano, dove Pietruccio si reca con il padrone di suo nonno, Filippaccio Frezzi, simpatica e vivida: lo spilorcio Filippaccio dirà all’ostessa: “Al ragazzo il formaggio non piace: datene una porzione a me; ma tenero, perché ho tre denti soli, lunghi ma non troppo sicuri.”. O alla parentesi di vita trascorsa con il giovane povero e malaticcio Andrea Vietti.
Non dobbiamo dimenticare che il percorso formativo di Pietruccio, che è in cerca del proprio destino, resta sempre legato all’amore verso la sua famiglia, in specie il nonno, la madre e le due sorelle, così che esso non è mai dipendente da una ambizione personale, bensì da un sentimento nobile di attaccamento alle proprie radici: “quel buon preside che vedeva già in lui un grande uomo, mentre egli si accontentava di diventare un uomo, ma al più presto possibile, per sollevare il nonno, per aiutare la mamma ed allietare la vita delle sorelle.”; “Nonno, ti giuro che non ti dovrai mai vergognare di me.”.
Entrato in una manifattura tessile, viene notato per la sua bravura e vi fa presto carriera. Ciò che seguirà è un intreccio di sventure e di avventure, ma ciò che conta è che finalmente, con il lavoro assicuratogli dall’amministratore della fabbrica Franco Varzi, Pietruccio ritroverà la sua serenità e il piacere del vivere.